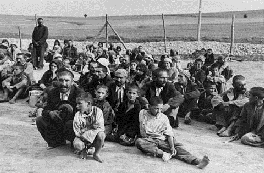“nella gioia dell’evangelo”

carissimo Papa Francesco, immaginiamo l’ingombro delle lettere sulla tua scrivania. E come non pensare che sarebbe pretesa che la nostra fosse letta e le fosse data risposta? Anche perché viene da un piccolo gruppo – composto da laici, presbiteri, religiosi – che non può vantare altro che la sua passione e la sua piccolezza
Innanzitutto vorremmo ringraziarti e poi vorremmo condividere brevemente con te qualche pensiero. Ringraziarti perché in te, nelle tue parole e nei tuoi gesti, questo piccolo gruppo si è sentito come interpretato. Alle nostre origini ci eravamo chiamati “Il vangelo che abbiamo ricevuto”. Convenivamo da varie parti d’Italia. Il piccolo gruppo milanese denominandosi anche “Laboratorio di sinodalità laicale” sottolineava una dimensione che ci sta a cuore. Ora che sei venuto tra noi, ci siamo dati un nome a te caro: “Nella gioia dell’evangelo”. Portavamo e in parte ancora portiamo nel cuore la sofferenza per il rischio di un evangelo ridotto a codice di comportamento morale, mentre esso è soprattutto l’annuncio dell’amore del Padre, quale nella forza dello Spirito si è manifestato e reso disponibile a tutti nella vita umana e profetica di Gesù, il galileo di Nazareth. Siamo infatti convinti che solo restando dentro tutta l’ampiezza e la profondità dell’evangelo, è possibile parlare a noi stessi, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle dentro e fuori della chiesa visibile, per sperimentare assieme a tutti la potenza liberante dell’evangelo. Nella tua voce abbiamo riascoltato con insistenza queste parole: evangelo, gioia, sinodalità. Abbiamo colto dalle tue parole e dai tuoi gesti uno sguardo diverso sul magistero del vescovo di Roma.
Ti poni come colui che si mette nella compagnia del suo popolo indicando in modo semplice orizzonti evangelici verso cui camminare insieme. Stai di fatto incoraggiando tutta la chiesa, con le sue strutture, a uscire dal ripiegamento su sé stessa, nella convinzione che solo “uscendo e rischiando” essa fa esperienza dell’evangelo che è chiamata ad annunciare.
A partire dal giorno della tua elezione, nel quale hai chiesto al popolo di invocare su di te la benedizione di Dio, tu hai dato valore alla reciprocità tra pastori e gregge loro affidato, all’olfatto del popolo di Dio, alla sua “infallibilità” nel credere, alla partecipazione e responsabilità di tutti i battezzati nella sfida dell’evangelizzazione. In questa prospettiva attendiamo che i molti carismi, che lo Spirito dona a battezzati e battezzate, e le molte diaconie, che questi esercitano nella chiesa e nel mondo, trovino adeguato riconoscimento nell’ordinamento e nella prassi ecclesiale. L’istituzione di una commissione chiamata a studiare la questione del conferimento del diaconato alle donne è senza dubbio una grande apertura di un nuovo orizzonte. Ma, al di là di questa specifica questione,
auspichiamo un globale ripensamento della visione del ministero, che nella storia ha conosciuto diverse variazioni. Infatti l’intera comunità ecclesiale è chiamata all’unico ministero di annunciare il Signore, lottando per la liberazione e integrità del creato e di ogni persona umana, a cominciare dagli scartati e ultimi della terra. Pertanto ci sembra urgente che le varie forme di ministero, lontane dal configurarsi come posizioni di potere, siano concepite e vissute nella chiesa e dalla chiesa, nello splendore della gratuità evangelica, a servizio del Regno e quindi di una umanità in cammino
Forte di questa convinzione ogni ministero che presiede alla comunione sentirà come irrinunciabile il richiamo ad essere disponibile all’ascolto, il richiamo al discernimento come dono dello Spirito e come frutto di cammini autenticamente sinodali, che sappiano coinvolgere le componenti laicali che oggi, a mezzo secolo dal concilio, restano ancora emarginate. Viviamo con sofferenza la sensazione di uno scollamento tra il messaggio che le tue parole custodiscono e la coscienza di parte della chiesa. Certamente è questione di semine lunghe e ci è chiesta la pazienza del contadino del vangelo. Ma ci sembra di ravvisare tentativi di contrastare l’evangelo sia nell’indisponibilità di alcuni vertici ecclesiali, sia nelle reazioni di un certo numero, non trascurabile, di fedeli che sembrano impermeabili al tuo annuncio.
Ci chiediamo a volte come si possa partecipare alle assemblee liturgiche e poi assumere posizioni, coscientemente o no, opposte all’evangelo. Come ricucire la frattura? In tempi in cui ci si affida a slogan ci parrebbe opportuno puntare su un appello al “pensare”, a “esporsi al contatto” con il mondo, favorendo in ogni realtà ecclesiale, a partire dalle parrocchie, esperienze in cui “vedere, giudicare, agire, accompagnare”, come ci sembra tu abbia suggerito a Firenze
Luoghi e tempi non elitari, in stretta relazione con il popolo di Dio che vive fatiche e speranze della vita quotidiana, illuminata dalla gioia dell’evangelo. Tu spesso ci hai invitato a sognare. Ti abbiamo raccontato sogni. Nella fiducia di condividerne altri con te in un prossimo futuro. In comunione di preghiera
il gruppo NELLA GIOIA DELL’EVANGELO
Maria Cristina BARTOLOMEI, Milano;
Ugo Francesco BASSO, Milano;
Marco BERTÈ, Parma;
Gianfranco BOTTONI, Milano;
Massimo CADAMURO, Venezia;
Angelo CASATI, Milano;
Francesco CASTELLI, Milano;
Ursicin Gion Gieli DERUNGS, Milano;
Italo DE SANDRE, Padova;
Luciano GUERZONI, Modena;
Licinia MAGRINI, Bologna;
Giancarlo MARTINI, Verbania;
Giovanni NICOLINI, Bologna;
Enrico PEYRETTI, Torino;
Ugo Gianni ROSENBERG, Torino;
Francesco SCIMÈ, Bologna;
Carlo URBANI, Venezia;




 Sono stati tra i primi a unirsi civilmente, lo scorso 6 agosto, la loro è stata una corsa contro il tempo prima che la malattia avesse la meglio. E sono diventati un simbolo, fuori dagli stereotipi. La coppia, molto credente, andata a Lourdes in viaggio di nozze, ha scritto una lettera a Papa Francesco, con una domanda molto chiara: «Dopo esserci scambiati amore e sostegno, dopo aver condotto una vita a due, siamo una famiglia?». Franco, con un passato da seminarista, scriveva: «Non ce la facciamo più a sentirci fuori dalla Chiesa, io faccio la comunione da sempre, perché mi sento di farla». Per don Carrega, «la Chiesa deve farsi un serio esame di coscienza. A partire da alcune voci autorevoli che sembrano più preoccupate dei valori che delle persone. Anche nell’ultimo sinodo dei vescovi ci sono cardinali che hanno detto che da un’unione gay non può nascere nulla di buono. Frasi gratuite, non comprovate da nessun fatto oggettivo, categorie trite e ritrite». Don Carrega al contrario ha paragonato la coppia ai due discepoli di Emmaus, passo del Vangelo che ha scelto per la Messa. «I due discepoli discutevano tra loro, come in vita hanno fatto loro come coppia, con Gesù accanto come compagno di viaggio». E anche sul sesso in teoria vietato alle coppie gay credenti, chiamate alla castità, don Carrega ha qualcosa da dire. «Parlando dei divorziati risposati a proposito della castità, Papa Francesco ha detto che bisogna valutare caso per caso. Così anche per i gay bisognerebbe evitare giudizi universali e irrevocabili». Non si spinge, don Carrega, oltre: «Questo non significa automaticamente benedire le coppie gay, ma bisogna mettersi in un ascolto». Ma il tema è ormai non più demandabile: «Fortunatamente le coppie unite civilmente aumenteranno: le parrocchie devono relazionarsi a loro, non possono ignorarle». A salutare Franco amici, parenti, istituzioni. Marco Giusta, assessore del Comune, ha detto: «Gianni potrà dire che Franco era suo marito».
Sono stati tra i primi a unirsi civilmente, lo scorso 6 agosto, la loro è stata una corsa contro il tempo prima che la malattia avesse la meglio. E sono diventati un simbolo, fuori dagli stereotipi. La coppia, molto credente, andata a Lourdes in viaggio di nozze, ha scritto una lettera a Papa Francesco, con una domanda molto chiara: «Dopo esserci scambiati amore e sostegno, dopo aver condotto una vita a due, siamo una famiglia?». Franco, con un passato da seminarista, scriveva: «Non ce la facciamo più a sentirci fuori dalla Chiesa, io faccio la comunione da sempre, perché mi sento di farla». Per don Carrega, «la Chiesa deve farsi un serio esame di coscienza. A partire da alcune voci autorevoli che sembrano più preoccupate dei valori che delle persone. Anche nell’ultimo sinodo dei vescovi ci sono cardinali che hanno detto che da un’unione gay non può nascere nulla di buono. Frasi gratuite, non comprovate da nessun fatto oggettivo, categorie trite e ritrite». Don Carrega al contrario ha paragonato la coppia ai due discepoli di Emmaus, passo del Vangelo che ha scelto per la Messa. «I due discepoli discutevano tra loro, come in vita hanno fatto loro come coppia, con Gesù accanto come compagno di viaggio». E anche sul sesso in teoria vietato alle coppie gay credenti, chiamate alla castità, don Carrega ha qualcosa da dire. «Parlando dei divorziati risposati a proposito della castità, Papa Francesco ha detto che bisogna valutare caso per caso. Così anche per i gay bisognerebbe evitare giudizi universali e irrevocabili». Non si spinge, don Carrega, oltre: «Questo non significa automaticamente benedire le coppie gay, ma bisogna mettersi in un ascolto». Ma il tema è ormai non più demandabile: «Fortunatamente le coppie unite civilmente aumenteranno: le parrocchie devono relazionarsi a loro, non possono ignorarle». A salutare Franco amici, parenti, istituzioni. Marco Giusta, assessore del Comune, ha detto: «Gianni potrà dire che Franco era suo marito».