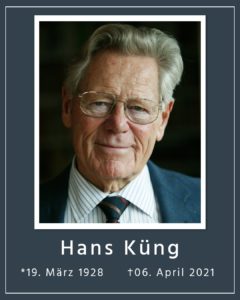IN ONORE DI CARLO MOLARI, DEL SUO PENSIERO, DELLA SUA VITA
relazione tenuta a Bologna nel luglio 2018 in occasione del novantesimo compleanno di Carlo Molari e alla sua presenza
1. Un teologo convertito
A metà degli anni Ottanta la casa editrice Marietti richiese a dieci teologi italiani una testimonianza sul loro essere teologi in vista di un volume che poi pubblicò con il titolo Essere teologi oggi. Dieci storie. Tra questi teologi vi era Carlo Molari che iniziò il suo intervento così: “Fare teologia non è un mestiere o un semplice servizio reso agli altri, ma è un modo concreto di vivere la fede ecclesiale, è uno stile di vita, e per me, oggi, è componente di identità personale, ragione di tutta la mia storia”.
È bello per me oggi, bello di quella bellezza un po’ solenne che hanno sempre le celebrazioni, tenere un discorso in onore di Carlo Molari, ovvero della sua teologia e della sua vita, perché in lui le due dimensioni, come scrisse egli stesso 32 anni fa, sono venute a coincidere: per lui fare teologia è stata ed è la ragione di tutta la sua storia. Vorrei anzi dire che egli non si è limitato a fare teologia, ma è arrivato a essere teologia; non si è limitato cioè a essere un teologo nel senso di un professionista della dottrina dell’istituzione Chiesa cattolica; ma è arrivato a essere egli stesso teo-logia, cioè “parola o discorso su Dio”, “parola o discorso di Dio”, “logos-legame linguistico con Dio”. Questa identità di fare e di essere teologia è la medesima che si ritrova nelle grandi figure della storia teologica, tra cui menziono un solo nome che è impossibile non fare parlando di Molari, quello di Pierre Teilhard de Chardin.
Molari scelse di intitolare la testimonianza richiestagli dalla Marietti Conversioni di un teologo. Scelse cioè di descrivere il suo essere teologo all’insegna di tre passaggi non previsti dalla sua condizione iniziale di teologo ufficiale della Chiesa cattolica. Egli avrebbe potuto non convertirsi e rimanere nel binario assegnatogli, e sicuramente il suo viaggio lungo la carriera ecclesiastica l’avrebbe portato molto in alto: e in questo momento a celebrare i suoi novant’anni ci sarebbe qualcun altro al posto mio e forse anche al posto vostro. Ma Molari si convertì, per la precisione si convertì tre volte, e in queste sue tre conversioni consiste il nucleo pulsante della sua teologia e, ancora più profondamente, della sua umanità. Esse gli hanno impedito di diventare cardinale (a meno di ulteriori sorprese, qualche volta i teologi diventano cardinali all’ultimo momento), ma l’hanno reso un uomo vero, sincero, libero, liberante, e un teologo dal pensiero coraggioso, profondo e cristallino. Perché una cosa è chiara al primo sguardo: incontrare la teologia di Molari significa incontrare la libertà, quella libertà esigente che ti pone di fronte alla verità di te stesso. Nella prefazione a un volume del 1972, La fede e il suo linguaggio (in cui sono raccolti i suoi saggi pioneristici sul rapporto tra la fede e la sua espressione verbale), Molari fa della sincerità la condizione di verità della teologia: “Le riflessioni sul mistero dell’esistenza, come sono i saggi teologici, non si possono fare senza essere sinceri… per questo ogni libro di teologia è una specie di confessione”. Molari è sincero e invita chiunque lo incontra alla sincerità e quindi alla conversione. Ma quali sono le sue tre conversioni?
2. Le tre conversioni
Si potrebbe parlare di esse come di una conversione filosofica, di una conversione teologica e di una conversione spirituale. Nel contributo sul suo essere teologo Molari le descrive così:
1) la conversione alla cultura contemporanea; più in particolare si trattò della scoperta della prospettiva evolutiva nell’interpretazione della natura e della svolta linguistica nell’interpretazione della cultura; una conversione che definisco filosofica;
2) la conversione al nuovo modo di fare teologia applicando all’ambito teologico le prospettive apprese dalla cultura contemporanea; una conversione teologica che portò Molari a essere processato dal Sant’Uffizio tra il 1974 e il 1977 ricevendo infine il monito di non esporre più le sue idee e venendo sollevato dall’insegnamento nelle università pontificie romane; il che lo portò il 14 febbraio 1978, all’età di 50 anni, a chiedere e a ottenere la pensione (il che significa che è da 40 anni che tu Carlo pesi sulle casse dello Stato pontificio!);
– 3) la conversione dovuta all’incontro, non libresco ma vivo ed esperienziale, con le altre religioni; una conversione che definisco spirituale.
3. La prima conversione: al nostro tempo
Questa prima conversione consiste nell’intendere la cultura contemporanea non più come un nemico da cui difendersi e da conoscere solo per smontarlo apologeticamente, secondo quanto gli era stato insegnato durante gli anni della formazione, ma come fonte da cui apprendere insegnamenti sulla vita, il mondo, la storia. La cultura contemporanea viene accostata secondo un’autentica funzione costruttiva e le questioni teologiche vengono pensate al suo interno. Molari acquisisce dalla cultura contemporanea in particolare due grandi orizzonti: la prospettiva evolutiva e la svolta linguistica.
– Per quanto riguarda la prima, si tratta della visione dinamica secondo cui la perfezione non è più pensata come inizio, ma come fine del processo evolutivo. La creazione in questa prospettiva non è ancora finita ma continua. Molari ama ripetere che “la forza creatrice non ha ancora espresso tutta la sua possibile perfezione”. Ne viene che il tempo assume una valenza straordinaria: “Esso non è il luogo dove le cose accadono, ma una struttura intima delle cose” (Per una spiritualità adulta, Cittadella 2007, pp. 9-10).
E di conseguenza muta anche la visione dello spazio: il mondo non è più un insieme di cose e di individui già strutturati, ma un sistema di aggregati che si trasformano in continuazione. La categoria decisiva diviene quindi, ben prima di quella di sostanza che da Aristotele in poi ha costituito la modalità decisiva di vedere il mondo, la categoria di relazione: “La vita è relazione… Prima viene la relazione, poi viene la nostra individualità che cresce attraverso i rapporti. Spesso pensiamo che prima diventiamo persone o siamo individui e poi stabiliamo le relazioni, invece è vero il contrario: prima c’è la relazione entro la quale noi sorgiamo come individui” (Il difficile cammino della fede, Oreundici, p. 38).
– Per quanto riguarda la svolta linguistica, Molari giunge alla convinzione che “il linguaggio rispecchia più l’uomo che parla che le cose di cui parla” (Per una spiritualità adulta, 23), che il linguaggio cioè è un’invenzione umana per tradurre l’esperienza della realtà. Il che presenta grandi ripercussioni per una religione come il cristianesimo che ha tra le fonti della sua rivelazione un libro e che richiede verbali professioni di fede. Ma Molari è conseguente: “Non esiste un linguaggio divino insegnato agli uomini. Tutte le parole nascono da esperienze umane e sono invenzioni umane” (La svolta linguistica e la teologia, l’altrapagina 2013, p. 12).
Da qui una precisa idea sulla Bibbia: “In senso proprio la Scrittura non è parola di Dio, è la trascrizione di tradizioni relative a eventi vissuti nell’atteggiamento di accoglienza dell’azione di Dio” (Il difficile cammino della fede, Oreundici, p. 28). E da qui un’idea altrettanto precisa sulle formule della tradizione ecclesiastica: “Le formule della fede non trasmettono nozioni o parole divine e neppure verità trascendenti; nascono da esperienze” (La svolta linguistica e la teologia, p. 25).
Da qui la seconda conversione, quella al nuovo modo di fare teologia, diviene inevitabile.
4. La seconda conversione: al nuovo modo di fare teologia
Molari elenca i temi che sempre più presero a occupare il suo interesse di teologo: “la secolarizzazione, l’incidenza in teologia della coscienza storica, le conseguenze del nuovo concetto di rivelazione, il ripensamento del metodo teologico, la riacquisizione della teologia negativa con il superamento dell’antropomorfismo, la correzione del neocalcedonesimo cristologico, la revisione dell’antropologia e l’adattamento dei modelli pastorali” (Essere teologi oggi, pp. 108-109). Ovviamente è impossibile esporre la sua teologia riguardo a tutti questi temi, quindi io mi limiterò a quelli essenziali per ogni elaborazione teologica cristiana, cioè Dio e Cristo.
1. Dio
Coerentemente con l’affermazione secondo cui “il linguaggio rispecchia più l’uomo che parla che le cose di cui parla”, per Molari parlare di Dio significa parlare della nostra esperienza al riguardo. Ecco come egli spiega il fondamento esistenziale delle affermazioni teologiche: “Noi non esprimiamo Dio, ma quello che sentiamo di Lui, la sua azione creatrice in noi. Avvertiamo che in noi è in azione una forza più grande di noi. Ogni volta che pensiamo, avvertiamo che la Verità in azione nella nostra mente è più profonda delle nostre idee; ogni volta che amiamo, ci rendiamo conto che il Bene che ci attira supera quello che noi possiamo offrire; ogni volta che progettiamo la giustizia, sappiamo di non poter mai realizzare pienamente la Giustizia… questa è l’esperienza della trascendenza che noi chiamiamo Dio” (Per una spiritualità adulta, p. 44).
L’esperienza della trascendenza si dà non in speciali e misteriose rivelazioni, ma nelle più alte e insieme più comuni esperienze umane: la Verità, il Bene, la Giustizia. Fare esperienza di trascendenza significa prendere coscienza “di non essere la sorgente, il centro di se stesso, ma di essere inserito in un processo più grande, attraversato da un’energia più profonda… L’uomo spirituale afferma: Non sono io a pensare, ma è il pensiero che in me cerca di esprimersi; non sono io ad amare, ma è il bene che in me cerca di diventare amore” (Per una spiritualità adulta, p. 84; cfr. anche p. 129).
Molari parla ripetutamente di Dio come forza creatrice, ma in linea con la teologia negativa sa prendere le distanze anche da questa espressione: “Noi non sappiamo cos’è Dio; io so che quando parlo di Dio come forza creatrice, metto in gioco una componente che non corrisponde alla realtà, ma so che oggi è il modo con cui io posso vivere l’esperienza di fede e posso esprimerla coerentemente” (Il difficile cammino della fede, Oreundici, p. 30).
L’apofatismo riguarda non solo l’essenza di Dio, ma anche il suo agire, al cui proposito Molari è chiarissimo nell’affermare che non esiste nulla nel mondo creato che possa essere interpretato come diretta azione divina che opera del tutto a prescindere dalle creature. E cita Teilhard de Chardin: “Dio, propriamente parlando, non fa le cose, ma fa che le cose si facciano” (Per una spiritualità adulta, p. 47). Secondo Molari l’azione di Dio non aggiunge qualcosa, ma immette nella creatura un’energia conducendola a esprimere in se stessa la perfezione cui è destinata.
Ne viene quanto segue: “Dobbiamo essere radicali… dobbiamo eliminare ogni ambito riservato a una sua azione che non si esprima nelle creature” (Il difficile cammino della fede, Oreundici 2013, p. 23). Ancora: “Dobbiamo evitare richiami a interventi soprannaturali o ad azioni riservate di Dio” (ivi). Nessun evento della creazione e della storia va attribuito a Dio, perché Dio non fa nessuna cosa nella creazione e nella storia: “Tutto ciò che nella storia emerge e viene realizzato, tutto avviene attraverso creature” (Id., p. 25).
Non è che Dio non agisca, il Dio di Molari non ha nulla a che fare con il Deus otiosus del deismo; ma l’azione di Dio consiste nel conferire la condizione di possibilità dell’azione delle creature: “Nell’interpretazione di chi crede in Dio tutto ciò che accade è sostenuto e alimentato da una forza più grande, ma tutto avviene sempre attraverso dinamiche che hanno una loro struttura interna” (Id., p. 36).
Ciò che vale per la creazione, vale esattamente allo stesso modo per la rivelazione: “Non ci sono dottrine rivelate da Dio, perché noi non possiamo conoscere il pensiero di Dio. Ciò che di Dio conosciamo, lo apprendiamo attraverso l’esperienza di fede” (Il difficile cammino della fede, Oreundici, p. 26).
2. Gesù
Fin dal dibattito sull’io di Cristo (sulla sua fede, sulla sua conoscenza, sulla sua coscienza) che ebbe luogo a Roma tra Pietro Parente e Paul Galtier tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50, il pensiero cristologico di Molari si può definire come un cammino verso la coerenza nel pensare la piena umanità di Cristo. Egli partì da una cristologia da lui definita dotata di “tratti chiaramente cripto-monofisisti” (Essere teologi oggi, p. 102), secondo la quale l’anima di Gesù Cristo godeva da subito di scienza infusa e di visione beatifica (cfr. Per una spiritualità, p. 159). Al contrario Molari, in linea con la prospettiva evolutiva, ritiene che “l’incarnazione umana del Logos continua fino a Pasqua”, e che “Gesù è diventato figlio di Dio a poco a poco” (Per una spiritualità, 160).
Anche sulla redenzione il lavoro di Molari è fortemente innovativo. Egli parla al riguardo di due pregiudizi da eliminare: 1) “che Gesù sapesse fin dall’inizio che sarebbe morto in modo violento; 2) che tale morte fosse parte di un decreto divino, fosse cioè necessaria alla salvezza”. Riguardo a queste due idee molto diffuse nel cristianesimo del passato e del presente, Molari afferma che si tratta di “pregiudizi non fondati nella Scrittura” (Per una spiritualità, p. 168).
Da qui la reinterpretazione innovativa dei concetti soteriologici di espiazione e di soddisfazione, e il passaggio dalla prospettiva ascendente secondo cui Gesù salva perché ha offerto una riparazione a Dio, alla prospettiva discendente secondo cui Gesù salva perché ha offerto da parte di Dio la forza dello Spirito (cfr. Per una spiritualità, p. 173).
Per Molari la mediazione di Cristo va intesa in senso discendente, nel senso che è Dio, per mezzo dell’uomo Gesù, che agisce (cfr. Teologia del pluralismo religioso, p. 119).
5. La terza conversione: alla pluralità delle religioni
Prendere sul serio l’esistenza delle altre religioni significa pensarle ex parte Dei, come effetti a loro volta di quella forza creatrice in cui consiste l’azione divina. Questo però fa nascere una serie di problemi teologici che Molari elenca così: “la natura della fede salvifica; il significato assoluto di Cristo come Messia; i criteri dell’inculturazione; la convergenza di tutte le religioni per la realizzazione della giustizia e della pace nel mondo” (Essere teologi oggi, p. 123).
Il suo punto di vista consiste nel ritenere che l’assolutezza del cristianesimo non riguarda il cristianesimo, ma i valori per i quali Gesù è vissuto ed è morto. La sua rivelazione “è nella storia ed è perciò accessibile a tutti, anche se non entrano nella Chiesa o non si riferiscono al Gesù storico” (Essere teologi oggi, 123).
Questa impostazione comporta il superamento non solo dell’ecclesiocentrismo con il classico assioma extra ecclesiam nulla salus, ma anche del cristocentrismo; più precisamente, di quella prospettiva che fa dipendere la salvezza dalla sequela del Gesù dei Vangeli e dalla partecipazione alla sua passione, morte e risurrezione. Per Molari, alla luce del fatto che “il Nome di Dio è ineffabile” e quindi “si esprime sempre e solo storicamente e quindi in forma limitata (Id., p. 104), “è innegabile che l’attività di Gesù ha avuto dei limiti culturali e storici” (Teologia del pluralismo religioso, Pazzini, Rimini 2013, p. 96).
Il passaggio centrale della sua cristologia, al contempo base della sua teologia del pluralismo religioso, consiste nel distinguere il Gesù storico dal Verbo eterno. Si tratta cioè di considerare che il Gesù storico non esaurisce e non può strutturalmente esaurire (proprio per la sua storicità) la ricchezza ontologica del Verbo eterno. Per questo Molari afferma quindi una “eccedenza rivelativa e salvifica del Verbo eterno rispetto a Gesù Cristo” (Teologia del pluralismo religioso, p. 121).
E Gesù? Gesù è “la cifra storica per individuare altri nomi umani, un criterio assoluto per interpretare le altre traduzioni del Nome ineffabile” (Id., 104). La funzione di Gesù è di essere “un criterio unico per rintracciare il vero e il giusto che si trova nelle altre rivelazioni storiche di Dio” (Id., 139-140).
Muta ovviamente anche il compito della Chiesa: non più convertire tutti al cristianesimo, ma “testimoniare i valori annunciati da Gesù in modo che tutti accolgano il progetto di Dio e diventino uomini autentici” (Essere teologi oggi, 123).
Le religioni quindi si devono convertire, ponendosi al servizio di qualcosa di più importante di loro, qualcosa che le scavalca e che le contiene. L’umanità del XXI secolo si salverà dal nichilismo e dalla globalizzazione uniformante solo se le tradizioni spirituali sapranno ritrovare questa prospettiva più ampia all’insegna non certo del relativismo quanto piuttosto della relatività e della relazione tra tutte le strade.
6. Maestro di vita
Ma, come ho detto all’inizio, Molari non si è limitato a fare teologia, è piuttosto arrivato a essere teologia. Va detto cioè che il frutto più maturo delle sue tre conversioni riguarda non la teologia, ma la sua umanità; non il teologo, ma l’uomo. Occorre quindi parlare di lui come di un maestro di spiritualità.
Molari sostiene la presenza nel nostro tempo di una forte domanda di spiritualità: “Tutti dobbiamo diventare mistici. Oggi è un’esigenza, questa” (Per una spiritualità, p. 136). Per lui la spiritualità nasce quando si sente di essere “ambiti di una Realtà più grande”, e questo “vale per tutte le religioni” (Per una spiritualità, p. 136).
Specifica poi che “la spiritualità di cui oggi c’è bisogno è una spiritualità della relazione, vale a dire il passaggio dalla spiritualità dell’essere a quella della relazione” (Per una spiritualità, p. 136). Ma per quanto insista sulla spiritualità della relazione, Molari presenta quelle che a mio avviso sono le sue pagine spirituali più intense quando giunge a parlare della solitudine e del raccoglimento in se stesso dell’essere umano. In questo la sua proposta spirituale può essere intesa come un’interpretazione della più bella definizione di religione che io conosca, quella del matematico e filosofo Alfred Whitehead: “Religione è ciò che l’individuo fa della propria solitudine” (Religion in the Making).
Il cammino dell’uomo conduce necessariamente alla vecchiaia e alla morte e il compito della spiritualità è di prendere sul serio questo orizzonte facendo scaturire da esso una proposta di vita. Molari lo fa scrivendo quanto segue: “Invecchiare esige la capacità di fare progressivamente a meno di tutti i riferimenti di identificazione, per essere semplicemente se stessi… La morte ci chiederà di avere acquisito in modo così completo e definitivo il proprio nome, da saperlo abitare senza necessità di altri riferimenti” (Per una spiritualità, p. 85). Mi sembra di risentire le parole con cui Ernesto Balducci nel 1985 concludeva L’Uomo planetario: “Chi ancora si professa ateo, o marxista, o laico e ha bisogno di un cristiano per completare la serie delle rappresentanze sul proscenio della cultura, non mi cerchi. Io non sono che un uomo”.
Molari parla della morte come del “criterio supremo della vita”. Secondo lui “noi siamo in questa fase di esistenza per diventare capaci di uscirne… siamo in una situazione che è destinata a finire”. Quindi ecco il criterio decisivo: “Ciò che nella vita ci consente di finire bene è giusto, ciò che ci impedisce di morire bene è male” (Per una spiritualità, p. 110).
Dalla considerazione della morte in quanto traguardo del nostro essere Molari fa discendere cinque criteri della vita autentica: “La morte chiederà a tutti: 1) di avere consolidato la propria identità al punto da saperne abitare il nome senza ricorrere ad altri riferimenti; 2) di avere imparato il distacco da tutte le cose; 3) di avere interiorizzato così gli altri da sapere partire senza tenere nessuno per mano; 4) di avere imparato ad amare in modo così oblativo da saper donare se stessi senza rimpianti; 5) di avere imparato a fidarsi così della vita da saperla perdere per ritrovarla” (Per una spiritualità, p. 111).
Più avanti riassume i 5 criteri così: 1) identità definitiva; 2) distacco dalle cose e dalle persone; 3) interiorizzare le persone per partire in solitudine; 3) amare fino all’oblatività radicale; 5) fiducia nella vita.
7. Conclusione
Desidero concludere leggendo una preghiera di Carlo Molari che a mio avviso riassume bene la sua teologia e la sua spiritualità. Ma desidero introdurla con le parole che tu Carlo dedichi a tuo padre: “Mio padre era tornitore meccanico e adorava il suo lavoro. Ricordo ancora il suo volto, mentre a stento tratteneva le lacrime, quando nel 1944 i tedeschi ridussero in frantumi il suo tornio, che egli ricompose dopo il passaggio del fronte pezzo per pezzo. Ma era soprattutto un fervido credente. La sua pratica religiosa era costante e serena. Alla sua testimonianza, credo, debbo la decisione di diventare sacerdote” (Essere teologi oggi, p. 98). È bello pensare che la preghiera del teologo Molari che ora vi leggo affondi le radici nelle preghiere del Molari tornitore meccanico:
“Io che il mio cammino è sostenuto e alimentato da un amore grande, da una forza che non posso accogliere completamente in poco tempo ma solo passo dopo passo, lungo tutto il tragitto verso il compimento, per cui mi affido, apro il mio cuore, senza riserve. Io non so, ma Tu sai, io non posso, ma Tu puoi alimentare il mio sviluppo, posso diventare capace di attraversare ogni situazione e viverla in modo positivo. Io debbo diventare vivo, non c’è nessuno che mi può sostituire in questo compito; divento attraverso ogni gesto che compio, ogni pensiero che sviluppo, ogni rapporto che intrattengo, per cui sono consapevole della grande responsabilità che ho di fronte a Te e di fronte al mondo” (In cammino verso la Pasqua, p. 41).
Vito Mancuso, Bologna 19 settembre 2018
.jpg?width=1024)