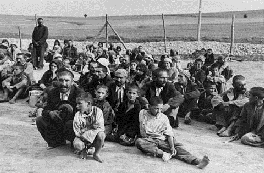Clicca qui per leggere l’introduzione di Adista al documento

I soldati che hanno rotto il silenzio non lo hanno fatto senza pensarci. L’atto di rompere il silenzio non è fatto per lavarsi la coscienza o per alleviare i sintomi post-traumatici di coloro che sono stati spediti a rafforzare un regime militare (anche se questo può essere un effetto collaterale).
L’atto di rompere il silenzio non è piacevole. Rompere il silenzio è spaventoso; ti fa perdere il sonno. Lo scopo di questo atto è il cambiamento radicale della situazione politica; non in modo cosmetico, ma dalle fondamenta, andando alle radici.
Rompere il silenzio vuol dire prendere una posizione morale e personale contro una situazione che è inaccettabile da cima a fondo, nella sua totalità. Rompere il silenzio significa anche assumersi la responsabilità delle proprie azioni ed essere personalmente pronti a pagarne il prezzo.
Noi rompiamo il silenzio per protestare contro l’occupazione. Il nostro gesto è un grido per dire che il controllo militare, in atto da decenni, su milioni di persone – i palestinesi – è inaccettabile. Per dire che l’occupazione non è qualcosa che può o deve essere normalizzata o “aggiustata”: è solo qualcosa cui va posto fine. Perché, anche se esiste da decenni, non ha il diritto di esistere. Rompere il silenzio vuol dire sfidare qualcosa che, da quasi 50 anni, è diventata parte di noi e della nostra identità.
L’amministrazione dell’Università Ben Gurion ha detto che la decisione di cancellare il premio conferito a Breaking the Silence si basava sul fatto che la nostra organizzazione è fuori dal consenso politico.
Dal giorno in cui è stata fondata, Breaking the Silence non ha mai fatto parte del consenso nazionale. Al contrario, l’atto di rompere il silenzio significa dichiarare pubblicamente che si è contro il consenso.
Non facciamo confusione: consenso vuol dire occupazione. I soldati che hanno rotto il silenzio lo hanno fatto per porre fine all’occupazione. Loro, noi, stiamo cercando di contestare il sistema, di smontare il suo meccanismo, di sabotarlo. Rompono il silenzio per denunciare cosa significa occupare un altro popolo. E non lo fanno in maniera teorica, come fosse una ricerca storica, non lo fanno da lontano: sono stati lì. E ora ci mostrano l’ingiustizia insita nell’attuazione di questa politica crudele. E sono pronti a pagare di persona per questo gesto.
Rompere il silenzio è un diritto che ogni cittadino ha in democrazia, per contestare l’opinione predominante. Per sfidarla e gridare forte e chiaro che ciò che ci hanno fatto credere è un mucchio di fandonie, è una menzogna, un’illusione. È una politica orribile che serve solo a una piccolissima parte della società israeliana: la destra colonialista e messianica e i suoi rappresentanti in Parlamento.
Quindi, in effetti, la professoressa Carmi, il professor HaCohen e gli altri membri dell’amministrazione che hanno scelto l’argomento del consenso non ci hanno rivelato niente di nuovo. Hanno ragione. Noi siamo, orgogliosamente, fuori dal consenso.
I soldati che si avvicinano a Breaking the Silence per offrire le loro testimonianze circa ciò che succede nei Territori si stanno liberando – consapevolmente e intenzionalmente – dal caldo e confortevole abbraccio del consenso. Ognuno di loro rompe il silenzio per prendere le distanze dall’opinione dominante. Uno dopo l’altro, testimonianza dopo testimonianza, hanno creato una banca dati fatta di migliaia di storie che, negli ultimi 12 anni, ha rivelato i pericoli del consenso. Alla luce della reazione isterica e violenta che il nostro atto ha scatenato, possiamo dedurne che è altamente efficace.
Breaking the Silence farà parte del consenso il giorno in cui vinceremo, il giorno in cui finirà l’occupazione e inizierà un processo di ricostruzione e riconciliazione. Fino ad allora, non abbiamo alcun interesse a far parte del consenso. Non perché vogliamo essere dispettosi, ma perché non abbiamo altra scelta.
L’occupazione, questo regime distruttivo, da 50 anni impedisce a Israele di essere una vera democrazia e sta rapidamente diventando il nucleo della nostra identità. Questo vuol dire che sempre più israeliani stanno diventando servi di questo regime di occupazione. Sempre più persone, di ogni estrazione sociale, sono costrette a essere parte attiva nel mantenimento e nel sostegno del sistema, soprattutto per coprire le crepe che si stanno aprendo. Nel corso dell’ultimo anno, sono stato testimone di questo orribile processo più e più volte.
In questo senso, la prof. Carmi è sulla stessa lunghezza d’onda di un mucchio di persone indegne, come Yair Lapid, che ha attaccato Breaking the Silence per guadagnare consenso. Al suo fianco ci sono i membri del suo partito che lo criticano dietro le quinte, ma tacciono in pubblico. E gli stessi politici che una volta guidavano la lotta contro l’occupazione non dicono una parola di fronte all’ostilità e alla violenza manifestate contro di noi; alcuni politici mi hanno detto, con le lacrime agli occhi, che “il sostegno a Breaking the Silence gli costerebbe le primarie”.
La lista di queste “nobili persone” che preferiscono tenere per sé la loro contrarietà all’occupazione perché il prezzo da pagare sarebbe troppo alto si allunga sempre più.
Ed è vero: ospitare una conferenza o assegnare un premio a dei soldati che si sono apertamente schierati contro l’occupazione, in Israele, nel 2016, è un atto di coraggio, non è una cosa scontata. È un gesto che ha un prezzo. Non c’è bisogno che qualcuno mi spieghi qual è il prezzo da pagare per essersi opposti al consenso. Ma il pericolo sta proprio in questo.
Carmi non ha solo ritirato il premio a Breaking the Silence, ma – forse senza volerlo, forse senza pensarci troppo – ha contribuito a rafforzare il consenso che ci etichetta come traditori e spie. Dopo tutto, se non fossimo dei traditori, il premio non ci sarebbe stato tolto. La vera tragedia è questa: Carmi non ha ritirato il premio perché sostiene l’occupazione (anche se non so proprio cosa sostiene). E non penso che detesti Breaking the Silence (in realtà non ci conosce). Ha solo avuto paura.
Carmi ha ceduto di fronte al populismo sensazionalista e violento del governo dell’occupazione e del consenso. Ha accettato le regole anti-democratiche del gioco. Ha introiettato quello che i leader del consenso chiedono a tutti noi: non opponetevi. Non offrite tribune a chi si oppone alla politica del governo. Non intralciate l’occupazione e la colonizzazione. E, soprattutto, non minate il nostro straordinario successo nel trasformare l’occupazione nel consenso nazionale.
Adesso possiamo e dobbiamo dire la verità: coloro che permettono che l’occupazione dei territori palestinesi continui da ormai quasi 50 anni, e che questa sia diventata il consenso nazionale, non sono i coloni o i loro rappresentanti in Parlamento. E non è nemmeno il primo ministro. Sono coloro che permettono all’occupazione di prosperare. Sono coloro che non sono favorevoli ma che ciononostante rimangono in silenzio. Coloro che sanno che mette in pericolo il futuro di Israele, ma non vi si ribellano. Coloro che riconoscono che l’occupazione contraddice e mina la democrazia israeliana, ma scelgono ancora e ancora di rimanere nel consenso.
Detto questo, vorrei ringraziare la prof. Carmi e l’amministrazione dell’Università: grazie alla vostra decisione, il premio è diventato ancora più prezioso. Ha acquistato grande valore perché negli ultimi mesi ha denunciato di fronte a tante persone l’immenso degrado morale che ci circonda. La vostra decisione ha spinto la gente a prendere posizione, con coraggio, contro la tirannia del consenso.
Ed è prezioso perché ci è stato assegnato oggi da un gruppo di persone che ha agito con fiducia e con coraggio, senza indietreggiare, offrendo a tutti noi un esempio e un modello di comportamento. Guy, Hagai, Iris, Anat, Amit, Yoni, Oren e molti altri, sono orgogliosa di essere qui con voi per questa toccante cerimonia. A nome di Breaking ghe Silence, sono fiera di ricevere questo premio che è fuori dal consenso, che si oppone al consenso ed è la spina nel fianco del consenso.
* Foto di Justin McIntosh, tratta da Commons Wikimedia. Immagine originale e licenza.