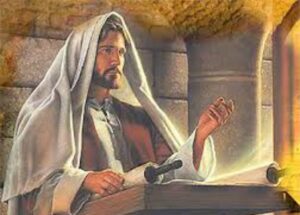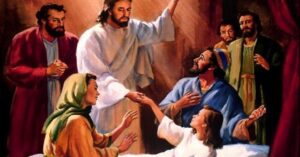Author Archives: luciano meli
il commento al vangelo della domenica
NON DI CONTENUTI MA DI MODALITÀ
il commento di E. Ronchi al vangelo della quindicesima domenica del tempo ordinario
Mc 6,7-13
Vangelo che mette con le spalle al muro.
Mi proteggo da questo vangelo, pensandolo rivolto agli altri, invece siamo tutti inviati, tutti sulla strada, come i Dodici, per essere un dito puntato su Gesù, un evidenziatore, un faro su di lui.
E ci viene istintiva la scusa di Mosè: ma come Signore, mandi me balbuziente a parlare alla corte, si metteranno a ridere! O di Geremia: sono troppo giovane; di Amos che protesta: sono solo un mandriano, sto dietro alle mucche.
Ma “l’annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l’annuncio sarà infinitamente grande” (G. Vannucci).
Allora vado bene anch’io.
Perché il sacerdote Amasia non si lascia aiutare dal piccolo profeta? Forse perché Dio brucia, e se l’accogli ti cambia la vita.
Io non ero profeta; ero un bovaro, un contadino, mi occupavo della vita. Ma il Signore mi ha “preso”. Confessa una chiamata che è quasi una violazione da parte di Dio. Il vangelo di oggi ci aiuta a farci “prendere”.
Per le strade di Galilea (ogni strada del mondo è Galilea) la gente vede arrivare, sotto il sole, due tipi strani, a piedi, più poveri di un povero, senza bisaccia e con solo un bastone.
Li vede venire a due a due, che non è la somma di uno più uno, ma è l’inizio della comunione, la prima cellula della comunità.
Ma così arriva il vangelo?
Così è venuto Cristo, senza denaro, senza borsa, nudo sulla croce.
Aveva solo un bastone, il legno della croce, piantato a sorreggere.
Più che sui contenuti da trasmettere, Gesù con i Dodici insiste sulle modalità di come si passa nel mondo: liberi e leggeri. Il come si vive, è la vita. Prima si è visti, poi si è ascoltati.
In tre anni di strade, olivi, lago, pane che non finisce, malati toccati e guariti, hanno appreso l’essenziale, hanno imparato Gesù.
Lui porteranno in giro per le strade.
Riassumo in due linee questo vangelo: l’economia della piccolezza e quella della strada.
La piccolezza attraversa l’intera Bibbia e ne rappresenta l’anima profonda. Quella di Abele, delle donne sterili e madri, di Giuseppe venduto dai fratelli, di Amos e Geremia, della stalla di Betlemme, dei “beati i poveri”, del granello di senape, dei 12 che vanno senza niente fra le cose.
L’economia della piccolezza ci fa trovare profeti là dove la grandezza vede solo piccoli contadini.
E poi l’economia della strada: che è libera ed è di tutti, che non domanda tessere, che ti apre orizzonti ed è sempre nuova. Mettersi per strada è un inno alla libertà e alla fiducia. Un salmo cantato agli incontri che farai.
E i Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; li ha messi sulla strada che non si ferma, che verrà sempre incontro, che se li porterà con sé verso il cuore della vita.
Vanno, profeti del sogno di Dio: quello di un mondo finalmente guarito; ripulito dai demoni che invecchiano il cuore giovane della vita.
il commento al vangelo della domenica
il commento al vangelo della domenica
il migrante costruito come nemico da cui difenderci
la costruzione del nemico migrante
di Filippo Miraglia
in “il manifesto” del 26 giugno 2024
Trentacinque anni fa, dopo l’omicidio del rifugiato sudafricano Jerry Masslo, avvenuto nell’agosto
del 1989 a Villa Literno, il 7 ottobre di quell’anno, un vasto schieramento di forze sociali promosse
la prima grande manifestazione contro il razzismo. Quella data segna la nascita di un movimento
antirazzista per i diritti delle persone di origine straniera e contro ogni forma di discriminazione.
A distanza di 35 anni, la condizione del mondo dell’immigrazione è peggiorata e, nonostante il
numero di migranti sia cresciuto (da poche centinaia di migliaia del 1989 a più di 5 milioni oggi),
abbiamo visto diminuire la visibilità e il protagonismo di migranti e rifugiati, in parallelo a un
aumento della politicità dell’argomento e di un uso sempre più strumentale a fini elettorali.
La scarsa presenza nel dibattito pubblico sull’immigrazione dei protagonisti, insieme all’uso
aggressivo di argomenti razzisti, ha portato a una progressiva disumanizzazione delle persone,
permettendo a politici e giornalisti spregiudicati di usare argomenti esplicitamente razzisti senza
alcuna vergogna. Questa condizione ha autorizzato chiunque a considerare stranieri, migranti,
rifugiati, lavoratori e lavoratrici come numeri, la cui vita evidentemente non vale nulla.
Le affermazioni di Renzo Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, sulla responsabilità del
lavoratore morto «per mancanza di attenzione», cancellano le circostanze che ne hanno determinato
la morte, nonché l’elemento essenziale di quella che è una nuova forma di schiavitù, con condizioni
note a tutti come il lavoro nero, lo sfruttamento e il ricatto legato al permesso di soggiorno.
Questo ricorda chiaramente quanto disse il ministro Piantedosi all’indomani della strage di Cutro:
««L’unica cosa che va detta e affermata è che i migranti non devono partire». E subito dopo: «La
disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei
propri figli».
Insomma, la colpa è delle vittime che scelgono di morire perché sono irresponsabili, mettendo a
rischio le loro vite e quelle dei figli. Se lo dice un ministro della Repubblica, perché non dovrebbe
dirlo un datore di lavoro che non si vergogna di un atto crudele e criminale?
Le parole allucinanti di Piantedosi all’epoca di quella strage furono seguite da una scelta coerente di
tutto il governo, che si riunì subito dopo, proprio nel luogo della strage, per approvare una legge
contro l’immigrazione legale e a sostegno dei trafficanti, senza peraltro stringere la mano e portare
il cordoglio dell’Italia ai superstiti e ai familiari delle vittime. Un governo che ha impostato tutta la
sua azione in questo ambito proprio sulla costruzione del nemico, da dare in pasto all’opinione
pubblica con profluvio di leggi e accordi in sfregio della Costituzione e del diritto internazionale.
Una forma esplicita di razzismo di stato che va contrastata con forza, mettendo in campo
un’alternativa dal basso, dai territori.
Oggi, come nel 1989, un fatto tragico legato allo sfruttamento lavorativo, non un incidente ma un
vero omicidio, può rappresentare l’elemento che fa scattare la reazione dell’Italia antirazzista. Un
movimento che non è minoranza in Italia, ma che prende raramente la parola, come di rado la
prendono le persone di origine straniera sulle questioni che le riguardano direttamente.
È necessario che il prossimo autunno, proprio in prossimità di quella data che ha visto l’avvio di
una mobilitazione importante per la lotta contro il razzismo nel nostro Paese, si faccia tutto il
possibile per portare in piazza quella parte d’Italia che non vuole arrendersi alla disumanizzazione
delle persone, all’attacco alla civiltà giuridica italiana ed europea e all’avanzata delle destre
xenofobe in tutta l’Ue, per gli interessi dei partiti che sul razzismo hanno costruito la loro fortuna, il
loro business e non certo nell’interesse del Paese.
Una mobilitazione che va preparata con assemblee territoriali, in tutti i luoghi nei quali le persone,
soprattutto migranti e rifugiati, si incontrano per discutere e organizzare la partecipazione, ridando
finalmente la parola ai protagonisti.
C’è il tempo per farlo, per far crescere dai territori una grande mobilitazione. Per ribaltare l’idea che
il razzismo paga elettoralmente, che parlare di diritti e uguaglianza è impopolare e affermare con
forza che ciò che serve per rimotivare le persone a partecipare è un’idea giusta e praticabile di
società accogliente e aperta. Se non ora, quando?
il commento al vangelo della domenica
il commento al vangelo della domenica
NELLA NATURA DELLA NATURA
il commento di E. Ronchi al vangelo della undicesima domenica del tempo ordinario
Mc 4,26-34
Quante volte non troviamo le parole adatte per dire Dio!
E Gesù ci risponde con le parabole.
Lo fa con parole laiche, di casa, di orto, di lago, di strada, per raccontarci storie di vita.
Il vangelo di Marco riassume il suo insegnamento con immagini di contadini che si affaticano nell’arte di far nascere, fiorire, fruttificare.
Il contadino nel vangelo è l’anello mancante tra l’uomo e Dio, dove le parabole non sono solo semplici pretesti per insegnare teologia e morale.
Un albero, le foglioline del fico, il granello di senape diventano una continua rivelazione del divino (Laudato si’), una sillaba del suo messaggio.
Le cose del mondo non sono sante perché ricevono l’acqua benedetta, ma sono degne di riceverla perché già benedette, santificate, e noi camminiamo in mezzo a loro come dentro un santuario.
Ezechiele aveva parlato della tenerezza di un Dio giardiniere che pianta un cedro del Libano. Gesù va oltre: parla di un semino di senape con una novità tutta sua: sceglie una pianta mai nominata nel Primo Testamento, nonostante fosse di uso comune.
Gesù sceglie l’economia della piccolezza: mette la senape al posto del cedro del Libano; l’orto al posto del monte;
parlerà di Dio con l’immagine di una chioccia con i suoi pulcini: è il linguaggio teologico portato al registro più umile, a sovvertire le gerarchie.
Gli ascoltatori di Gesù saranno rimasti sconvolti all’idea che il Regno di Dio ha inizi così piccoli, ma Gesù si concentra sulla crescita dal minuscolo al grande, dai più piccoli germogli, alla maturazione in pienezza.
Le sue parole contengono anche un appello alla meraviglia: il Regno diventa un mistero davanti al quale stupirsi.
Prendere sul serio l’economia della piccolezza ci fa guardare il mondo in un altro modo. Ci fa cercare i re di domani tra gli scartati di oggi, ci fa prendere sul serio i giovani e i bambini, e trovare meriti là dove l’economia della grandezza vede solo demeriti.
Il vangelo della terra di Gesù sovverte le norme, perché le leggi che reggono il venire del Regno di Dio e quelle che alimentano la vita naturale sono in fondo le stesse.
Spirito e realtà si abbracciano.
Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura essere dono e crescita. È nella natura di Dio essere eccedenza gratuita. E anche in quella dell’uomo.
Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; e non per sottrazione, ma sempre per addizione, per aggiunta e incremento, con incrollabile fiducia nei germogli.
Dalle sue parabole sboccia una visione profetica del mondo: la nostra storia è tutto un seminare, germinare, spuntare, accestire, maturare: tutto è fiducia incamminata.
il messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale del migrante
papa Francesco:
«Nei migranti assetati e provati incontriamo il Signore»

il papa con un gruppo di migranti, durante un’udienza generale
Vedere nei migranti Cristo stesso e farsi buoni samaritani nei loro confronti. È questo l’invito che il Papa ripete nel Messaggio per la 110a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 29 settembre 2024, sul tema: “Dio cammina con il suo popolo”. «L’incontro con il migrante, come con ogni fratello e sorella che è nel bisogno – scrive infatti Francesco -, «è anche incontro con Cristo. Ce l’ha detto Lui stesso. È Lui che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito».
Il Pontefice ricorda anche che ogni cristiano può essere considerato un migrante, perché in viaggio verso la Patria celeste. E facendo riferimento al Sinodo di ottobre prossimo ricorda. «L’accento posto sulla sua dimensione sinodale permette alla Chiesa di riscoprire la propria natura itinerante, di popolo di Dio in cammino nella storia, peregrinante, diremmo “migrante” verso il Regno dei cieli. Viene spontaneo il riferimento alla narrazione biblica dell’Esodo, che presenta il popolo d’Israele in cammino verso la terra promessa: un lungo viaggio dalla schiavitù alla libertà che prefigura quello della Chiesa verso l’incontro finale con il Signore«. Il parallelo tra l’Esodo e i viaggi odierni dei migranti è infatti uno dei punti forti del Messaggio. «Le due immagini – quella dell’esodo biblico e quella dei migranti – presentano diverse analogie – spiega Francesco -. Come il popolo d’Israele al tempo di Mosè, i migranti spesso fuggono da situazioni di oppressione e sopruso, di insicurezza e discriminazione, di mancanza di prospettive di sviluppo. Come gli ebrei nel deserto, i migranti trovano molti ostacoli nel loro cammino: sono provati dalla sete e dalla fame; sono sfiniti dalle fatiche e dalle malattie; sono tentati dalla disperazione».
Ma il Papa ricorda anche che «Dio precede e accompagna il cammino del suo popolo e di tutti i suoi figli di ogni tempo e luogo. La presenza di Dio in mezzo al popolo è una certezza della storia della salvezza». Dio dunque cammina con i migranti. E molti di loro «fanno esperienza del Dio compagno di viaggio, guida e ancora di salvezza. A Lui si affidano prima di partire e a Lui ricorrono nelle situazioni di bisogno. In Lui cercano consolazione nei momenti di sconforto. Grazie a Lui, ci sono buoni samaritani lungo la via. A Lui, nella preghiera, confidano le loro speranze. Quante bibbie, vangeli, libri di preghiere e rosari – nota ancora il Papa accompagnano i migranti nei loro viaggi attraverso i deserti, i fiumi e i mari e i confini di ogni continente».
Ma non solo Dio è compagno di viaggio. Egli si identifica con loro. «Dio non solo cammina con il suo popolo, ma anche nel suo popolo, nel senso che si identifica con gli uomini e le donne in cammino attraverso la storia – in particolare con gli ultimi, i poveri, gli emarginati –, come prolungando il mistero dell’Incarnazione». In questo senso «ogni incontro, lungo il cammino – prosegue il Messaggio -, rappresenta un’occasione per incontrare il Signore; ed è un’occasione carica di salvezza, perché nella sorella o nel fratello bisognoso del nostro aiuto è presente Gesù. In questo senso, i poveri ci salvano, perché ci permettono di incontrare il volto del Signore». Di qui l’invito del Pontefice a unirsi «in preghiera per tutti coloro che hanno dovuto abbandonare la loro terra in cerca di condizioni di vita degne. Sentiamoci in cammino insieme a loro, facciamo “sinodo” insieme, e affidiamoli tutti, come pure la prossima Assemblea sinodale, all’intercessione della Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza e di consolazione nel cammino del Popolo fedele di Dio».
Il testo si conclude poi con una preghiera scritta dal Papa che qui riportiamo integralmente:
Dio, Padre onnipotente,
noi siamo la tua Chiesa pellegrina
in cammino verso il Regno dei Cieli.
Abitiamo ognuno nella sua patria,
ma come fossimo stranieri.
Ogni regione straniera è la nostra patria,
eppure ogni patria per noi è terra straniera.
Viviamo sulla terra,
ma abbiamo la nostra cittadinanza in cielo.
Non permettere che diventiamo padroni
di quella porzione del mondo
che ci hai donato come dimora temporanea.
Aiutaci a non smettere mai di camminare,
assieme ai nostri fratelli e sorelle migranti,
verso la dimora eterna che tu ci hai preparato.
Apri i nostri occhi e il nostro cuore
affinché ogni incontro con chi è nel bisogno,
diventi un incontro con Gesù, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.
il commento al vangelo della domenica
il commento al vangelo della domenica
PURO SILENZIO
il commento di E. Ronchi al vangelo della domenica del Corpus Domini
Mc 14,12-16.22-26
Oggi, Corpus Domini, non è la festa dei tabernacoli aperti o degli ostensori dorati da venerare.
Che cosa celebriamo?
Cristo che si dona? Neppure questo è sufficiente. La festa di oggi è ancora un passo avanti.
Io che faccio la comunione?
Non basta.
E’ Lui che viene a fare comunione con noi. E’ Lui in cammino.
Lui che percorre i cieli, Lui felice di vedermi, Lui che non chiede agli apostoli e a me di venerare quel Pane, ma dice molto di più: ‘io voglio stare nelle tue mani come dono, e nella tua bocca come pane, sangue, cellula, pensiero di te.
Tua vita’. Vuole perdersi dentro noi come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo.
La prima parola è: prendete. Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; “corpo e sangue”. Ignote quelle mezze parole ambigue che permettono ai potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio.
Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti.
Prendete. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: per essere trasformati. Quello che sconvolge, è ciò che accade nel discepolo più ancora di ciò che accade nel pane.
Allora mangiare e bere Cristo è molto più che fare la comunione, è “farci comunione”. Che Leone Magno sintetizza così: prendere il corpo e il sangue di Cristo tende a trasformarci in ciò che riceviamo.
Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.
A che serve un Dio come pane chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all’incenso?
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue “ha” la vita eterna. Adesso! Non “avrà”, come una specie di futuro tfr.
La vita eterna è già qui, libera e autentica, e fa cose che meritano di non morire, con Gesù che dice: prendete il mio corpo, tutta la mia umanità, il mio modo di piangere e ridere, di sedermi alla tavola di Zaccheo, di Levi, e a casa tua.
Ma noi di cosa nutriamo anima e pensieri? Di generosità, bellezza, profondità?
O ci saziamo di intolleranze, miopie dello spirito, paure di tutto?
Se accogliamo pensieri degradati, ci faranno come loro; se accogliamo pensieri di vangelo, ci faranno creature di bellezza.
Alla Messa ecco per noi un piccolo pane bianco che non ha sapore, che è puro e profondissimo silenzio.
Dono lieve come un’ala.
Ma accade qualcosa che i padri orientali chiamano deificazione (theosis), parola che fa tremare. Un pezzo di Dio in me perché io diventi un pezzetto di Dio nel mondo.
Finita la religione dei riti e degli obblighi, ecco la religione del corpo a corpo con Dio, la religione del tu per tu con Lui, che prima che io dica: “ho fame”, mi dice: “Prendete e mangiate”.
Mi ha cercato, mi ha atteso e si dona, e io posso solo accoglierlo e ringraziare.