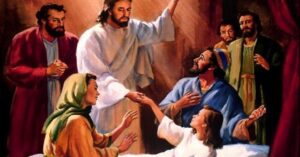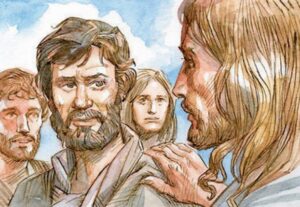Category Archives: materiale da rielaborare
il commento al vangelo della domenica
il commento al vangelo della domenica
il commento al vangelo della domenica
AL BALCONE DEL FUTURO
il commento di E. Ronchi al Vangelo della domenica di Pentecoste
Gv 15,26-27; 16,12-15
Lo Spirito Santo altro non è che il Dio nomade e libero, che inventa, spalanca porte, soffia sulle vele, fa cose che non t’aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta e agli apostoli il coraggio di uscire all’aperto dal luogo chiuso, dalla vita bloccata. Un Dio che non sopporta statistiche né schemi, non recinti di parole, neppure sacre: Dio in libertà.
Parola nuova che si offre al navigante come nostalgia di casa, e all’uomo chiuso in casa come nostalgia del mare aperto.
Le letture bibliche della festa raccontano lo Spirito di Dio attraverso quattro registri musicali che vanno dal mosso vivace della prima lettura al grave e profondo della seconda, ma sono semplici feritoie sul mistero.
La prima porta che lo Spirito abbatte è quella di una casa, il Cenacolo, dove l’aria è chiusa, dove manca luce. Il Libro degli Atti ci racconta di quel cinquantesimo giorno dopo Pasqua, quando gli Apostoli parlavano come “ebbri”, fuori di sé, storditi da qualcosa che li aveva presi come un capogiro, una vertigine violenta e felice.
E’ la prima chiesa, fino ad allora arroccata sulla difensiva, terrorizzata, che viene lanciata fuori, nella Gerusalemme ostile. E la nostra chiesa oggi, anch’essa amata e infedele, proprio perché al bivio di grandi cambiamenti, ancora custodisce in molti suoi figli questo slancio originario.
La seconda porta la apre il salmo, come una melodia che naviga e aleggia sul mondo: del tuo Spirito, Signore, è piena la terra (Sal 103).-
Il Vento di Dio riempie la terra della sua santità, avvolge le cose con la sua luce: e scopro la santità delle stelle e del filo d’erba, del bambino che nasce, del giovane che ama, dell’anziano che pensa. L’umile santità del bosco e della pietra.
La terza porta dello Spirito immette su altre cento: la lettera di Paolo introduce un’orchestra dove ciascuno canta la sua nota, ciascuno porta in dono l’unicità della sua vita, incalzato da uno Spirito che vuole discepoli geniali, non ripetitori di stanche melodie.
Tempo di semine, il nostro. Tempo della pazienza del seme nella terra.
Quando verrà lo Spirito, vi guiderà alla verità. Appare l’umiltà di Gesù che non pretende di avere l’ultima parola, ma parla della nostra storia con Dio, soltanto con verbi al futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà.
Pregare lo Spirito è come affacciarsi al balcone del futuro, che è la terra fertile e incolta della nostra speranza.
Abbiamo bisogno che ciascuno creda al proprio dono, alle proprie originalità, unicità e bellezza, che sono i bellissimi doni dello Spirito. Lui, il Vento santo che non mancherà mai al mio veliero. O alla mia piccola vela, che Dio ha fatto sorgere sul vuoto del mare:
la scuola della pace a Lucca chiede una tregua immediata
la scuola per la pace della provincia di Lucca:
“si lavori per una tregua immediata”
L’appello: “Indispensabile è anche l’immediata apertura di corridoi umanitari che consentano la salvaguardia dei diritti basilari per la popolazione civile”
“Dare voce al popolo della pace di fronte all’escalation bellica”. È questo, in strema sintesi, l’appello lanciato dalla scuola per la pace della provincia di Lucca, che scrive una lunga riflessione in seguito alle terribili notizie sul conflitto tra Hamas e Israele.
“Nel 2003 allo scoppio della guerra in Iraq il movimento pacifista occupò le piazze di tutto il mondo in modo tanto forte da meritare la definizione giornalistica di superpotenza mondiale. Preceduto nel 2001 dal Forum di Porto Alègre, a sua volta spinto dal Popolo di Seattle (1999), il movimento seppe organizzare dal basso una critica radicale della globalizzazione e una potente strategia alternativa di ampiezza mondiale. Seppero collaborare intellettuali, movimenti sociali, sindacati, minoranze di ogni genere e tipo su una piattaforma intergenerazionale, transnazionale e interculturale. Il movimento seppe condizionare i governi nazionali”.
“La guerra tra Russia e Ucraina ha definitivamente spaccato il movimento, già indebolito dalla pervasività delle forme decise dal mercato 4.0, nonché dalla destrutturazione sociale provocata dalla pandemia – proseguono -. Nel contempo è divenuto sempre più evidente che il nodo di tutti i conflitti (sociali, energetici, climatici) e dei loro effetti – che Porto Alègre denunciava già vent’anni fa – si è spostato in Europa. Bisogna riconoscere che la crisi dell’Unione Europea corrisponde alla crisi del modello politico ed economico occidentale: è la crisi dell’Occidente, la crisi della civiltà dei diritti. Ne consegue che è necessario rivedere le forme attraverso le quali si ridefiniscono il bisogno e la possibilità di politiche del pacifismo per rafforzare l’Europa e la civiltà dei diritti. L’Unione Europea non è una comunità, ma è diventata un campo da gioco per la competizione degli Stati: il primo pericolo per l’Europa sono i nazionalismi e i forti principi identitari che ormai guidano o condizionano i governi di diversi Paesi. Con la vittoria della globalizzazione economica neoliberista è fallito il progetto di estensione della liberal democrazia occidentale a livello mondiale: il mercato ha vinto sui diritti. La guerra in Ucraina ha svelato l’inconsistenza diplomatica dell’Unione Europea, un Occidente a trazione nordamericana in contrapposizione al fronte Russia-Cina. Il resto del mondo si posiziona secondo dinamiche sempre meno prevedibili, che tuttavia si innestano in contraddizioni mai sanate, come testimonia la crescente virulenza del conflitto tra Hamas e Israele: noi scegliamo di guardarlo con gli occhi delle vittime dei due opposti fanatismi integralisti che intrappolano la vita delle persone in un conflitto feroce dove pagano i civili e gli inermi. Né possiamo tacere davanti alle politiche oppressive e coercitive che dal 2007 costringono 2 milioni di palestinesi a vivere in assoluta povertà nella striscia di Gaza“.
“Il processo di decolonizzazione dell’Africa testimonia ulteriormente la debolezza dell’Unione Europea e al tempo stesso non lascia intravedere reali processi di emancipazione dei popoli – proseguono -. Sono cambiate le logiche militari: oggi è in atto una guerra tecnologica 4.0, che si affianca a una guerra reale combattuta e sofferta, fin qui limitata a un preciso scacchiere geopolitico che tuttavia si sta pericolosamente allargando. Cambiamenti climatici e guerre regionali spingono ondate migratorie sempre più imponenti, mettendo in evidenza un altro conflitto che si va inasprendo, quello tra ricchi e poveri su scala mondiale. Di fronte a tutto questo, la scuola per la pace della Provincia di Lucca si mette a disposizione per riattivare la comunicazione tra le reti associative e facilitarne le forme organizzative al fine di: rielaborare gli strumenti di analisi politica e le forme di azione in grado di influire sull’opinione pubblica e sulle istituzioni; uscire dalla pigrizia mentale e dai perimetri identitari, cercando nuove forme per mediare gli inevitabili conflitti; produrre una cultura che evita le semplificazioni e smaschera le mistificazioni – strutturare convergenze che diano corpo e spazio alla fiducia nell’azione politica per la giustizia sociale, ambientale, di genere/i e intergenerazionale”.
“Nel vivo del nuovo fronte di guerra appena aperto, l’ente Provincia di Lucca si impegna attraverso il presidente a farsi portavoce presso le istituzioni sovraordinate dell’appello per una tregua immediata del conflitto tra Hamas ed Israele, affinché si possano porre le basi di una reale mediazione tra le parti – concludono -. Indispensabile è anche l’immediata apertura di corridoi umanitari che consentano la salvaguardia dei diritti basilari per la popolazione civile”.
il commento al vangelo della domenica
la giustizia del Padre è dare il meglio a ciascuno

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”»(…)
il commento al vangelo della domenica
Gesù cerca seguaci vivi e coraggiosi per seguirlo
il commento di E. Ronchi al vangelo della ventiduesima domenica del tempo ordinario anno A
In quel tempo (…). Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». (…)
Un avvio così leggero e liberante: se vuoi venire dietro a me. Se vuoi: farai come vorrai, andrai o non andrai con lui, il maestro degli uomini liberi, nessuna imposizione. Ma le condizioni sono da vertigine. La prima: rinnegare se stessi. Un verbo pericoloso se capito male. Non significa annullarsi, diventare sbiadito o incolore. Il maestro non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dai talenti realizzati, seguaci vivi e coraggiosi. Lo Spirito cerca e crea discepoli geniali. Rinnegare se stesso significa: non sei tu il centro dell’universo, della famiglia, della comunità, e tutti a servirti per darti le gratificazioni di cui hai bisogno. Rinnega la concupiscenza di essere un Narciso allo specchio: tu sei il filo di un meraviglioso arazzo, piccolo, unico, insostituibile. Martin Buber riassume così il cammino dell’uomo: “a partire da me, ma non per me”. Perché chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. La seconda condizione: prendere la propria croce. Immagine che abita gli occhi di tutti, che pende al collo di molti, che segna vette di monti, incroci, campanili, ambulanze, che abita i discorsi come sinonimo di disgrazie e di morte. Ma il suo senso profondo è altro. Per Gesù, è il luogo del dolore e dell’amore, incrocio delle più grandi passioni, nel doppio significato di appassionarsi e di patire. Sostituiamo la parola ‘croce’ con la parola ‘amo-re’, e la frase diventa: chi vuole venire con me, prenda tutto il “suo” amore, tutto quello di cui è capace, e mi segua. Viva e ami, come me, quelle cose che meritano di non morire, a partire da sé ma non per sé, e troverà una vita indistruttibile. Prendi su di te tutto l’amore di cui sei capace e poi prendi anche il dolore che ogni amore comporta, perché dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue ferite e le tue spine. Trasforma la ferita in benedizione. Gesù non sogna uno sterminato corteo di gente con la croce addosso, ma l’immenso pellegrinaggio verso più vita. Chi vuole salvare la propria vita…. La vita si salva come si salva un tesoro, spendendolo. Se chiudi le porte, la tristezza non può uscire e la gioia non può entrare. La vita ama le porte aperte, non la puoi possedere o fermare, deve scorrere; tutto scorre nell’universo, astri, pianeti, fiumi, uccelli migratori, sangue, nessun filo spinato può fermare il vento. La vita se si ferma, si ammala. Allora cammina la vita con me. Gesù riesce a far sentire le persone più grandi e più preziose e feconde di quello che gli altri pensano, di quello che loro stesse pensano; libera le forze imprigionate dentro, le ricchezze addormentate in loro, è il risvegliatore della vita profonda, come nessun altro sa fare.
(Letture: Geremia 20,7-9; Salmo 62; Romani 12,1-2; Matteo 16,21-27)
la fede e il ‘catechismo femminista’ di Michela Murgia
la ricerca e la fede
Michela Murgia e quella sete di assoluto
.jpg?width=1024)
L’ultima volta che ci siamo visti, Michela Murgia aveva appena donato a papa Francesco una copia della rivista di cui era stata direttrice per un solo numero. In copertina c’era lei, elegantissima e sorridente come sempre appariva da quando, nel maggio scorso, aveva deciso di rendere pubblica la fase terminale della sua malattia. “Aspetta, ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, aveva detto mentre cercava uno sgabello. Era affaticata ma orgogliosa: di quel giornale che era diventato un manifesto delle sue convinzioni (“La famiglia è di tutti”, annunciava il titolo principale) e del fatto di averlo potuto consegnare nelle mani del Papa che proprio lei, conosciuta come iconoclasta, aveva difeso dalle accuse piovutegli addosso all’indomani dell’elezione (a proposito di titoli, quel “Bergoglio e pregiudizio” scelto per sintetizzare le sue posizioni resta memorabile).
Michela Murgia era credente e non ne aveva mai fatto mistero. Fin dal suo libro di esordio, Il mondo deve sapere del 2006, non le dispiaceva definirsi teologa, una qualifica poi rivendicata in modo militante attraverso i suoi saggi, in particolare Ave Mary del 2011 e il controverso “catechismo femminista” God Save The Queer del 2022. Non erano mere provocazioni, anche se come tali si è cercato di farle passare. Tutto sommato, anche a Michela Murgia sarebbe convenuto metterla sul piano del paradosso intellettuale, dell’esagerazione argomentativa. Alla peggio, la si poteva buttare in politica, che in certi casi è il modo migliore per chiudere il discorso. Il punto è che la narratrice di Accabadora (il suo libro più celebre e compiuto, pervaso da un’incombenza del sacro per la quale è difficile trovare corrispettivi nella recente letteratura italiana) non si limitava a essere orgogliosa. Era anche una persona esigente, con gli altri e con sé stessa, con la propria scrittura e con le proprie convinzioni, sempre messe alla prova. Prendeva sul serio la fede e proprio per questo si aspettava molto dalla Chiesa.
La sua simpatia nei confronti di Francesco non aveva niente di ideologico. Era la condivisione intima e istintiva di una dottrina della misericordia dalla quale nessuno, per nessun motivo, può sentirsi escluso. Su questi, che erano i temi che più le stavano a cuore, sapeva essere polemica come sono a volte gli adolescenti, che alzano la voce e sbattono le porte solo per essere sicuri di essere amati nonostante tutto, senza condizioni. A volte esagerano, d’accordo, ma hanno dalla loro la certezza che un amore che ponga condizioni semplicemente non è amore.
Di tutto il resto si può discutere, ma a questo desiderio di assolutezza non si può né si deve aggiungere nulla. “Ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, diceva Michela Murgia l’ultima volta che ci siamo visti. Ne abbiamo bisogno tutti, sempre, solo che spesso non abbiamo il coraggio di ammetterlo. Lei, invece, non ha voluto nascondere la sua fragilità finale. “Voglio andare avanti così, fino alla fine”, ripeteva. “Riesco a scrivere solo quando mi sento minacciata, quando il cuore mi impazzisce per la paura”, aveva confidato in un’altra occasione. Non so se fosse intenzionale, ma stava citando san Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, “quando sono debole, è allora che sono forte”. È una bella definizione della fede. Senz’altro, è la definizione migliore per la fede di Michela Murgia, che sorrideva al Papa e si aspettava tanto – tutto – dalla Chiesa.
il commento al vangelo della domenica
Il Vangelo di questa domenica ci racconta del momento in cui Gesù si è trasfigurato davanti a tre dei suoi discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni. Questi tre amici del Signore sono gli stessi che sono stati invitati a restare al suo fianco in altri passaggi forti della vita di Gesù, pensiamo al tempo doloroso e difficile nel Getsemani poco prima della Passione. Questo dettaglio ci fa comprendere l’importanza di ciò a cui assistono i tre discepoli e la difficoltà di comprendere correttamente la Trasfigurazione stessa. La scena si svolge in disparte e con un ristretto gruppo di discepoli, gli amici più intimi.
L’aspetto del Signore cambia, il suo volto diventa luminoso e appaiono al suo fianco Mosè ed Elia. Di fronte a questi grandi segni possiamo solo immaginare lo stupore dei discepoli, che come inebetiti restano muti, solo Pietro – forse senza rendersi conto delle sue stesse parole – dice: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Di fronte a questa proposta si oppongono le parole di Gesù: «Alzatevi e non temete». Non è possibile né corretto restare isolati in contemplazione di questa visione straordinaria, bisogna tornare in mezzo agli altri, proseguire il cammino, anche quando tutto ciò vuol dire affrontare la propria Passione e morte.
Fermiamoci a riflettere su questo aspetto: ci sono momenti nel cammino di ciascuno di noi, in cui si vivono forti esperienze a livello spirituale o di fede, penso a pellegrinaggio oppure ritiri o esercizi spirituali. Lo stare bene e in pace in quei giorni non deve diventare giustificazione per cercare di protrarre il più a lungo possibile quei contesti straordinari; bisogna piuttosto far tesoro di ciò che si è vissuto per cambiare e rafforzare il nostro impegno di cristiani nel cammino quotidiano, nelle situazioni ordinarie, nelle relazioni che viviamo tutti i giorni. La grazia da parte di Dio di farci sentire in maniera forte la sua presenza in alcune tappe della vita, deve essere occasione di trasfigurare la nostra per avvicinarla al modello di suo Figlio.
Nel passo della Trasfigurazione, una voce dal cielo rivela l’identità di Gesù: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». Ciò che i discepoli avevano solo intuito, senza comprenderlo appieno, viene rivelato da Dio stesso: essi sono chiamati ad ascoltare Gesù, lo avevano già seguito, eppure gli viene chiesto di rinnovare il loro ascolto, di vivere un ascolto nuovo, vero, attento. Solo attraverso questo nuovo ascolto i discepoli avranno la capacità di comprendere cosa di lì a poco sarebbe accaduto, il manifestarsi della regalità di Cristo e della sua vittoria sulla morte, passandoci attraverso. Anche noi abbiamo bisogno di migliorare sempre più il nostro ascolto del Signore: col tempo può capitare di appiattire la Parola allo stesso livello delle parole che ci sommergono, di travisare le sue parole in base alle nostre aspettative e desideri.
Questa festa della Trasfigurazione sia occasione per trasformare la nostra persona, lasciandoci illuminare dalla luce di Cristo che salva e conduce a Lui.
i lager a cielo aperto dei nostri tempi con l’avallo dell’Europa
Tunisia
il governo Saied nega le espulsioni
ecco le foto esclusive degli accampamenti al confine con Libia e Algeria
secondo Placemarks, che analizza le immagini satellitari, le tende alla frontiera aprono uno scenario nuovo. Il ministro degli interni tunisino Kamel Feki accusa i media che denunciano

TUNISI
Seduto in prima fila in uno degli scranni dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il ministro degli Interni tunisino Kamel Feki ha il volto sereno ed è pronto a rispondere alle domande del parlamento sulla situazione migratoria nel Paese. È il 27 luglio scorso e al centro dell’attenzione ci sono le immagini provenienti dal confine con la Libia e l’Algeria, dove da quasi un mese si registrano deportazioni di massa nei confronti della popolazione subsahariana e del Sudan. Persone che vengono arrestate a Sfax, seconda città della Tunisia e uno dei punti principali delle partenze lungo il Mediterraneo, e lasciate a loro stesse senza acqua e cibo in zone militari e inaccessibili dopo essere state picchiate o avere subito violenze di ogni tipo da parte delle forze di sicurezza locali. Le ricostruzioni più recenti parlano di 1200 persone espulse verso la frontiera algerina e libica

Soprannominato Stalin in patria solo per una netta somiglianza fisica con l’ex Segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica, le parole del ministro sono precise e puntuali: «Quelle immagini sono false. Lo dico e lo ripeto perché abbiamo le prove. È stato tutto fabbricato a monte e gli autori di quelle foto sono sorvegliati con audio e video».
Tuttavia sono parole che oggi possono essere smentite facilmente. In collaborazione con PlaceMarks, un progetto specializzato in ricerca e analisi di immagini satellitari, La Stampa ha ricostruito quanto sta avvenendo al confine con la Libia grazie a una serie di foto risalenti al 14 luglio. Due giorni prima della firma del memorandum d’intesa da un miliardo di euro tra Tunisia e Unione europea alla presenza della Commissaria Ue Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte. Nelle stesse ore in cui in vista della visita del 16 luglio a Tunisi la portavoce di Bruxelles Dana Spinant affermava che «la gestione dei migranti deve essere sempre svolta nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani».

Le immagini parlano chiaro. Si vedono almeno tre accampamenti di fortuna, di cui uno sembra essere costruito con una gabbia di ferro per gli allevamenti ittici, e un grande assembramento di persone, almeno 300, controllate a vista da alcuni mezzi militari tunisini e libici. A poche centinaia di metri di distanza si possono notare altri quattro mezzi della guardia di frontiera tunisina. Posizionati lungo un fossato costruito fra il 2014 e il 2018 per delimitare in maniera ancora più netta il confine, uno di questi è dotato di un mitragliatore o un cannone. «Da un’analisi storica dell’area si può affermare che lo scenario al confine tra Tunisia e Libia è qualcosa di completamente nuovo. Gli assembramenti e gli accampamenti prima non esistevano, mentre la presenza di militari in assetto di pattugliamento non è mai stata registrata in nessuna delle immagini disponibili, dal 2006 a marzo 2023», spiega Federico Monica di Placemarks.

Da queste istantanee prendono ancora più forza le testimonianze di chi in quella terra di nessuno ha vissuto per giorni senza acqua e cibo. Un limbo accessibile solo alla Croce rossa tunisina, impegnata in questi giorni a prelevare le persone per portarle in altri luoghi della Tunisia. Altri salvataggi sono stati compiuti dalle cosiddette autorità libiche, interessate a mostrare il volto più accogliente al netto di numerose denunce internazionali sul mancato rispetto dei diritti umani.
Sono testimonianze che raccontano di migranti, studenti, lavoratori, donne incinte, bambini e neonati che si sono visti privare tutto con la violenza; picchiati dalle autorità con mazze di ferro e bastoni, caricati su dei pullman e gettati senza risposte verso la Libia e l’Algeria. Per chi tentava di rientrare in Tunisia, ad attenderlo c’erano gas lacrimogeni e proiettili.Se l’Oim e l’Unhcr hanno emanato un comunicato per sollecitare un intervento a tutela di queste persone, Bruxelles sembra più concentrata sui numeri dei migranti in arrivo dal piccolo Stato nordafricano.