IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
commento al vangelo della quinta domenica di quaresima (2 aprile 2017) di p. Alberto Maggi:
Gv 11,1-45
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero:
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Il destino di chi si è fidato e ha creduto in Gesù, viene presentato da Giovanni, nel suo vangelo, nel capitolo 11, con l’episodio di Lazzaro, che inizia così: “un certo Lazzaro di Betania”, è l’unica volta che un infermo, in questo vangelo, ha il nome, Lazzaro significa “Dio che aiuta”, “il villaggio”, gli evangelisti, quando pongono questa indicazione, il villaggio, significa che è un luogo di incomprensione, se non di opposizione, è il luogo attaccato alla tradizione, che fa difficoltà ad accogliere la novità portata da Gesù. “… di Maria e di Marta sua sorella, era malato”, l’evangelista, attraverso tre personaggi, presenta una comunità, che si tratti di una comunità poi lo rivela più sotto quando dice: “le sorelle mandarono dunque”, doveva scrivere le sue sorelle, omettendo il possessivo l’evangelista vuole indicare che è una comunità. Ebbene questa comunità vive il momento della malattia mortale di uno dei suoi adepti, e mandano ad avvisare Gesù. Stranamente Gesù non si muove, Gesù non si muove, del brano leggiamo soltanto le parti essenziali perché è molto lungo, saltiamo al versetto 17, “quando Gesù arrivò trovò” e non Lazzaro. L’evangelista qui non mette il nome, “lo trovò”, perché nella tomba non c’è Lazzaro: Lazzaro, con il momento della morte, è entrato nella pienezza della dimensione divina, ma c’è il morto. Tutto il brano è un invito alla comunità cristiana a cambiare il concetto della morte. “Quando Gesù arrivò, lo trovò che già da quattro giorni era nel sepolcro”, perché questo “quattro giorni”? Si credeva che, per tre giorni, lo spirito dell’individuo restava a vegliare il cadavere. Quando poi non si riconosceva più nei lineamenti del volto, per l’inizio del processo di decomposizione, scendeva nel regno dei morti, quindi è completamente morto. Gesù non entra nel villaggio, il luogo dell’incomprensione. Per incontrare Gesù, occorre uscire dalla tradizione, dal villaggio, allora Marta “dunque come udì che veniva Gesù, gli andò incontro”, ed investe Gesù di un rimprovero dice: “«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!”. Avevano avvertito Gesù che il fratello era malato, che era grave, e Gesù non si era mosso. Gesù sembra non essere mai presente nei momenti di bisogno, e quindi Marta rimprovera Gesù. Ma dice: “anche ora so”, lei si rifà a quello che sa, cioè alla tradizione, “che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Gli evangelisti distinguono tra il verbo chiedere ed il verbo domandare: il verbo chiedere è una richiesta di un inferiore verso un superiore, il domandare una richiesta alla pari. Qui, per Marta, Gesù deve chiedere, quindi (Gesù) lei non ha compreso ancora che Gesù è Dio, che Gesù è uguale a Dio. E Gesù le risponde: “tuo fratello risorgerà”, non l’avesse mai fatto, si becca una reazione stizzita da parte di Marta. “Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno»”. Quando una persona è in lutto, se per confortarla gli si dice che la persona defunta risorgerà, quando? Non solo non gli si dà consolazione, ma la si getta nella disperazione. Quando risusciterà? Oggi, domani, tra un mese, tra un anno, alla fine dei tempi? E va bene per la fine dei tempi anche noi saremo morti e già risuscitati, non è una consolazione. Quindi Marta risponde seccata: “so che risorgerà, nella resurrezione dell’ultimo giorno”, perché questa era la credenza farisaica della resurrezione. Si viveva, si moriva, si finiva nel soggiorno dei morti, poi l’ultimo giorno, un giorno finale, ipotetico, ci sarebbe stata la risurrezione dei giusti. Ed ecco la rivelazione di Gesù, che cambia completamente il concetto di vita, il concetto di morte, il concetto di risurrezione. Gesù le disse: “io sono”, io sono non è una rivendicazione di presenza, ma è la rivendicazione del nome divino, è il nome con il quale Dio si rivelò a Mosé: “io sono”. Quindi Gesù rivendica la pienezza della condizione divina, “la risurrezione e la vita”, non dice io sarò, lui è la risurrezione e la vita, quindi la vita e la risurrezione non saranno, ma sono già. E poi la risposta di Gesù si articola in due elementi. Il primo, alla comunità che piange uno dei componenti che è defunto, dice: “chi crede in me”, Lazzaro ha creduto in lui, “anche se muore”, anche se adesso vedete un cadavere, “vivrà”, continua a vivere. Quindi Gesù richiede, alla comunità che piange un morto, di avere questa fede. Ma poi, ai componenti della comunità che sono vivi, Gesù dice: “chiunque vive”, e quindi voi che siete vivi, “e crede in me”, e mi avete dato adesione, “non morirà in eterno”, non morirà mai. Gesù assicura che non si farà l’esperienza della morte: la morte non interrompe la vita, ma introduce subito a una dimensione nuova, piena, definitiva dell’esistenza. Ma Gesù chiede a Marta se arriva a credere questo, ed ecco finalmente la crescita nella fede, “Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo»”, finalmente Marta è cresciuta nella fede. Bene, continua il brano, saltiamo al versetto 33, “Gesù allora, quando la vide piangere”, c’è stato l’intervento dell’altra sorella Maria, che ha rimproverato Gesù con le stesse parole, “e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente”, veramente il verbo adoperato dall’evangelista non è commuovere, è fremere, è reprimere una forte sensazione, potremmo tradurre sbuffò, fremette, e Gesù che non sopporta questa situazione, perché la sua comunità piange esattamente come piangono i Giudei, come piange la tradizione. E Gesù, qui al versetto 35, non scoppiò in pianto, Gesù lacrimò. L’evangelista adopera due verbi differenti per quelli di Marta, Maria, i Giudei, e per il pianto di Gesù. Per il pianto di Gesù usa lacrimare, un’espressione di dolore, per il pianto delle sorelle usa invece il pianto che si faceva nel cordoglio funebre, che indicava la disperazione totale. Ed ecco “allora” che “Gesù”, ancora fremendo, reprimendo se stesso, “si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra”, questa pietra apparirà per ben tre volte, per indicare che è questo che domina la narrazione, erano dei sepolcri scavati nelle grotte, e, di fronte, veniva posta una pietra. L’espressione italiana: “mettiamoci una pietra sopra”, deriva proprio da questi usi funerari, quando ci si è messa una pietra, significa che (tra) il mondo dei morti e quello dei vivi, non c’è più continuità, non c’è più comunicazione. E qui Gesù inizia a dare ordini imperativi, sono tre, il primo è: “togliete la pietra”, siete voi che avete recluso il defunto lì dentro, e voi la dovete togliere questa pietra. E reagisce Marta, Marta che viene indicata come “la sorella del morto”, è superflua questa indicazione, sappiamo che Marta era la sorella del morto, ma l’evangelista sottolinea che questo della morte era il clima, il pensiero che dominava la comunità, “«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni»”. Le disse Gesù: “«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?»”, nella vita indistruttibile si manifesta la gloria di Dio. “Tolsero dunque la pietra” che loro avevano messo, ed ecco gli ultimi comandi di Gesù, “Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!»”, la tomba, il sepolcro non è il luogo per un discepolo del Signore, il discepolo del Signore, nel momento della morte, entra subito nella piena dimensione della sua esistenza. Gesù ha chiamato Lazzaro, ma non esce Lazzaro, esce il morto. Gesù chiama Lazzaro, ma esce il morto, perché Lazzaro non c’era nel sepolcro, Lazzaro era già nella pienezza dell’amore del Padre, è il morto che deve uscire dal sepolcro, cioè l’evangelista vuole aiutare la comunità a cambiare completamente mentalità riguardo alla morte, che le persone defunte non stanno in un sepolcro, ma continuano la loro esistenza nella pienezza della dimensione divina. “Il morto uscì”, e, stranamente, “i piedi e le mani legati con bende”, che non era la maniera di seppellire da parte dei Giudei. Il cadavere veniva lavato con acqua e aceto, poi veniva posto un telo sopra, ma non veniva legato, perché qui il morto ha i piedi e le mani legate? Perché essere legati era il simbolo della morte. Nei Salmi si legge: “mi stringevano le fumi della morte”, essere prigionieri della morte, sono loro che l’hanno legato con queste bende, lo hanno reso prigioniero della morte. Gli ultimi comandi di Gesù sono rivelatori: “Gesù disse loro: «Liberatelo”, cioè scioglietelo, siete voi che lo avete legato come un morto senza vita, l’avete relegato in questo sepolcro. E l’ultimo comando è strano, scioglietelo e ci saremmo aspettati: fatelo venire, andiamogli incontro, accogliamolo, festeggiamolo. Nulla di tutto questo. L’ultimo comando stranamente è: “lasciatelo andare»”, ma dove deve andare? Il morto che deve andare dove Lazzaro già c’è, cioè nella dimensione della pienezza di vita, è la comunità che deve cambiare mentalità. È strano che esce questo morto, non una parola, non un ringraziamento ,non va verso le sorelle che pure lo avevano tanto pianto, ma il morto deve andare, l’evangelista adopera lo stesso verbo “andare”, che ha adoperato per indicare l’itinerario di Gesù con il Padre. Ecco questa espressione dell’evangelista ci illumina sul senso della morte: la morte di un discepolo di Gesù, non solo non interrompe la sua vita, ma lo introduce in una dimensione nuova, piena e definitiva dell’esistenza. La morte non allontana dalle persone, ma le avvicina, la morte non è un’assenza, ma una presenza ancora più intensa.















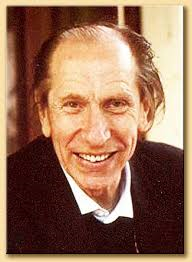
 che supplichi qualcuno
che supplichi qualcuno




%20(1).jpg)
