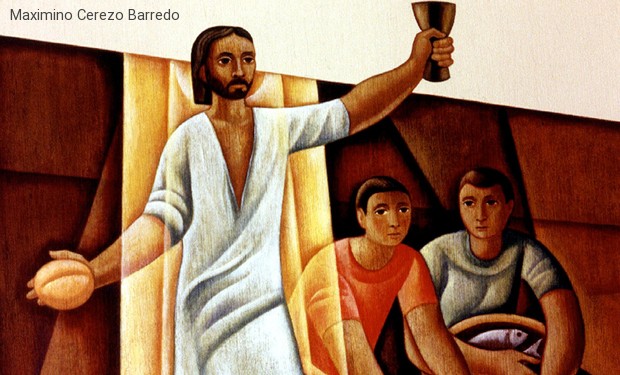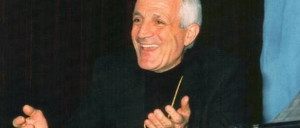nel tempo del “postumano”, tornare all’uomo
Fritjof Capra
Dobbiamo tornare alla comunità, spiega il fisico Fritjof Capra. Per il celebre autore del “Tao della fisica”, se studiamo il vivente “possiamo osservare che gli ecosistemi hanno sviluppato una serie di principi organizzativi che sono principi di comunità. Si potrebbe dire che la natura sostiene l’umano formando e nutrendo comunità”. Cooperazione e sviluppo sono impresse nel codice sorgente della nostra forma di vita.
«La nostra idea fissa della crescita economica e il sistema di valori ad essa sotteso hanno creato un ambiente fisico e mentale in cui la vita è diventata estremamente malsana». Eppure, prosegue Fritjof Capra, nemmeno l’idea opposta, quella di decrescita sembra in grado di accompagnarci verso quel «salto di paradigma» che l’odierno contesto di recessione globale rende non solo auspicabile, ma necessario
L’economia, osserva Capra, è solo un aspetto di un tessuto ecologico e sociale complessivo nel quale si sta facendo largo una nuova visione d’insieme che, a dispetto di cifre, rating e disavanzi di bilancio, oppone una «qualitative growth» – una crescita qualitativa – ai troppi numeri che «vorrebbero imbrigliare la vita» in schemi e grafici.
Fisico teorico, studioso di teoria della complessità, Fritjof Capra è fortemente critico nei confronti di ogni “parcellizzazione” e “settorializzazione” del sapere.
Dopo la svolta
Dono, comunità, interconnessione: tre parole chiave del nostro tempo…
Dobbiamo tornare alla comunità. Ci sono ragioni per questo “ritorno” che illuminano particolarmente il nostro tempo di crisi, dando ad esso una speranza nuova. Una ragione è legata alla sostenibilità, che non è una proprietà dell’individuo di una specie. È proprietà di una comunità ecologica o di una comunità sociale. Se studiamo la vita, possiamo osservare che gli ecosistemi hanno sviluppato una serie di principi organizzativi che sono principi di comunità. Si potrebbe dire che la natura sostiene la vita formando e nutrendo comunità.
Se vogliamo sostenere la vita, noi dobbiamo fare la stessa cosa: nutrire le comunità. In una comunità troviamo piacere nelle relazioni umane. Dobbiamo tornare alle relazioni umane, nutrirle, svilupparle Dobbiamo sognare un’economia informale basata sulla reciprocità, sul dono, su quella shadow economy che, nascosta dalle statistiche ufficiali, permette a uomini e donne di aiutarsi, di sentirsi meno soli, di assistersi, di parlarsi, di avere cura di sé, avendo cura degli altri. La crescita qualitativa di cui parlavamo all’inizio passa proprio da qui: dall’aver cura di sé, dall’aver cura degli altri, dall’aver cura del mondo.

Dobbiamo tornare alla comunità. Ci sono ragioni per questo “ritorno” che illuminano particolarmente il nostro tempo di crisi.
Oggi il pensiero economico sembra arrivato a quel «punto morto» che lei descriveva in uno dei capitoli più forti di un suo libro pubblicato trent’anni fa, Il punto di svolta. Che cosa è cambiato da allora e perché la svolta («turning point») avvenuta nelle fisica all’inizio del XX e tanto attesa in questo inizio di XXI ancora non si è ancora verificata?
The Turning point venne pubblicato nel 1982 e la sua elaborazione mi prese quasi cinque anni, dal 1978 al 1981. Molte cose discusse e, in un certo senso, preconizzate in quel libro si sono poi verificate, ma il punto di svolta non è avvenuto. In questi anni mi sono chiesto molte volte la ragione. Nel 1989 tutto sembrava propendere per un cambiamento globale, invece… Ci siamo andati vicini, abbiamo visto sorgere una società civile globale, in particolare a Seattle, in occasione della manifestazioni di protesta (ma non solo di protesta) contro il vertice dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization).
Il 30 novembre 1999, più di cinquantamila persone, appartenenti a settecento organizzazioni non governative presero parte a una protesta pacifica e costruttiva che ha comunque cambiato per sempre l’orizzonte politico della globalizzazione. Però la storia non segue un corso lineare, avanza in maniera caotica e ci sorprende sempre.
La diffusione delle nuove comunicazioni e il pieno sviluppo della network societyhanno cambiato il contesto, mutando però anche la nostra consapevolezza. Hanno però anche dilatato i tempi della svolta. Una svolta che, ora, sembra nuovamente prossima ad arrivare.
“Noi siamo crisi”
La rapida consultazione di un qualsiasi dizionario basterebbe a ricordarci che “crisi” significa “separazione, scelta, giudizio”, capacità di cogliere nuove sfide, abbandonando vecchi schemi di pensiero. Qual’è dunque la sfida che ci pone la crisi che, dalla Grecia a New York, sembra non lasciare tregua al mondo?
La sfida principale è tutta nel capire “come” passare da un sistema ancora improntato su un’idea di crescita illimitata a un altro che preveda un livello ecologicamente sostenibile e socialmente oltre che economicamente equo. La nostra crisi inizia quando sbagliamo il sistema di referenza e avanziamo smarriti come su un territorio di cui possediamo la mappa, ma una macchia precocemente invecchiata. Per quanto attiene la sfida, occorre un passaggio, una svolta appunto. Ma per compiere questo passaggio, non basta dire “no” alla crescita o auspicare meno industria, meno consumi, meno tutto. La crescita è infatti una caratteristica fondamentale della vita e, di conseguenza, anche della società e dell’economia. Non c’è vita senza crescita e chi non cresce è destinato, prima o poi, a soccombere.
Dobbiamo però intenderci sul concetto di crescita e, come fisico, devo subito osservare che in natura essa non è mai un concetto lineare.
In un ecosistema c’è sempre un gioco di compensazioni che porta all’equilibrio: qualcosa cresce, qualcosa d’altro decresce, ma soprattutto si arriva a una crescita qualitativa che aumentare la complessità e la maturità dell’ecosistema stesso. Questo tipo di crescita non lineare, sfaccettata e multiforme è ben nota ai biologi e agli studiosi delle cosiddette scienze naturali, mentre pare ancora lontana dall’essere accolta dagli scienziati sociali, impregnati come sono di un meccanicismo cartesiano oramai fuori luogo e fuori tempo massimo.
La nostra è una cultura ancora troppo frammentata, divisa tra infiniti specialismi: il riduzionismo consiste proprio in questa disposizione culturale volta a ridurre interrelazioni tra fenomeni complessi a elementi base da studiare solo e soltanto in base ai meccanismo attraverso i quali interagiscono. È una visione ristretta del mondo alla quale, purtroppo, spesso si attribuisce l’etichetta del tutto fuori luogo di “metodo scientifico”.
L’attuale crisi finanziaria globale ha reso ancor più evidente che i maggiori problemi del nostro tempo – energia, ambiente, cambiamento climatico, sicurezza alimentare e la sicurezza finanziaria – non possono essere compresi separatamente. Sono problemi sistemici, il che significa che sono interconnessi e interdipendenti.
Proprio per uscire da questo schematismo, alla crescita e al suo corrispettivo, parimenti riduzionista di decrescita misurate dal PIL e dal consumo pro capite opporrei la visione di una crescita qualitativa e non-lineare, basata sulla qualità della vita e sulle relazioni. Siamo vicini al punto di svolta.

C’è una nuova energia, un movimento civile globale che non è puramente ideologico e chiede di rimettere l’uomo al centro dell’economia, mentre per troppo tempo l’economia si è insediata nel cuore dell’uomo.
Le nuove tecnologie hanno un ruolo ambivalente, in questa crisi. Aumentano la velocità di circolazione di denaro e titoli, ma al tempo stesso favoriscono la nascita di inedite solidarietà tra chi rivendica un modello di sviluppo diversamente partecipato e sostenibile…
Partiamo da una data: il 1989. Con la Caduta del Muro di Berlino. la crisi si è intensificata a tutti i livelli, ecologico, economico e sociale, ma il sistema ha sostanzialmente retto, anche perché le nuove tecnologie hanno dato vita a un nuovo materialismo fondato sul diktatedonistico “consumo, dunque sono”dando così a tutti l’illusione di partecipare in base alla propria capacità di acquisto. Oggi, venuta meno questa possibilità di inclusione attraverso il consumo, chi non può più consumare, comincia a chiedersi come ripartire, come partecipare, come fare rete. Al tempo stesso, infatti, queste nuove tecnologie di comunicazione hanno permesso la costituzione di reti di solidarietà orizzontale e di un pensiero non più lineare – la rete è, appunto, proprio questo: pensiero che si lega e interconnette in forma non convenzionale. C’è una nuova energia, un movimento civile globale che passa dall’occupazione di Wall Street alle proteste di piazza a un movimento di uscita dal nucleare che non è puramente ideologico e chiede di rimettere l’uomo al centro dell’economia, mentre per troppo tempo l’economia si è insediata nel cuore dell’uomo.
Nel tempo del “postumano” lei propone di tornare all’uomo?
Non c’è altra scelta. L’urgenza è anche quella di slegare finanza e vita. Un’economia in senso stretto dovrebbe uscire dall’ossessione istituzionalizzata della finanza. Questa ossessione è tutt’uno con la velocità: pensiamo al fatto che se, storicamente, gli scambi umani hanno sempre subito una certa frizione e un certo attrito – i trasporti via terra o via mare potevano subire ritardi di ogni tipo – oggi grazie alle nuove tecnologie di comunicazione la finanza ha velocizzato i processi di scambio annullando lo spazio tra azione e reazione. Al tempo stesso, però, queste nuove tecnologie hanno permesso il diffondersi di una consapevolezza altamente globalizzata, ma al tempo stesso localizzata nella necessità di azione. Il pensiero deve essere globale, ma l’azione non può prescindere dalla concretezza del locale. Il vecchio motto di Jacques Ellul, «pensa globalmente, agisci localmente» ha oramai preso corpo.