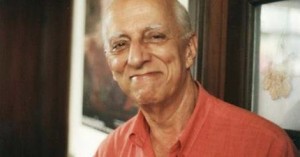e se li lasciassimo liberi di organizzare la loro vita riconoscendo loro semplicemente tutti i loro diritti?
parlando chiaramente e onestamente dovremmo riconoscere che il nostro non è mai stato un rapporto corretto con questo popolo, e questo sia in senso, per così dire, diacronico (guardando alla storia del nostro rapporto con loro), sia in senso sincronico (guardando al presente che riproduce in genere in forme più soft quello che nel passato ha rappresentato vere e proprie violenze, razzismo, disprezzo, … genocidio): la loro storia con noi può essere sintetizzata in forme, a volta a volta, di ‘esclusione’, di ‘reclusione’ , di ‘inclusione’ forzata pur di non riconoscere loro la libertà di organizzare liberamente la loro vita, lasciando loro la libertà di organizzarsi la vita come vogliono, semplicemente riconoscendo loro tutti quelli che sono i loro diritti
perfino ‘i migliori tra noi’, i meglio intenzionati ‘ a fare il loro bene’ hanno fatto spesso danni incalcolabili e irrecuperabili senza una presa di coscienza che il maggior danno che si può è sostituirsi ‘per il loro bene’ alla loro stessa libertà, creatività, cultura …
personalmente credo si debba un grazie particolare a Marcello Palagi per la pubblicazione (su faceboook) di una lucida riflessione in merito, e credo quanto mai opportuno ospitarla in questo sito per aiutare, chi fosse interessato, a focalizzare meglio la problematica:
rom e assistenzialismo
lasciamoli liberi di decidere di se stessi
Non se ne può più. dei sedicenti esperti e del volontariato beneficente, delle onlus a pagamento, degli amministratori democratici e fascisti, e di tutti quelli che sanno come si dovrebbero risolvere i problemi dei rom e dei sinti cioè il problemi che abbiamo noi nei loro confronti. Lasciamoli perdere gli “zingari”, non occupiamocene e non preoccupiamocene più. Più ci si occupa e preoccupa di loro e più i loro problemi crescono, più li neghiamo, perseguitiamo, escludiamo, respingiamo ai margini più bassi della nostra società e più diventiamo il loro vero problema. Perchè considerandoci buoni e solidali, ci dedichiamo al loro bene, a igienizzarli, a edilizzarli, ad alfabetizzarli, a scolarizzarli, occuparli, storiografarli, fotografarli, congressualizzarli, documentarizzarli, reportarizzarli, narrarli. E questo per “tutelare” la loro cultura, inserirli nel mondo del lavoro, insegnargli a vivere come si deve, a educare i figlii, a farli vivere e a renderli del tutto simili a noi.
Esperti improvvisati
Uno va in un campo di “zingari” un paio di volte e, se non ci scrive subito un libro o gira un documentario per ammannirci la sue scoperte “antropologiche”, si sente autorizzato a far proposte e progetti su come risolvere i “loro” problemi, quelli – ripeto che noi abbiamo nei loro confronti – “civilizzarli” e assimilarli: meno figli, inserimento nelle case popolari, igiene e pulizia, scuola e doposcuola, lavoro in fabbrica o, preferibilmente, nell’agricoltura, alimentazione “corretta”, inesorabile rispetto delle leggie nel caso non mandino a scuola i figli, sfratto dall’abitazione o dall’area di sosta (figli compresi ovviamente). E poi sgomberi manu militari e chiusura delle aree di sosta, abolizione del nomadismo, (dato che non sarebbero mai stati nomadi per scelta, ma perchè costretti a nomadizzare dai pregiudizi degli altri) e se dovessero perseverare nel voler fare i nomadi, le assistenti sociali calino su di loro, e gli tolgano i figli per metterli in istituto o darli in adozione, tanto i tribunali dei minori sono quasi sempre consenzienti.
Giustizia feroce
I rapporti della giustizia con i rom sono infatti quasi sempre sbrigativi e feroci. Perchè si pensa, anche a livello di tribunali, che i rom, siano quasi tutti dediti alla microcriminalità, per cui, anche a sparare nel mucchio, si farebbe sempre centro, Per i rom non scatta mai la prescrizione, venendo regolarmente processati per direttissima e se devono andare in galera ci vanno e stanno, altro che arresti domiciliari a 4 ore settimanali di “assistenza” a vecchi non autosufficienti!
Volontariato dannoso
Intorno ai rom e ai sinti si muovono quasi esclusivamente improvvisatori buonisti che fanno più danni che la grandine, perchè sono convinti di sapere, loro, cos’è il bene per gli “zingari” e vogliono redimerli, salvarli, inserirli, perchè sono arretrati, devianti e incapaci di autoregolarsi. E non c’è improvvisatore che non di senta ispirato a fondare un gruppo di volontariato che faccia progetti su di loro, “senza fini di lucro”, ovviamente, ma a pagamento, perchè i progetti si pagano e così pure gli operatori volontari. C’è chi si è inventato il mestiere di assistente agli “zingari” e usufruisce di finanziamenti pubblici che gli permettono di campare non male sulla loro pelle.
Salvatori a progetto
Il volontariato, quello a pagamento, c’è andato a nozze: un progettino oggi e uno domani e il gioco è fatto. Incompetenti totali sono andati nei campi ad alfabetizzarli, a insegnargli i mestieri loro come la battitura del rame o il cucito alle donne, a intrattenere i bambini con giochi e metodi disciplinari che niente hanno a che fare con i loro modi di vivere ed educare le nuove generazioni. I più furbi dei volontari, poi, hanno stabilizzato il loro interventismo, mettendo in piedi onlus che organizzano convegni, si autoeleggono esperti e accedono ai finanziamenti pubblici con cui inviano inutilissimi e dannosi operatori nei campi, elevano proteste in nome dei diritti dei rom e contro gli sgomberi e predicano la necessità che ai rom vengano dati appartamenti in case popolari, perchè, anche loro sono convinti che rom e sinti siano diventati nomadi perché costretti dai pregiudizi e dalle persecuzioni. Cazzate, ma i buonisti che si preoccupano del bene dei rom, le spacciano per verità indubitabili e le propalano grazie alla propria e altrui ignoranza.
La “scienza”
dell’omologazione
E gli antropologi accademici, che hanno a che fare, come consulenti, con gli enti pubblici e i loro emolumenti, mediano: ormai il nomadismo è finito, si tratta di una fase storica superata, sono i rom che vogliono avere una casa popolare, eliminiamo perciò i campi degradati e degradanti. Pontificano cioè sulla testa dei rom, contro il loro diritto di decidere di se stessi, se andare a stare in case o se continuare a vivere nei campi e a muoversi.
Quando fascisti e nazisti cominciarono ad occuparsi dei rom, aprirono i campi di concentramento e, dove gli riuscì, anche i forni.
E’ preoccupante questa crescita esponenziale dell’interesse buonista e assistenziale per i rom. Si preparano tempi sempre più bui per loro con tanta gente che li studia, li classifica, vuole fargli cambiare vita. Oggi rom e sinti sono diventati di moda e oggetto di studi e ricerche “nobili”, merce appetibile per tesi universitarie, carriere accademiche, promozione di convegni, progetti regionali e locali di scolarizzazione, socializzazione, inserimento, avviamento al lavoro, professionalizzazioni varie. Tutto sulla testa dei rom. Non sono loro a decidere e a prendere queste iniziative e i finanziamenti non vanno a loro.
Rom e intellettuali
Un buon mezzo per capire quali sia il tono dei rapporti tra società stanziale e rom, è costituita da quelle opere di gagé che si propongono di parlarne e di rappresentarli in modo pregiudizialmente positivo. Non è possibile in questa sede fare un’analisi ampia di queste opere, saggi, romanzi, racconti, reportage, documentari, film, articoli, ci vorrebbero ricerche e tempi lunghi che qui non abbiamo.
Limitandomi ad alcune considerazioni generali, che mi sembra possano riguardare da vicino anche molte associazioni di volontariato e onlus, direi che anche in chi ha molte simpatie per i rom e nutre pregiudizi positivi nei loro confronti, dominano i travisamenti e la incomprensioni.
Qui mi limiterò a citare alcuni esempi”, ma se ne potrebbero esaminare moltissimi altri. Non si tratta di uomini e avvenimenti che abbiano qualcosa che li leghi tra di loro, salvo appunto l’incomprensione del mondo “zingaro”, nonostante che per scelta di parte sensibilità e/o mestiere, dobbiamo considerarli dei simpatizzanti.
Un cantautore
Leggo sul Manifesto che un autore di canzoni, Pierpaolo Capovilla, ha pubblicato un disco “Obtorto collo” , la cui ispirazione deriva, dice, dagli “ultimi”, dagli “emarginati”. L’autore ha “incontrato”, per caso Irene “fuori da un ospedale di Treviso. Una ragazzina bellissima vestita con gusto. A pochi metri la sua famiglia zingara, anzi romani. Cosa fanno questi ragazzini, come spiega bene Bianca Stancanelli nel suo libro La vergogna e la fortuna, soprattutto a scuola? Cercano di non essere riconosciuti come appartenenti alla comunità romani, perchè una volta riconosciuti come zingari, vengono discriminati, stigmatizzati. Ecco alla vista di quella scena mi si è spezzato il cuore”. Non consiglierei mai la lettura del libro della Stancanelli (magari dirò perché in un’altra volta), ma una cosa appare evidente dalle parole di Capovilla che per lui la scuola deve essere la prima preoccupazione per “redimere” gli “zingari” dalla discriminazione e stigmatizzazione e per impedire che gli si spezzi il cuore. Viene spontaneo un “Vaffa…
Altre logiche
quelle dei rom
I rom si muovono sempre in terreni antropologicamente e culturalmente propri dove niente funziona come vorrebbero i gagé. La cultura rom è la cultura della flessibilità e dell’adattamento, secondo modalità proprie, alla “zingara”. Da una parte non vogliono farsi notare, perchè facili vittime di discriminazioni e persecuzioni, dall’altra però vogliono e debbono invece rendersi ben visibili (basta pensare ai loro modi inequivocabili, di vestire), perchè, per questa via, confermano la loro identità, la loro cultura, le loro tradizioni al loro interno (egemonia dell’interno appunto), e, contemporaneamente, si propongono all’esterno, di fronte al mondo gagiò, come marginali, diversi, anche bisognosi di aiuti, di elemosine, di assistenza.
Dentro e fuori
I rom vivono cioè fuori e dentro la nostra società (noi siamo il loro ecosistema) e risolvono i problemi di relazioni con noi e tra di loro secondo metodologie differenti dalle nostre, proprio per questa doppia appartenenza che poi potremmo anche definire plurima, perchè sono anche nomadi e stanziali, parlano lingue diverse oltre alla loro specifica variante romané, mandano i figli a scuola per necessità, ma non ci credono e formano i figli con altri metodi e ad altri valori, ecc. A seconda dell’ambiente i cui si muovono, quello esterno o quello interno, adottano quindi strategie di vita differenti, flessibili, le più adatte in quel momento al contesto in cui si trovano. Se perciò ci si fa “spezzare il cuore”, pensando e credendo che loro, poverini, devono nascondere la loro identità a scuola, per non essere emarginati e discriminati, senza tener conto di queste plurime appartenenze, si finisce per non capir niente di loro e si adotta il punto di vista dell’assistenzialismo buonista, cioè dei buoni che pensano e vogliono: che rom e sinti diventino come lnoi e smettano di essere rom. Ma rom e sinti, fortunatamente, da secoli, e nonostante tutte le persecuzioni e genocidi subiti continuano a resistere e a fare di testa loro, anche quando crediamo che ci prendano sul serio.
De André
Su un sito, che si fregia della denominazione di Onlus dedicata ai rom, vedo riportata ancora una volta la canzone di De Andrè, Khorakhanè, da Anime Salve, con tanto di note che si trovano nel depliant di accompagnamento del disco. Sono quasi venti anni che ho scritto che la parte del testo di “Khorakhanè” in romané era in realtà in lingua harvata, sufficientemente diversa da quella dei Khorakhanè bosniaci e macedoni, a cui ho fatto sentire la canzone, tanto che non l’hanno compresa. In appendice al testo di Khorakhanè comparivano, poi, nel depliant di accompagnamento del disco, tre annotazioni, per spiegare il significato di “khorakhanè”, di “festa di San Giorgio” e di kampina, di cui si parla nella canzone. Tutte e tre le spiegazioni erano sbagliate: il termine khorakhanè non indica una tribù (non ci sono tribù di rom e sinti) diffusa in Serbia e Montenegro, come dice il depliant, ma definisce i rom di religione musulmana sufi, probabilmente provenienti, chissa quando, dalla Turchia e molto più presenti in Bosnia, Macedonia, Kossovo, che non in Montenegro e in Serbia.
La festa di san Giorgio non è una festa annuale dei rom del sud della Francia, ma una festa ortodossa slava, che i rom dell’ex Iugoslavia e anche i khorakhanè, mussulmani hanno fatto propria e celebrano regolarmente agli inizi di maggio, dovunque si trovino; anche qui ad Avenza, perciò. Infine con la parola kampina non si indica una “baracca da campo dei rom”, o una tenda, ma la roulotte.
Sono solo canzonette?
Mi è stato risposto dalla Onlus in questione, a cui ho fatto notare queste cose, che si trattava solo di “imprecisioni” linguistiche e che loro vogliono bene a De André. Hanno capito tutto, evidentemente. Perchè degli “zingari” appunto si può parlare, sparlare, straparlare, inventare quello che si vuole tanto è lo stesso. E a chi gliene frega? Le leggende metropolitane su di loro circolano molto meglio che le conoscenze. Non si tratta di questioni e tanto meno di “imprecisioni” meramente linguistiche, ma di mancanza di rispetto verso i rom e di ignoranza, negazione, superficialità nei confronti della loro cultura. De Andrè è sicuramente bravo, ma coi khorakhanè, oltre che per la retorica, ha toppato.
Anche per lui evidentemente non c’è bisogno di conoscere i rom e controllare quello che si dice su di loro, bastano i pregiudizi correnti: figli del vento, perseguitati, fieri della loro identità e cazzate del genere e se si confonde la festa slava e ortodossa di San Giorgio con quella delle Saintes Maries de la mer, in Provenza, che diferenza fa? tanto sono rom.
Mi domando, ad esempio, quale sarebbe stata la reazione davanti al depliant illustrativo di una raccolta di canzoni in cui fosse stato scritto di De Andrè, “compositore francese”; del disco “Anime sole”, “opera lirica” e della canzone “Khorakhanè”, “quartetto per archi”. Non penso che autore ed editorei ne avrebbero permesso la diffusione.
I rom parlano
lingue diverse
Va anche precisato che non esiste una lingua romané, ma esistono più parlate e lingue dei rom e dei sinti che hanno un fondamento comune, ma spesso sono anche così diversificate da non permettere la comunicazione tra i diversi parlanti. Il sardo o il siciliano, il francese o l’italiano, per capirci, sono lingue neolatine, ma dubito che un parlante italiano o francese comprenda un sardo che parla la sua lingua. Ad esempio i rom bosniaci non si capiscono nel modo più assoluto con i sinti piemontesi e fanno fatica a capire un harvato.
La storia dei rapporti tra cantautori e rom è emblematica, segnata da innamoramenti improvvisi nei loro confronti (semplici, spontanei, fieri figli del vento, liberi, solidali, anarchici, disinteressati, fedeli alla tradizione e alla famiglia) e da persistenti travisamenti e pregiudizi, scambiati per sollecitudine verso di loro. In questi casi i rom vengono pensati e sognati dai gagè che ovviamente li pensano e sognano come vorrebbero che fossero, secondo stereotipi sostanzialmente assimilazionisti.
Pelù
Anche Pelù dedica ai rom una canzone. Il titolo “Lacio drom” significa “buon viaggio”, un’espresione di augurio che non appartiene ai rom o ai sinti. Siamo noi che l’abbiamo inventata ricalcandola sui nostri modi di esprimerci quando uno di noi parte. Anche Pelù come De André, ha evidenti simpatie per i rom, ma appena viene intervistato su di loro, ripete, come tanti, i luoghi comuni e i pregiudizi correnti, perbenisti e omologati, nei loro confronti. Per quanto non generalizzi, vede nei rom, prima di tutto il negativo, quello che tutti rimproverano loro, l’accattonaggio, il furto, la sporcizia, i costumi strani, la volontà di non farsi assimilare, la scarsa o nulla scolarizzazione, la devianza.
Una coincide piena con qunto dicono i razzisti, anche se lui non lo è.
Ma che ne sa?
“… Una cosa che non sopporto (ovvio non tutti sono così) è lo sfruttamento dei bambini, il fatto di mandarli a elemosinare o a vendere rose la notte nei ristoranti, senza mandarli a scuola. Necessariamente – continua – viene fuori una generazione che non saprà scrivere, leggere e non si inserirà mai in una realtà”. Ancora stereotipi negativi: accattonaggio contro scolarizzazione, sfuttamento contro promozione culturale.
Ho visto zingari felici
Sarebbe necessario guardare le cose da un altro punto di vista meno omologato e moralistico e chiedersi, ad esempio, se l’accattonaggio sia avvertito e vissuto dagli “zingari” come comportamento vergognoso o no. E capire se i bambini vivano questa situazione come imposizione, lavoro e sfruttamento o non invece come divertimento, esperienza di vita, contatto anche gratificante con i non zingari che altrimenti non avrebbero occasione di frequentare e conoscere mai.
E ci si dovrebbe chiedere, in via preliminare, se l’accattonaggio sia o non sia, in genere, sfruttamento di minore. e se gli zingari abbiano l’esigenza di educare le loro nuove generazioni alla scuola dei non zingari.
E, ancora, se la nostra scuola, anche solo a quella dell’obbligo, come auspica Pelù, sia strumento adeguato per “inserirli in una realtà” e soprattutto se debbano venir inseriti in “una realtà”.
Attore protesta
e sdottora
L’attore Montesano, in questi giorni ha protestato col sindaco di Roma, perché esiste un campo nelle vicinanze della sua abitazione dove si bruciano a cielo aperto copertoni. Ha ogni ragione di protestare sui fumi nocivi e tossici che lo possono investire, ma non è autorizzato a discutere di cose che non sa, di come si dovrebbero trattare gli “zingari”: i campi rom – dice – sono come campi di concentramento, i rom dovrebbero invece integrarsi e decidere di andare ad abitare come tutti in case «con l”indirizzo, il numero civico, così si sa che mestiere fanno». Se invece sono nomadi non dovrebbero, secondo l’attore, star fermi nè stanzializzarsi.
Un altro che ha capito tutto e vuole insegnare ai rom come devono vivere, basta che premetta, quando apre la bocca per queste banalità, “Io non sono razzista”, e si sente autorizzata a cazzeggiare.
Pregiudizi positivi
Ormai che ci sono dico anche questa. Il grande Moni Ovadia, che apprezzo molto, ha scritto una volta, ma lo ripete spesso, che i rom non hanno mai dichiarato guerre. Oggettivamente può sembrare vero e una volta ho anche pubblicato questa sua presa di posizione su questo giornale, ma non è con questo che si possa fare dei rom i rappresentanti della nonviolenza o della mitezza. Non sono pacifisti: hanno fatto anche i mercenari, quando gli se ne è presentata l’occasione, per lungo tempo. E se non hanno mai dichiarato guerre a qualche stato non è per amore della pace o della noviolenza, ma per il semplice motivo che non avevano uno stato e, ultimi nomadi giunti in Europa, quando ormai si erano consolidati gli stati, non erano sufficientemente forti e organizzati per invaderne uno. Sono come tutti, un misto di bene e di male. In altre parole Moni Ovadia utilizza un pregiudizio positivo per difendere i diritti dei rom contro i pregiudizi negativi che corrono su di loro, ma i pregiudizi positivi sono dannosi quanto quelli negativi, perchè suscitano aspettative che non si verificheranno e si rovesciano, per chi ne resta deluso, nel loro contrario. I pregiudizi positivi sono l’anticamenra di quelli negativi.
Ci si mette anche Durruti
In questi giorni ho dovuto consultare, per altri motivi “La breve estate dell’anarchia Vita e morte di Buenaventura Durruti di Hans M. Enzensberger. Non ricordavo, risalendo la mia lettura a più di quarant’anni fa, che da varie testimonianze lì raccolte e indubitabili, perchè di anarchici al seguito di Durruti, viene fuori che anche questo grande, eroico e generoso rivoluzionario e gli uomini che erano con lui nutrivano nei confronti degli “zingari” profondi pregiudizi. Non solo la proibizione di Durruti di vestirsi alla “zingara” ricalcava quella dei re spagnoli, presa,secoli prima, per cancellare, anche in questo modo, la sopravvivenza come comunità dei kalè (il nome spagnolo degli zingari), ma il tono irridente e sprezzante con cui questa storia si è svolta e viene narrata, dimostra una grave, pregiudiziale e irremovibile mancanza di rispetto e di comprensione dei diritti, delle libertà e delle ragioni di questa minoranza.
Ricardo Sanz
Racconta Ricardo Sanz che sostituì Durruti, dopo la sua morte, nel comando della della Colonna:
«Durruti costituì una brigata di lavoro per la costruzione di strade. … Una delle nuove strade conduceva presso Pina de Ebro dall’arteria principale Lérida-Saragozza fino all’isolato villaggio di Monegrillo. … Questa strada è ancor oggi chiamata dagli abitanti “La strada degli zingari.” Infatti Durruti aveva trovato, nella sua zona d’operazione, un campo di zingari, ed era riuscito a persuadere il popolo migratore a lavorare per la costruzione della strada. Cosa che agli altri sembrava un miracolo, ma che gli zingari, naturalmente, chiamavano “una punizione di Dio».
Gaston Leval
Molto più esplicito e disteso il resoconto dell’anarchico Gaston Leval: “La colonna Durruti, avanzando verso l’Aragona, capitò su un campo di zingari. Intere famiglie erano attendate in piena campagna. La cosa era tanto più spiacevole, perché questa gente non si preoccupava minimamente dell’andamento della linea del fronte, e andava avanti e indietro a suo piacere. Non era escluso che si facessero utilizzare come spie da Franco.
Durruti rifletté sul problema. Poi andò dagli zingari e disse loro: “In primo luogo, signori miei, vi vestirete in modo diverso, nello stesso modo in cui ci vestiamo noi.” Allora i miliziani portavano tutti la blusa operaia, la tuta, e questo col caldo di luglio!
Gli zingari non furono precisamente entusiasti. “Fuori dai vostri stracci! Quello che portano gli operai va bene anche per voi.” Gli zingari si accorsero che Durruti non era dell’umore di scherzare, e si cambiarono. Ma non bastò. “Adesso che avete abiti da lavoratori, potete anche lavorare,” continuò Durruti. Ora sì che ci fu pianto e strider di denti! “I contadini di qui hanno fondato un collettivo e hanno deciso di costruire una strada, in modo che il loro villaggio abbia uno sbocco su quella principale. Ecco pale e picconi, dateci dentro!” Che restava da fare agli zingari?
E di tempo in tempo, lo stesso Durruti passava a controllare come procedeva il lavoro.
Era felice come un matto di aver portato gli zingari al punto di servirsi delle proprie mani. “Viene il Seno’ Durruti!” si sussurravano gli zingari, col loro accento andaluso, e alzavano il braccio nel saluto antifascista; cioè, gli mettevano in faccia i pugni chiusi, e Durruti capiva benissimo quello che volevano dire» (op. cit. pgg. 200 – 201).







 Caricamento in corso…
Caricamento in corso…