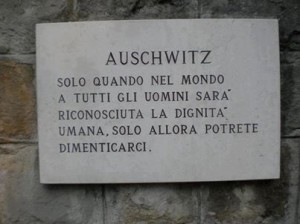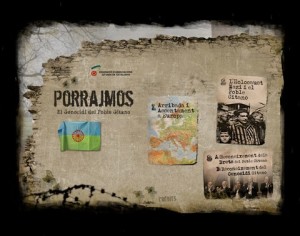memoria e memorie
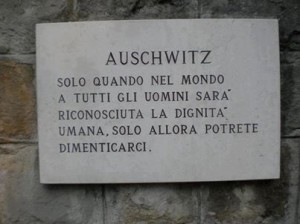
il Giorno della Memoria è stato istituito nel giorno in cui 69 anni fa i soldati dell’Armata Rossa abbatterono i cancelli del lager di Auschwitz e vi entrarono rivelandone l’orrore. E sacrosanto è stato aver stabilito un giorno in cui ricordare quell’abisso incancellabile. Ma, come per ogni ritualizzazione, quella ferita sanguinante si scontra con il rischio della museificazione da una parte e della falsa coscienza dall’altra
M. Ovadia nel fare memoria delle varie shoah (compreso il porrajmos, la shoa del popolo zingaro) pone la vera domanda: non:come abbiamo potuto arrecare danno a loro, ma: come abbiamo potuto arrecare un così grave danno a noi stessi:
Moni Ovadia
in “l’Unità” del 25 gennaio 2014
Un paio d’anni fa fui invitato dall’associazione Beneruwanda a partecipare ad una giornata di memoria del genocidio del popolo Tutsi, nel ricorrere del suo anniversario. In quell’occasione ebbi modo di incontrare la signora Yolande Mukagasana, testimone del genocidio del suo popolo, militante della Memoria e candidata al Premio Nobel per la Pace. Yolande nel genocidio ha perduto marito e figli, lei stessa si è salvata miracolosamente grazie all’aiuto di una donna Hutu.
Incontrandola, rimasi profondamente impressionato dalla luce intensa del suo volto e dalle sue parole pacate e ferme nell’esprimere il dolore per l’ignobile opera di negazionismo che è stata avviata anche nei confronti del genocidio dei Tutsi.
Ebbene sì! Può suonare incredibile ma il negazionismo non è rivolto solo contro il martirio gli ebrei, ma anche contro altre vittime di stermini. Mentre parlavo con Yolande Mukagasana, un singolare dettaglio mi colpì, il fatto che lei portasse al collo, come ciondolo, una vistosa stella di Davide. Vincendo il riserbo le chiesi perché indossasse quella stella e lei mi rispose: «Noi dobbiamo fare come gli ebrei!».
Evidentemente Yolande si riferiva al Senso della Memoria che ha permesso al popolo ebraico di non soccombere alla violenza, all’annientamento e all’oblio, ma di rispondere alle tenebre dell’odio con una cultura di conoscenza e di vita. Per uscire da un equivoco molto diffuso, ovvero che l’istituzione del Giorno della Memoria sia ad usum degli ebrei, è bene chiarire con fermezza che non è così! Lo specifico ebraico della memoria vive nelle sinagoghe e nelle case di studio. La teoria e la Pratica della Memoria ebraica nascono 3500 anni fa in occasione del primo scampato sterminio progettato nel deserto del Sinai dal re Amalek, il progenitore di tutti gli antisemiti irriducibili. A seguito di quell’evento viene consegnato ai b’nei israel, i figli di Israel, il monito «yizkhor!», (ricorderai!). Questa e la ragione del suo carattere originale ed irrinunciabile, 3500 anni di pensiero.
Il Giorno della Memoria deve servire all’Europa che, in misura maggiore o minore, ha nutrito e accolto nelle proprie fibre intime carnefici, collaborazionisti, delatori zone grigie ed indifferenti, deve indurre a riflettere criticamente pro bono della qualità del presente e del futuro sollecitando a porsi la grande domanda che non è «perché abbiamo fatto questo agli ebrei, ai rom, ai menomati , agli omosessuali, agli slavi, agli anti fascisti, ai testimoni di Geova», bensì «perché abbiamo fatto questo a noi stessi? Come abbiamo potuto ridurci a questo infame degrado?».
Quanto agli ebrei devono capire che la memoria della Shoah non deve garantire primazie, ma deve illuminare tutti i genocidi e gli stermini, quelli di prima e quelli di dopo e portarli in primo piano, non relegarli sullo sfondo, inoltre bisogna capire che ogni uso strumentale, propagandistico, bassamente retorico della Shoah è il miglior modo per destituirla di verità e di universalità
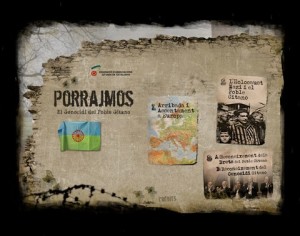
L’“altra” Shoah la devastazione del popolo rom
di Moni Ovadia e Marco Rovelli
in “il Fatto Quotidiano” del 25 gennaio 2014
Il Giorno della Memoria è stato istituito nel giorno in cui 69 anni fa i soldati dell’Armata Rossa abbatterono i cancelli del lager di Auschwitz e vi entrarono rivelandone l’orrore. E sacrosanto è stato aver stabilito un giorno in cui ricordare quell’abisso incancellabile. Ma, come per ogni ritualizzazione, quella ferita sanguinante si scontra con il rischio della museificazione da una parte e della falsa coscienza dall’altra.
Le attività e le manifestazioni di questa Giornata riguardano in maniera soverchiante la Shoah, ovvero lo sterminio degli ebrei, al punto da oscurare quasi gli eccidi e le sofferenze subìte dalle altre vittime della ferocia nazista: i rom, gli omosessuali, i menomati, gli antifascisti a vario titolo, i testimoni di Geova, gli slavi, i militari italiani che rifiutarono di servire il governo fantoccio di Salò.
NESSUN POLITICO AD AUSCHWITZ. HA MAI DETTO: “MI SENTO ROM”

Ricordare l’unicità della Shoah non può essere l’alibi per dimenticarsi degli altri. I rom, in particolare, sono stati per lunghissimo tempo misconosciuti nel loro status di vittime: e se oggi non c’è quasi un politico occidentale che non voglia mostrarsi amico degli ebrei e soprattutto degli israeliani, quasi nessuno di essi è disposto a identificarsi con i rom. Nessuno dei rappresentanti politici dei paesi occidentali ha il coraggio di uscire da una visita al lager di Auschwitz dichiarando: “Mi sento rom”; molti, però, si affrettano ad affermare: “Mi sento israeliano”. Ora sia chiaro, nessuno vuole ignorare o sottovalutare lo specifico antisemita del nazifascismo e sminuire l’immane dimensione della Shoah. Ciò che è inaccettabile è il deliberato sottacere delle sofferenze dei rom e dei sinti anch’essi destinati al genocidio. È intollerabile che si discrimini fra le sofferenze di esseri umani che subirono la stessa tragica sorte. I rom sono vittime secolari dell’occultamento della loro identità e della loro memoria, oltre che essere vittime di un’antichissima persecuzione. Essi non hanno terra, non hanno un governo potente che parli per loro, sono tuttora gli “zingari” reietti: perché mai dunque riconoscere piena dignità alle loro inenarrabili sofferenze? La cultura orale dei rom, del resto, diversamente dalla cultura ebraica fondata sulla Scrittura, ha facilitato il compito della dimenticanza: non c’è stato che un soffio di vento, niente più che questo, nulla che sia conservato e degno di conservazione. Solo con fatica si è imposto il nome dello sterminio nazista dei rom: Porrajmos. Il merito di questo va al grande intellettuale rom inglese Ian Hancock, linguista e fra le altre cose rappresentante del popolo rom presso le Nazioni Unite. Il termine “Porrajmos”, nella lingua di alcuni romanì, “devastazione”. Ma la lingua romanes ha molte articolazioni, corrispondenti alla disseminazione dei suoi numerosissimi gruppi e sottogruppi: perciò capita che un significante abbia significati diversi per diversi rom. Da Jovica Jovic, grande fisarmonicista rom serbo, abbiamo appreso che quel termine, nel “suo” romanes, ha un significato sessuale osceno. Così per Jovica quel termine è inusabile, e offensivo: impossibile per lui ricordare i suoi zii morti ad Auschwitz con quel termine. Una vicenda paradossale, questa, direttamente legata alla dispersione e alla secolare marginalizzazione e inferiorizzazione dei rom. Per rispetto nei confronti dei rom come Jovica crediamo dunque che dovremmo cominciare a trovare un altro termine, che non sia l’ennesimo affronto alla memoria proprio là dove la memoria dovrebbe essere sacralizzata e conservata.
Samudaripen è il termine alternativo che molti rom propongono: significa “tutti morti”, e non ha implicazioni imbarazzanti per nessuno. Per domani le associazioni 21 luglio e Sucar Drom hanno organizzato un convegno a Roma intitolato proprio Samudaripen: può essere un buon inizio, per avere finalmente un nome, e un nome giusto, per l’Orrore dimenticato.