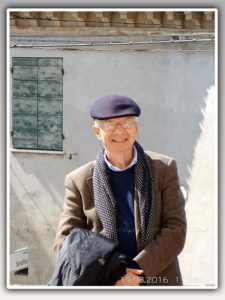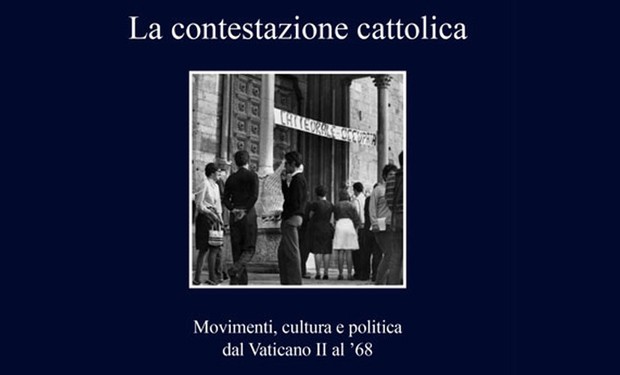dal 17 al 22 maggio Firenze ospita la Settimana di preghiera per le vittime dell’omofobia

dal 17 al 22 maggio a Firenze avrà luogo la Settimana di preghiera per le vittime dell’omofobia organizzata dall’Associazione cristiana “Fiumi d’acqua viva – Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato”, dalla Comunità cristiana “Agape” – Chiesa della Comunità Metropolitana (CCM/MCC), dalla Chiesa Vetero-Cattolica di Firenze “S. Vincenzo di Lerins”, dalla Chiesa avventista di Firenze, dal CECSNUR (Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose). Quattro eventi di approfondimento, dialogo e preghiera organizzate da chiese molto lontane tra loro per storia ed etica ma accomunate dal desiderio di respingere violenza e discriminazione
Martedì 17 maggio alle ore 21 presso l’Aula Magna della Facoltà Avventista in Viuzzo del Pergolino, 8 avrà luogo la tavola rotonda “Evangelicali ed omosessualità: un rapporto impossibile?”. Interverranno Simona Tocci, teologa Chiesa Vetero-Cattolica; Eugen Havresciuc, Direttore Gioventù Avventista del Centro Italia e Pietro Ciavarella, pastore Chiesa Logos. Modererà: Andrea Panerini, pastore CCM/MCC Firenze.
Giovedì 19 maggio alle ore 21 presso l’Aula Magna della Facoltà Avventista in Viuzzo del Pergolino, 8 sarà proiettato il film “Latter Days” (USA, 2003). Christian ha vent’anni, un fisico costruito in palestra e sempre tanta voglia di divertirsi. Lavora come cameriere in un ristorante con alcuni suoi amici e passa le serate in modo un po’ frivolo ed edonistico fra la discoteca e il letto, nel quale non si risparmia in incontri occasionali. Un giorno, per un bizzarro scherzo del destino, un gruppo di missionari mormoni si trasferisce nel suo stesso complesso residenziale e lì avviene l’incontro con il coetaneo Aaron. Chris inizia a corteggiare il ragazzo per una scommessa fatta con i suoi amici del ristorante, ma proprio nell’istante in cui lui e Aaron si baciano, vengono scoperti dai compagni Mormoni: Aaron viene rispedito a casa; Christian si rende conto in quel momento dei sentimenti che prova per il ragazzo, mai provati in precedenza.
Venerdì 20 maggio alle ore 21 presso l’Aula Magna della Facoltà Avventista in Viuzzo del Pergolino, 8 avrà luogo la presentazione del volume “Fede cristiana e orientamenti sessuali” di Andrea Panerini (Doxa editrice). Interverranno, oltre all’Autore, Paolo Ricca, teologo Chiesa valdese; Saverio Scuccimarri, pastore Chiesa avventista e Mirko Zanaboni, militante LGBTQ.
La Settimana si concluderà Domenica 22 maggio alle ore 12 presso la Chiesa anglicana di Via Maggio, 16 con il Culto cristiano per le vittime dell’omofobia. La liturgia sarà a cura di Giampaolo Pancetti (Chiesa Vetero Cattolica Firenze) mentre la predicazione sarà a cura di Saverio Scuccimarri (Chiesa avventista) ed Andrea Panerini (MCC Firenze).
Qui e qui è possibile avere maggiori informazioni sugli eventi