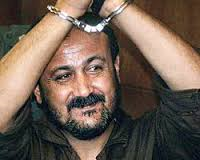chiesa “in uscita”
un decalogo
Andrea Lebra
dalla “Evangelii gaudium” e da altri interventi di papa Francesco si capisce cosa egli intende per “Chiesa in uscita missionaria”. Nelle sue parole sono presenti molti temi: uno stile di Chiesa, il kerigma, le donne, i laici, i poveri, la Parola e il linguaggio.
la “Chiesa in uscita missionaria” è una delle novità che maggiormente caratterizzano il servizio di papa Francesco. Secondo alcuni, questa sarebbe addirittura la vera novità del suo pontificato. Si tratta di una categoria decisamente originale attorno alla quale è costruito il programma pastorale consegnato all’esortazione apostolica Evangelii gaudium dove «la riforma della Chiesa in uscita missionaria» per annunciare la gioia del Vangelo è indicata come la prima delle sette questioni sulle quali Francesco intende soffermarsi (n. 17).
ma quali sono le specificità di una Chiesa in uscita missionaria per annunciare gioiosamente che la salvezza realizzata da Dio è per tutti (n. 113)? Dalla Evangelii gaudium è possibile farne sinteticamente emergere almeno dieci, tutte di straordinaria importanza.
1. Tutti siamo Chiesa!
In primo luogo, va detto che la Chiesa non è limitata ai presbiteri, ai vescovi o al Vaticano. La Chiesa sono tutti i fedeli! È popolo in cammino verso Dio (n. 111). Tutti i battezzati sono la Chiesa. Tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa vocazione, che è quella alla santità. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione implica un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati (n. 120).
2. Più spazio alle donne.
Nella Chiesa c’è bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva (n. 103). Le rivendicazioni dei legittimi diritti delle donne, a partire dalla ferma convinzione che uomini e donne hanno la medesima dignità, pongono alla Chiesa domande profonde che la sfidano e che non si possono superficialmente eludere (n. 104). È urgente accogliere e offrire spazi alle donne nella vita della Chiesa, tenendo conto delle specifiche e mutate sensibilità culturali e sociali. È necessario studiare criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano non ospiti, ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita ecclesiale (Discorso, 7 febbraio 2015).
3. Chiesa non autoreferenziale.
La Chiesa in uscita missionaria evita la malattia spirituale dell’autoreferenzialità; non si chiude in se stessa, nella parrocchia, nella cerchia di chi la pensa allo stesso modo, ma si apre all’incontro con gli altri, anche con chi la pensa diversamente o professa un’altra fede (Discorso, 18 marzo 2013). È una comunità di discepoli che prendono l’iniziativa per andare incontro ai «lontani», per intercettare ai crocicchi delle strade gli «esclusi», per accorciare le distanze con la gente (n. 24). In essa tutto viene pensato in chiave di missione: si tratta non di aspettare che la gente venga, ma di andarla a cercare là dove vive per ascoltare, benedire e camminare insieme, cogliendone l’odore, fino a restare impregnati delle sue gioie e delle sue speranze, delle sue tristezze e delle sue angosce (Messaggio alla Fuci, 14 ottobre 2014).
4. Gerarchia delle verità.
Nella Chiesa in uscita missionaria il Vangelo è annunciato non per imporre nuovi obblighi, ma per condividere una gioia, per segnalare un orizzonte di bellezza, per offrire la partecipazione ad un banchetto desiderabile (n. 14). Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere, ma si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e, allo stesso tempo, più necessario (n. 35). Per raggiungere questo obiettivo è soprattutto necessario tenere in debita considerazione un criterio proposto dal Vaticano II ma spesso dimenticato e trascurato: la gerarchia delle verità, che vale tanto per i dogmi di fede quanto per l’insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi compreso l’insegnamento morale (n. 36).
5. Primato della Parola.
La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la parola di Dio diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale (n. 174). Lo studio della sacra Scrittura deve essere una porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale che la Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede. L’evangelizzazione richiede la familiarità con la parola di Dio e questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante personale e comunitaria (n. 175).
6. Dimensione sociale del kerygma.
La Chiesa in uscita è consapevole che la religione non deve limitarsi all’ambito privato e non esiste solo per preparare le anime per il cielo. Dio desidera la felicità dei suoi figli e delle sue figlie anche su questa terra, benché tutti siano chiamati alla pienezza eterna (n. 182). Una fede autentica, mai comoda e individualista, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Tutti i cristiani, anche i pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore (n. 183). Dio, in Cristo, redime non solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli esseri umani e il cuore del Vangelo rimanda ad un’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana (n. 178).
7. Opzione per i poveri.
Cristiani e comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone che siano docili e attenti ad ascoltare il loro grido e a soccorrerli (n. 187). C’è un segno che non deve mai mancare tra i cristiani: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via (n. 195). Occorre affermare, senza giri di parole, che esiste un vincolo inseparabile tra la fede cristiana e i poveri (n. 48). Una Chiesa povera e per i poveri (n. 198) è una Chiesa che pratica una volontaria semplicità nella propria vita – nelle sue stesse istituzioni, nello stile di vita dei suoi membri – per abbattere ogni muro di separazione, soprattutto dai poveri (Udienza, 3 giugno 2015).
8. Linguaggio chiaro.
Nella Chiesa in uscita missionaria non solo si usa un linguaggio semplice, chiaro e diretto che i destinatari sono in grado di comprendere o che hanno bisogno di sentirsi dire (n. 154), ma soprattutto si usa un linguaggio positivo e attraente perché in grado di offrire speranza, di orientare verso il futuro e di liberare dalla negatività (n. 159). Nelle scelte pastorali e nell’elaborazione dei documenti deve prevalere non l’aspetto teoretico/dottrinale astratto utile solo ad alcuni studiosi e specialisti, ma lo sforzo di tradurre le une e gli altri in proposte concrete e comprensibili per tutti, anche per rafforzare l’indispensabile ruolo dei laici disposti ad assumersi le responsabilità che a loro competono (Discorso alla CEI, 18 maggio 2015).
9. Teologia che odora di popolo e di strada.
Nella Chiesa in uscita la teologia da tavolino (n. 133), che si esaurisce nella disputa accademica o che guarda l’umanità da un castello di vetro, dev’essere sostituita da una teologia che odora di popolo e di strada in grado di versare olio e vino sulle ferite degli uomini e delle donne di oggi. La misericordia, che non è solo un atteggiamento pastorale ma è la sostanza stessa del Vangelo di Gesù, va declinata nelle varie discipline teologiche (dogmatica, morale, spiritualità, diritto e così via). La Chiesa in uscita ha bisogno non di teologi da museo che accumulano dati e informazioni sulla Rivelazione senza sapere che cosa farsene. Ad essa servono teologi capaci di costruire attorno a sé umanità, di trasmettere la divina verità cristiana in dimensione veramente umana (Lettera alla Pontificia Università Cattolica Argentina, 3 marzo 2015).
10. Chiesa che benedice e vivifica.
La Chiesa in uscita è la comunità che si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Per testimoniare Gesù Cristo è pronta al martirio. Però il suo sogno non è di circondarsi di nemici, ma piuttosto che la parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice (n. 24). Nella Chiesa in uscita l’identità cristiana non è né occultata (n. 79) né ostentata (n. 95), ma testimoniata in modo sempre rispettoso e gentile (n. 128). All’atteggiamento del nemico che punta il dito e condanna o del principe che guarda gli altri in modo sprezzante (n. 271) viene preferito uno stile fraterno e sororale che diventa attraente e luminoso (n. 99) agli occhi di tutti, in quanto in grado di illuminare e benedire, vivificare e sollevare, guarire e liberare (n. 273).