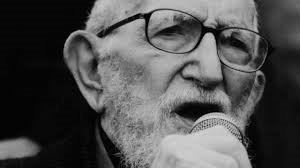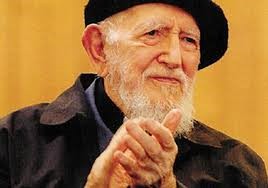otto ricconi possiedono mezzo mondo
di Antonio Sciotto
in “il manifesto” del 117 gennaio 2017
viviamo in un mondo dove crescono impetuosamente le disuguaglianze, dove si fa sempre più ampia la faglia tra i pochi che hanno e i tantissimi depredati. Il mondo del turbocapitalismo non è solo un mondo sempre più ingiusto, squilibrato. È anche un mondo sempre più ingovernabile
le disuguaglianze anche in Italia sono feroci, e la sproporzione non si nota solo rispetto ai più poveri, ma anche rispetto al ceto medio. Il patrimonio dell’1% più ricco degli italiani (in possesso oggi del 25% della ricchezza nazionale netta) è oltre 30 volte quello del 30% più povero dei nostri connazionali e 415 volte quello detenuto dal 20% più povero
Otto super miliardari detengono la stessa ricchezza netta (426 miliardi di dollari) di metà della popolazione più povera del mondo, vale a dire 3,6 miliardi di persone. Il dato, tragico, viene dall’ultimo rapporto dell’Oxfam – «Un’economia per il 99%» – diffuso alla vigilia del Forum economico mondiale di Davos. La forbice tra ricchi e poveri aumenta ogni anno anziché venire corretta al ribasso, e il fenomeno è sempre più preoccupante visto che una grossa fetta della popolazione mondiale (circa un decimo) soffre la fame ed è costretta a sopravvivere con meno di 2 dollari al giorno. Ma dall’altro lato ci sono gli stra-ricchi, gli sfacciatamente ricchi, e nei prossimi 25 anni potremo sperimentare il brivido di conoscere addirittura un trillionaire («trilionario»): possiederà cioè più di 1000 miliardi di dollari (oggi i primi otto paperoni sono tutti sotto i 100 miliardi). Per avere un’idea del significato – spiega Oxfam – bisogna pensare che per consumare un trilione di dollari è necessario spendere 1 milione di dollari al giorno per 2.738 anni.
Le identità degli uomini più ricchi del mondo (tutti e otto maschi, tra l’altro) sono ovviamente già note: guida la classifica Bill Gates, fondatore di Microsoft, con 75 miliardi di dollari di patrimonio personale. Al secondo posto troviamo lo spagnolo Amancio Ortega, fondatore e proprietario della catena Zara (67 miliardi). Seguono il finanziere Usa Warren Buffett (60,8 miliardi), Carlos Slim (industriale messicano delle telecomunicazioni) con 50 miliardi, Jeff Bezos (fondatore di Amazon) con 45,2 miliardi, Mark Zuckerberg di Facebook con 44,6 miliardi. In fondo alla graduatoria (in fondo si fa per dire) troviamo Larry Ellison (Oracle) con 43,6 miliardi e Michael Bloomberg (magnate dei media) con 40 miliardi di dollari.
E in Italia? Non sfiguriamo di certo in quanto ad ampiezza della forbice tra ricchi e poveri: nel 2016 il patrimonio dei primi sette dei 151 miliardari italiani della lista Forbes equivaleva alla ricchezza netta detenuta dal 30% più povero della popolazione (ovvero 80 miliardi di euro). In sette hanno cioè una ricchezza equivalente a quella in mano ai 20 milioni di italiani più poveri. I sette nomi di nostri concittadini che leggiamo nella lista della rivista Forbes sono: Rosa Anna Magno Garavoglia (recentemente scomparsa) del gruppo Campari; lo stilista Giorgio Armani; Gianfelice Rocca; Silvio Berlusconi; Giuseppe De Longhi; Augusto e Giorgio Perfetti. Una situazione che, come abbiamo già detto, non è stazionaria, né in miglioramento, ma che al contrario si aggrava ogni anno: sette persone su dieci, infatti, vivono in paesi dove la disuguaglianza è cresciuta negli ultimi 30 anni. Tra il 1988 e il 2011 il reddito medio del 10% più povero è aumentato di 65 dollari, meno di 3 dollari l’anno, mentre quello dell’1% più ricco di 11.800 dollari, vale a dire 182 volte tanto. Le disuguaglianze anche in Italia sono feroci, e la sproporzione non si nota solo rispetto ai più poveri, ma anche rispetto al ceto medio. Il patrimonio dell’1% più ricco degli italiani (in possesso oggi del 25% della ricchezza nazionale netta) è oltre 30 volte quello del 30% più povero dei nostri connazionali e 415 volte quello detenuto dal 20% più povero. Nel 2016 la distribuzione della ricchezza nazionale netta (il cui ammontare complessivo si è attestato, in valori nominali, a 9.973 miliardi di dollari) vedeva il 20% più ricco degli italiani detenere poco più del 69% della ricchezza nazionale, il successivo 20% (quarto quintile) controllare il 17,6% della ricchezza, lasciando al 60% più povero dei nostri concittadini appena il 13,3% di ricchezza nazionale. Il top-10% della popolazione italiana possiede oggi oltre 7 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione.

Ma come fanno le multinazionali – e i loro proprietari e dirigenti – ad arricchirsi, allargando peraltro la forbice con i cittadini più poveri? La ricetta, spiega Oxfam, è un mix di elusione fiscale, riduzione dei salari dei lavoratori e dei prezzi pagati ai produttori: il tutto, condito con la finanziarizzazione, disinvestendo nell’industria. L’organizzazione ha raccolto testimonianze di donne impiegate in fabbriche di abbigliamento che lavorano 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana e lottano per vivere con una paga di 1 dollaro l’ora. Producono abiti per alcune delle più grandi marche della moda, i cui amministratori delegati sono tra i più pagati al mondo.
E non èmun caso se spesso le fasce di reddito più deboli le troviamo affollate di donne: la disuguaglianza colpisce soprattutto loro, e secondo l’Oxfam di questo passo ci vorranno 170 anni perché una donna raggiunga gli stessi livelli retributivi di un uomo. «Rabbia e scontento per una così grande disuguaglianza fanno già registrare contraccolpi – conclude l’organizzazione non governativa – Da più parti analisti e commentatori rilevano che una delle cause della vittoria di Trump negli Usa, o della Brexit, sia proprio il crescente divario tra ricchi e poveri».