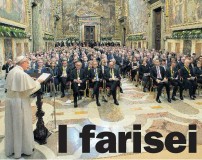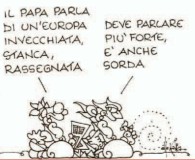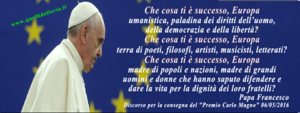siamo don Emanuele, don Andrea, don Alessandro e don Gianluca:
conclusa la Pasqua abbiamo deciso di continuare a vivere nella tenda
lettera dal titolo “la tenda, ancora” nella quale raccontiamo il perché
e anche qualcosa di quello che abbiamo capito in questi mesi

La tenda. Tempo primo
Quando abbiamo cominciato a vivere nella tenda avevamo più sentimenti che idee, eravamo più protesta che proposta. Vivendo in tenda abbiamo assistito sorpresi al fiorire di significati come mai avremmo immaginato. A propiziare tutto quanto è stata la sua collocazione, sul limitare del sagrato, ma anche la lettera-denuncia che ne ha accompagnato l’apparizione e il rimbalzo della sua immagine su qualche social network e giornale. Motivo di vaniloquio, occasione di dibattito, luogo di ascolto: la tenda è stato tutto questo e promette di diventare anche altro. Intanto su di noi ha agito come una levatrice: ci ha aiutato a partorire sguardi nuovi sul mondo, sulla chiesa, su noi stessi. Ripensando con riconoscenza agli incontri vissuti ci rendiamo conto ora che essi attendevano da tempo di poter accadere. Serviva soltanto che ci spostassimo un po’.
Non è stato facile. Siamo preti, eredi di una cultura cristiana che ha occupato una posizione di assoluta centralità. La tenda ha fatto del suo meglio per aiutarci a guardare le cose dal punto di vista di chi vive in periferia. E qualche risultato l’ha ottenuto se diverse persone che soffrono ai margini del mondo hanno sentito qui un p di vicinanza spirituale. Persone che vivono ai margini della vita ecclesiale per ragioni etiche, politiche o religiose; persone che vivono al centro della vita parrocchiale ma soffrono l’immobilità delle sue pratiche pastorali; persone che condividono la vita con i poveri e combattono per il loro riscatto; persone che continuano a credere nella politica come arte della convivenza; adolescenti e giovani in ricerca: molti di loro hanno trovato nella tenda motivo di conforto, un’àncora simbolica alla loro condizione. Non ultimi i nostri amici richiedenti asilo. Nella lettera lasciata in occasione della loro visita abbiamo trovato queste parole: “l’esperienza che state vivendo in tenda ci fa pensare a come potremmo trovarci a vivere se fossimo costretti alla clandestinità…”. Grazie ai sensi molteplici e perfino ai controsensi che di volta in volta le persone hanno voluto trovarvi, la tenda è cresciuta divenendo ai nostri occhi come un simbolo, capace di mettere insieme e di dividere. L’abbiamo abitata in quattro, ma molti l’hanno edificata come molti l’hanno demolita. A tutti dobbiamo un grazie perché nel tempo di Quaresima è stata ci che è stata.
Qualche visitatore ci ha ringraziato perché vivevamo insieme in condizione di debolezza e provvisorietà. D’un colpo abbiamo rotto due cliché radicati nell’immaginario, quello del parroco che vive da solo e che vive in una canonica. E’ bastata l’esile struttura della tenda con noi quattro dentro a disarmare i nostri visitatori e a favorire il clima libero, non giudicante e confidenziale dello scambio. Vivere insieme in un ambiente indifeso è stato la risposta più efficace e persuasiva che ha raggiunto i nostri visitatori prima ancora che aprissimo bocca, l’argomento più solido di qualsiasi considerazione sul divario tra ricchi e poveri. Con la complicità di un ambiente povero, a qualche parrocchiano e visitatore è parso del tutto naturale inserirsi in questa fraternità offrendo un dono, un pasto, un servizio, una lettera, una telefonata. Ovviamente a qualcun altro è parso del tutto inappropriato che dei parroci vivessero così. Nel frattempo la tenda è riuscita a mettere insieme noi preti molto più di quanto non siano riuscite a fare le nostre case parrocchiali. Mai come in queste settimane abbiamo percepito il bisogno gli uni degli altri. Non il bisogno di una mano pastorale ma il bisogno di stare vicini, di sostenerci a vicenda nel rendere ragione della nostra scelta. Una sensazione del tutto nuova, favorita dalla vulnerabilità e confinante con l’amicizia. Vivere insieme ha naturalmente reso evidenti somiglianze e differenze: ma perché ci sia amicizia servono entrambe. Così, pur nella diversità dello stile e del ritmo abitativo, abbiamo sentito che la nostra fraternità c’era, che poteva essere generativa per altri, che poteva favorire lo sviluppo di alleanze e parole vere per il nostro tempo.
Trovato posto per le nostre distanze, è stato possibile trovarne uno per quelle alimentate da osservatori esterni: le critiche di amici e nemici ci hanno rafforzato, costringendoci a verifiche continue. Uno degli effetti salutari imposti dalle obiezioni degli altri è stato dubitare seriamente di noi stessi. Già quando si era trattato di scendere in tenda all’inizio della Quaresima, qualche esitazione si era fatta sentire. Ma col passare dei giorni e con il polarizzarsi dei commenti, a favore o contro, i dubbi hanno cominciato a pesare.
Dubbi sull’opportunità di un gesto così apertamente provocatorio in un clima sociale già teso: non sarebbe stato meglio un invito forte alla conciliazione visto il nostro ruolo di parroci in paesi prevedibilmente divisi su questioni così gravi? Non sarebbe stato meglio promuovere azioni solidali invece che azioni di rottura?
Dubbi sui possibili effetti controproducenti: non avrebbe la tenda favorito paradossalmente sentimenti pregiudiziali verso i poveri?
Dubbi sulla credibilità della nostra causa: i poveri non sono forse sempre esistiti? Perché svegliarsi ora e con questa veemenza? E perché questa insistenza sui poveri che giungono da fuori? Non sarebbe stato meglio occuparsi delle mille povertà che affliggono i nostri paesi ed evitare di sporgere una denuncia così unilaterale contro le colpe dell’Occidente?
Infine dubbi sulla credibilità della nostra scelta: i poveri sono ben lontani dalle condizioni socio-economiche di cui abbiamo continuato a godere noi, malgrado la nostra precaria abitazione. Sicché: la tenda sarà anche povera; ma i quattro che la abitano?
Onore dunque ai dubbi; ma restiamo convinti che neppure essi siano al di sopra di ogni sospetto, che anch’essi siano una forma del rapporto che l’uomo istituisce con la verità delle cose e siano specchio del suo cuore. E che vadano sempre distinti dal sarcasmo stizzoso e dal pregiudizio. Per questo motivo tra i dubbi che meno ci hanno convinto c’è quello di aver trasgredito le buone maniere, il politicamente corretto e l’ecclesialmente corretto; aver lasciato trasparire la passione con i suoi eccessi, le sue parzialità, aver vestito i panni arrabbiati dei migranti invece che quelli equilibrati degli osservatori. Più che figlie del dubbio queste reazioni ci sono sembrate irritazioni un poco borghesi. Non c’è da rimanere meravigliati: decidendo di uscire dal tracciato delle pratiche pastorali ammesse, era da prevedere qualche rischio, qualche perplessità e ironia tra i cristiani e i confratelli alle prese con le stesse problematiche pastorali.
La tenda. Tempo secondo
Con la Pasqua le visite sono sostanzialmente terminate. E con esse il flusso gratuito e inarrestabile di senso profuso dalle parole e dalle attese degli altri. La palla è tornata nuovamente a noi. Che fare della protesta con cui abbiamo iniziato? Che fare dei significati nuovi avuti in regalo? E come rispondere alle attese emerse dagli incontri? Ci troviamo di fronte non a un difetto di senso ma alla sua sovrabbondanza. Gli sviluppi possibili sono molteplici e coinvolgono l’intera nostra esistenza. Abbiamo bisogno di tempo per capire e rispondere. Ecco una ragione per cui la tenda è ancora qui e noi siamo ancora dentro: per ora ci pare il luogo migliore per ascoltare le periferie, per custodire le intuizioni nate, per dare corpo alla nostra fraternità, per dare vita a nuovi segni di protesta e azioni di proposta in favore degli indifesi del mondo.
Mentre scriviamo, l’Austria e i paesi del nord Europa minacciano di sospendere Schengen per altri due anni, il Burundi sta precipitando nel rischio di un nuovo genocidio, l’intervento armato in Libia è sempre sul punto di esplodere, la guerra in Siria continua a mietere vittime innocenti, l’Inghilterra ha detto no a tremila bambini siriani fuggiti da quell’inferno. L’elenco delle aberrazioni etiche e giuridiche è infinito. Proprio in questi giorni i siti web hanno aggiornato la cifra dei morti annegati nel penultimo affondamento nel mediterraneo: non quattrocento ma cinquecento. Quanti sono ormai a giacere là in fondo? Tanti, troppi perché il nostro sistema emotivo possa reggere senza dolore. Questo è il punto. Si diventa remissivi per soffrire di meno. Se la morte del piccolo Aylan sulle coste della Grecia fu una tragedia, 500 migranti che affogano diventano facilmente un dato statistico. Ci si abitua, ci si adatta. Ma a noi non sta bene. Noi non vogliamo abituarci né adattarci. Come tutti ci sentiamo impotenti. E l’impotenza acuisce il dolore. Ma noi crediamo che questo dolore sia il ponte che ci tiene collegati alla realtà e alla nostra comune umanità. Per questo non vogliamo disfarcene. E per questo restiamo nella tenda. Abbiamo bisogno di pungolare continuamente la nostra carne e la nostra mente per restare svegli, per riuscire a piangere, per non assopirci e lasciarci inoculare qualcuno degli anestetici di cui la nostra cultura abbonda. Beninteso, è del tutto inutile restare in una tenda ai fini del miglioramento della condizione degli oppressi. Ma anche abitare una casa lo è. La differenza è che in una tenda piantata tra le case è più difficile abituarsi. In un tenda devi dare spiegazioni a te stesso e agli altri. In una tenda è più facile immaginare ci che i poveri vivono. E sentirlo. E sentire ogni giorno l’urgenza di alzare la voce in loro favore denunciando l’illegalità e la complicità delle istituzioni democratiche occidentali, quelle dei regimi dittatoriali loro alleati o nemici, l’indifferenza della società civile, il silenzio dei media, la lucida crudeltà della finanza mondiale e del commercio di armi.
Non è la nostra tenda a costituire un’eccezione. Per limitarci al diritto negato di un luogo dove vivere in dignità, è risaputo che ci sono milioni di esseri umani baraccati nelle immense bidonville latino-americane e africane, dimenticati da decine di anni nei campi profughi mediorientali, espropriati delle case, della terra e di ogni altro diritto in Palestina, sistemati in tendoni maleodoranti ai confini dell’Europa in fuga da guerra e miseria. Se spostiamo lo sguardo nei nostri paesi scopriremo che gli sfratti per morosità sono in aumento, che la crescita dei senza fissa dimora non conosce sosta e che le case vuote sono molte ma sono indisponibili per chi ne ha un disperato bisogno. Non si tratta di una situazione transitoria: la verità è che sempre più persone faticano a trovare un posto dove vivere e un modo per vivere. E vengono trattate come fuori legge se protestano. Sempre più persone sono costrette ad accontentarsi delle briciole che cadono dalla mensa dei ricchi, relegate alle periferie del mondo, lontane dai centri che contano, condannate a non avere voce né storia. No davvero, non è la nostra tenda a fare eccezione. Siamo in molti qui.
Ci che è stato fatto alle vittime è imperdonabile ma non pu essere cambiato. L’orologio indietro non torna. L’unica cosa che possiamo e dobbiamo fare è implorare che accada l’impossibile: il perdono. Qualcuno ha detto che c’è perdono solo dove c’è l’imperdonabile. Se accadrà saremo salvi. Intanto è nostro dovere domandarlo con forza e domandarlo sempre. Non c’è altra speranza di salvare l’umanità che abbiamo perduto. E’ questa un’altra ragione per cui continuiamo ad abitare la tenda. E’ un modo di fare penitenza e dire ad alta voce che ci vergogniamo di quanto abbiamo fatto e di quanto stiamo facendo. Il perdono delle vittime è l’unica cosa che vorremo aver implorato quando si tratterà di entrare nel Regno dei cieli.
Domandare perdono sarebbe d’altra parte un insulto ulteriore alle vittime se fosse disgiunto dalla volontà ferma di dare un nome ai crimini commessi in passato e denunciare quelli in corso. Mentre imploriamo il perdono dunque, dobbiamo deciderci a scucire la bocca, a rompere l’autocensura che ci imponiamo nel timore di suscitare incomprensioni o divisioni. Noi crediamo che la Chiesa così come il suo Signore è stata inviata “a portare un lieto messaggio ai poveri e la liberazione ai prigionieri”. Dobbiamo stare all’erta per cogliere da quale direzione giungono le voci delle vittime perché da quella parte giunge anche la voce di Gesù: Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verr da lui, cener con lui ed egli con me. (Ap 3,20).
I sacerdoti delle comunità di
Ambivere, Mapello e Valtrighe