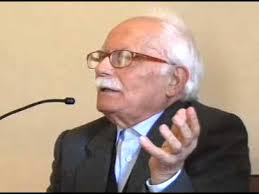Il prete di papa Francesco
L’IMMAGINE DEL PRESBITERO NELL’ESORTAZIONE APOSTOLICA “evangelii gaudium”

una accurata descrizione di Armando Matteo (in rivista ‘Settimana’ del 1 febbraio 2015 n. 5)
Emerge la figura di un presbitero che accetta, senza troppe nostalgie, i cambiamenti sociali ed ecclesiali; che non teme la creatività; che facilita il cammino della grazia; che vive la “mistica della comunità”; che custodisce la prossimità con i poveri e con le periferie; che sa dare anche fastidio. E questo perché ferito dallo sguardo d’amore di Gesù.
Quale immagine di prete emerge dall’Evangelii gaudium? Qual è, cioè, “il prete che serve” in quest’ora della Chiesa e del mondo secondo papa Francesco? Qual è il servizio più importante che il prete possa realizzare perché il compito missionario dell’annuncio della gioia del Vangelo possa essere svolto con maggiore lena e slancio? Proviamo a rispondere a questi interrogativi attraverso una lettura trasversale dell’esortazione papale, considerando non solo i riferimenti diretti al ministero sacerdotale, ma, più in generale, le attese che il papa nutre nei confronti di tutti i credenti; fino a prova contraria, del resto, i preti sono – si sforzano d’essere – anche loro dei credenti.
Il prete che serve è un prete che sa fare il lutto con la cristianità
Bisogna partire dalla constatazione che la nostra non è un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca. L’EG ricorda, al riguardo, il cambiamento apportato dai nuovi mezzi di comunicazione, il cambiamento dell’economia e della finanza, della medicina, delle nuove tecnologie, delle nuove geografie umane e, in particolare, le nuove geografie urbane, il cambiamento dell’autocoscienza e del ruolo delle donne nella società (52, 71-75, 103-104); ricorda ancora l’impatto della secolarizzazione (64). Prendere atto di tutto questo è davvero essenziale per i preti. Si tratta, cioè, di prendere coscienza che quell’unità di cultura e quella cultura di unità, vigente in Occidente sino alla rivoluzione culturale del Sessantotto, non c’è più. Non solo: si tratta pure di capire che non c’è quasi più alcun riferimento e alcuna osmosi vivente tra le istruzioni per vivere e quelle per credere.
Per provare ora a meglio visualizzare un tale cambiamento, si faccia mente al fatto che noi diventiamo umani e cittadini di un dato tempo, facendo nostro il linguaggio umano in generale e, più specificatamente, il linguaggio di quel dato contesto storico e culturale, che tradisce e indica un ordine delle cose del mondo e del mondo delle cose. Ebbene, negli ultimi centocinquant’anni, abbiamo assistito ad un mutamento delle parole e del loro ordine, e dunque all’eclissi di alcune e all’emergere di altre. Sino agli anni 80 del secolo scorso, le parole decisive della vita umana erano eternità, paradiso, verità, natura, legge naturale, fissità, maturità, adultità, mortalità, spirito, mascolinità, sobrietà, sacrificio, rinuncia, autorità, diritto, tradizione. Oggi, al centro del nostro essere abitanti di questo tempo e di questo spazio culturale, si trovano le parole finitezza, alterità, pluralismo, tolleranza, sentimento, tecnica, salute, cambiamento, aggiornamento, corporeità, donna, consumo, benessere, giovinezza, longevità, singolarità, sessualità, democrazia, convinzione, comunicazione, partecipazione.
Esattamente questo provoca la rottura della cristianità, cioè di quella unità tra cultura e fede, tra esistenza e preghiera, tra quotidiano e santo, che, non senza qualche ombra come è naturale che sia, ha molto favorito il lavoro della Chiesa e del clero in particolare: in casa, a scuola, per la strada i codici linguistici – umano e credente – passavano facilmente da una parte all’altra. Ciò non è più dato. Assistiamo, perciò, ad un divenire estraneo del cristianesimo nelle nuove generazioni, che pur frequentano per non poco tempo i luoghi ecclesiali.
L’EG invita ad accettare tutto ciò senza risentimenti, senza cadere in depressione. Certamente, come credenti, si è più poveri, meno sostenuti dall’ambiente culturale, dalla lingua e dalla sensibilità diffuse, ma, se non si compie il lutto con tutto ciò, il rischio è la chiusura, l’introversione, l’autocommiseramento, il ridursi ad essere «generali di eserciti sconfitti» piuttosto che «semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere» (96). Senza il lutto con la cristianità, si lascia spazio alla «psicologia della tomba» (83), alla nostalgia verso «strutture e abitudini che non sono più apportatrici di vita nel mondo attuale» (108). A differenza di tutto ciò, invece…
Il prete che serve è un prete che non teme la creatività e l’immaginazione
Sono davvero numerosi i passaggi che l’esortazione apostolica dedica a questo tema: la parola creatività ritorna così diverse volte (11, 28, 134, 145, 156, 278) come l’invito ad immaginare percorsi nuovi e proposte innovative. In verità, tanti gesti di fede che vengono con magnanimità proposti all’interno delle comunità cristiane non funzionano più o almeno non funzionano più bene come sarebbe giusto attendersi. Basterebbe pensare ai percorsi di iniziazione cristiana o all’impegno per la pastorale giovanile e su questo l’EG non teme di dire che, nell’uno e nell’altro caso, siamo in una sorta di anno zero (70 e 105). Ed è proprio per questo che l’esortazione sollecita, invita a non temere di cambiare. Dando vita pure ad un curioso neologismo: “primerear = prendere l’iniziativa” (24).
Due passaggi del documento papale meritano qui maggiore attenzione. Il primo, al numero 73, dove, ricordando i grandi cambiamenti avvenuti nelle città, che generano nuove culture, l’EG richiede di «immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane». Del passaggio ora citato faccio risaltare il riferimento pregnante alla preghiera: non è più dato ai preti di disinteressarsi dell’attitudine, della qualità e della quantità di preghiera di chi crede, non solo di chi non crede!
L’altro passaggio è la bella difesa che l’EG fa della parrocchia, ma con l’indicazione che essa necessita della docilità e della creatività missionaria del pastore e della comunità: la parrocchia è dotata – si legge al numero 28 – di «grande plasticità» e «può assumere forme molto diverse».
Un tale invito alla creatività e all’immaginazione, al primerear – è naturale – può lasciare i preti in parte sorpresi e impauriti per eventuali effetti non preventivamente calcolabili. Ma è la situazione che lo richiede in quanto chi non muta quando tutto muta alla fine resta semplicemente muto.
Il prete che serve è un prete che facilita la grazia
Qui è d’obbligo citare per intero un passaggio dell’EG: «Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa» (47). Il tono potrebbe suonare duro, specie per i
preti, ma queste sono le cose che stanno tanto a cuore a papa Francesco. Ma come possono facilitare, i preti, l’azione della grazia?
L’EG richiama la necessità di una Chiesa dalle porte aperte e il testo suggerisce di intendere la cosa sia in senso materiale che spirituale, la questione della pratica dei sacramenti (47), l’uso del confessionale, da parte del clero, non come «una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile» (44).
La mia esperienza dei parroci italiani mi dice che su questo, in verità, stiamo messi bene: la gente vuole in generale loro bene proprio per quel senso di grande accoglienza che sanno esprimere e per quell’attenzione verso la singolarità delle situazioni di vita che raramente loro manca.
Un tasto più dolente riguarda, invece, un altro ambito che – secondo me – rientra in questa azione dei preti di facilitare l’azione della grazia. Si tratta dell’impegno a mettere più Bibbia nella vita della comunità cristiana (174-175). Senza un tale contatto con la Parola, vissuta e celebrata, difficilmente verranno alla luce credenti capaci «di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana». Su questo forse qualche domanda il clero deve porsela: facilitare l’azione della grazia non significa pure interessarsi della “dieta spirituale” dei propri fedeli? Li si abitua, per esempio, a leggere e a pregare il Vangelo? Si fa di tutto per far sorgere in loro il gusto della Parola?
Ed è in questo contesto che collocherei la questione dell’omelia: suo compito è quello di facilitare quella grazia speciale connessa al dialogo d’amore tra il popolo di Dio e Dio stesso e che, proprio per questa sua intrinseca verità e funzione, deve stare tanto a cuore ai preti.
Il prete che serve è un prete che vive la “mistica della comunità”
L’espressione mistica della comunità non si trova letteralmente in EG, ma il suo contenuto vi è senz’altro. Lo ravviso dove si dice che «oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (87, si veda pure il n. 272).
Al centro dell’azione pastorale di ogni prete si dovrebbe collocare, dunque, la cura della comunità, che potremmo dire l’impegno generoso affinché cresca la coscienza e la vita di una comunità in quanto comunità, in quanto popolo di Dio; affinché cresca una comunità caratterizzata «da una vita fraterna e fervorosa» (107). Questo è decisivo: per EG il contrario della gioia del vangelo è l’individualismo triste, promosso dal consumismo e dalle logiche del mercato. Ebbene, quale potrebbe essere l’antidoto contro l’individualismo se non una tale mistica della comunità? Non ci deve assolutamente sfuggire questo binomio essenziale tra gioia e comunità.
Certo, creare comunità è una cosa davvero difficile, oggi soprattutto. Ci sono difficoltà intrinseche connesse al dinamismo quanto mai delicato proprio del fare ed essere comunità o fraternità, ci sono difficoltà d’ambiente, ci sono poi specifiche questioni ecclesiali. Il papa enumera: il rapporto laici-clero (102), il rapporto gestione del potere ecclesiastico-donne (103 e seguenti), il rapporto adulti-giovani (105), la questione della pietà popolare (122), il rapporto tra le parrocchie e i movimenti (29). Sono tante sfide e tanti capitoli aperti rispetto all’urgenza della creazione di comunità, di sviluppo del sentimento e della realtà di popolo di Dio; e, detto sinceramente, in tutte queste questioni l’apporto di preti è decisivo.
Eppure mistica della comunità significa credere sul serio sulla forza sanante, liberante e di testimonianza della comunità: si dovrebbe scommettere di più su questo. Una Chiesa in uscita missionaria ha bisogno di più “comunità” e il punto di partenza della Chiesa italiana è quello di avere troppe parrocchie e forse poche comunità.
Il prete che serve è un prete che custodisce la prossimità con i poveri e con le periferie
Le parole che EG dedica alla necessità di stare vicino, accanto e dalla parte dei poveri sono di una chiarezza incredibile. Papa Francesco ricorda che tale attenzione non è un pallino suo o di qualche altro pastore o teologo: è Vangelo in presa diretta, è lo stile di Gesù, è costante tradizione della Chiesa. Anche su questo punto, la mia esperienza dei parroci italiani mi conferma che siamo in grande sintonia con il pontefice. In verità, esiste tutta una tradizione e un modello di parroco vicino alla gente e vicino in modo particolare ai poveri che in Italia è stato ed è assai fecondo.
Qualcosa di simile sento di poterla affermare anche per il tema tanto caro a papa Francesco delle periferie. Come è noto, è proprio questo il terminus ad quem che deve caratterizzare l’uscita missionaria della Chiesa odierna (20, 30). Una tale sensibilità per le periferie, per la marginalità, per gli esclusi, per gli invisibili, a molti livelli e in differenti modi, ha sempre marcato in verità l’esercizio del ministero dei preti italiani. Penso all’impegno per i giovani, per coloro che soffrono la dipendenza dalla droga, per gli immigrati, contro la prostituzione, contro la criminalità organizzata, per la pace, contro le ludopatie… Insomma, i parroci italiani sul serio hanno l’odore delle pecore.
In ogni caso, l’accorato accento con cui EG raccomanda tale prossimità ai poveri e a coloro che vivono nelle periferie esistenziali si collega pure con la costante stigmatizzazione, operata dalla stessa esortazione, della cosiddetta «mondanità spirituale» (93 e ss), la quale ultimamente consiste nel cercare, pur «dentro le apparenze di religiosità e persino di un amore alla Chiesa», non più la gloria del Signore, ma la gloria umana e il proprio benessere.
Il prete che serve è un prete che sa dare anche fastidio
Al n. 203 di EG si constata realisticamente che, a volte, il discorso cristiano sulla dignità di ogni persona e sulle conseguenze che essa impone al comportamento di tutti spesso suona fastidioso: «Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia».
L’ordine mondiale nel quale viviamo nutre, invece, un sentimento generalizzato di indifferenza e costantemente sollecita la passione tristemente individualista del narcisismo: per esso l’essenziale è che crescano consumatori avidi e mai compiutamente soddisfatti, sempre pronti a cadere nella rete delle illusioni immesse nel mercato e opportunamente pubblicizzate come l’autentico Vangelo della gioia. Senza tenere minimamente conto degli effetti distruttivi che tutto ciò opera sulla dignità umana di chi non ce la fa, degli esclusi, degli “scarti”.
Tale meccanismo, francamente, non produce nemmeno la felicità o la gioia promessa in coloro che vi aderiscono perfettamente: la nostra è l’epoca di una tristezza infinita (265).
Si richiede pertanto uno scatto, una parola di risveglio, un moto di risorgimento rispetto a questo scenario per nulla edificante. Le parole di EG sono talmente nette al riguardo che papa Francesco avverte il bisogno di chiarire che la sua non è la parola «di un nemico né di un oppositore». A lui interessa unicamente «fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità individualistica, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro passaggio su questa terra» (208).
Anche i preti, soprattutto i preti, sono chiamati ad inserirsi in questo difficile ministero di liberazione dei loro fratelli e delle loro sorelle (quando non anche di loro stessi) dalla mentalità dominante del successo, del godimento, della difesa del proprio interesse privato, dell’esclusione dei più deboli e dei meno dotati, che sta davvero producendo un’autentica desertificazione dell’umano, con ricadute negative praticamente su tutti.
Qui tocchiamo il punto più alto dell’evangelizzazione: il Vangelo è fonte di gioia in quanto è fonte di umanizzazione. Ci apre all’amore e ci libera da ogni chiusura egoistica che reca del male non solo agli altri ma anche a noi stessi. Il Vangelo ci libera da quel possibile male che possiamo fare a noi stessi, oltre che agli altri! E torna pure il tema della comunità e della comunione: la gioia è legata appunto all’esperienza di umanizzazione promessa e permessa dal Vangelo che ci libera dall’individualismo e ci libera per gli altri.
Certamente, tutto questo può apparire difficile e al limite delle nostre possibilità ed è per questo che al centro dell’immagine di prete che emerge dal cuore di papa Francesco si trova l’idea che…
Il prete che serve è un prete ferito dallo sguardo d’amore di Gesù
Senza un autentico incontro con il Signore Gesù, con il suo amore, con la sua misericordia per i nostri peccati, con il dono della sua salvezza, la missione dei cristiani, e quella dei preti in particolare, non avrebbe sufficienti garanzie di successo né di durata. Qui si trova il cuore della spiritualità di papa Francesco. Per questo è necessario per tutti lasciarsi affascinare da Gesù, lasciare che egli ponga il suo sguardo su di noi, che egli ci contempli, che egli tocchi la nostra vita e «ci lanci a comunicare la sua nuova vita!» (264).
Senza il legame di amicizia con Gesù, che si traduce concretamente nello stare davanti ai suoi occhi in contemplazione e nel continuamente meditare le sue parole e i suoi gesti, raccolti nel santo Vangelo, manca quell’entusiasmo, quella forza, che è il principio vero della comunicazione della fede: la Chiesa non cresce per proselitismo ma per «attrazione» (14, citando Benedetto XVI).
Qui, e solo qui, possiamo davvero realizzare la convinzione che chi segue Gesù diventa più uomo, perché nessuno è stato così umano come Gesù, e proprio qui possiamo trovare la forza per rinnovare la passione missionaria dei credenti e dei preti: attratti da Gesù, dal suo amore di misericordia, dalla carica di umanizzazione che ha il suo Vangelo, attraiamo a nostra volta verso Gesù, offrendo una comunità concreta in cui vivere in pienezza la nostra umana dignità.
Armando Matteo