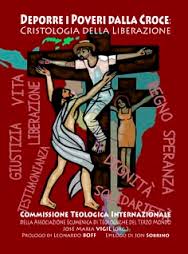il commento di p. E. Ronchi della diciassettesima domenica (29 luglio 2018) del tempo ordinario:
Giovanni 6,1-6
In quel tempo, Gesù (…) salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». (…) Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato (….).
C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci… Ma che cos’è questo per tanta gente? Quel ragazzo ha capito tutto, nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione: la prima soluzione davanti alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere. E allora: io comincio da me, metto la mia parte, per quanto poco sia. E Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di questo ragazzo, esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare la fame. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, quando a vincere è la legge della generosità. Poco pane condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece io tengo stretto il mio pane per me, comincia la fame.
«Nel mondo c’è pane sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente per l’avidità di pochi» (Gandhi).
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano, il pane non veniva a mancare; e mentre passava di mano in mano restava in ogni mano.
Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi dell’umanità, ma a indicare la direzione. Il cristiano è chiamato a fornire al mondo lievito più che pane (Miguel de Unamuno): a fornire ideali, motivazioni per agire, il sogno che un altro mondo è possibile. Alla tavola dell’umanità il vangelo non assicura maggiori beni economici, ma un lievito di generosità e di condivisione, profezia di giustizia. Non intende realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma dare un senso, una direzione a quei beni, perché diventino sacramenti vitali.
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti.
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. Noi non siamo i padroni delle cose. Se ci consideriamo tali, profaniamo le cose: l’aria, l’acqua, la terra, il pane, tutto quello che incontriamo, non è nostro, è vita che viene in dono da altrove, da prima di noi e va oltre noi. Chiede cura e attenzione, come per il pane del miracolo («raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto…e riempirono dodici canestri»), le cose hanno una sacralità, c’è una santità perfino nella materia, perfino nelle briciole della materia: niente deve andare perduto.
Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che ci mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si preoccupa: «La religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo: Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra (Evangelii gaudium 182)». Donaci Signore il pane, l’amore e la vita, perché per il pane, per la vita e per l’amore tu ci hai creati.