restare umani… oltre le paure
di Gruppo di preti del nord est*
in “www.centrobalducci.org”
la lettera di Natale 2016 per condividere esperienze, riflessioni, interrogativi, stanchezze, delusioni, speranze; per ridire la possibilità della fede in Gesù di Nazareth come orientamento di fondo della vita vissuta nelle comunità e oltre ad esse.
LE RELAZIONI UMANE
La dimensione e l’esperienza che continuiamo a vivere e a sentire come fondamentali sono le relazioni con le persone: l’attenzione, l’ascolto, la condivisione, la reciprocità. Complessità, disponibilità, dolori, speranze di tante storie ci coinvolgono, ci addolorano, ci comunicano profondità e ricchezze; ci danno la forza interiore di riprenderci e di continuare perché in questo intreccio di relazioni percepiamo la presenza di Colui che ci ha proposto di riconoscerlo nelle persone, soprattutto in quelle che esprimono fragilità, debolezze, ferite, senso di esclusione e di abbandono. Solo riconoscendo le nostre fragilità, debolezze, stanchezze possiamo incontrare in modo veritiero quelle altrui che favoriscono in noi la verità profonda su noi stessi. Questa costante esperienza quotidiana è collocata nella storia delle nostre comunità locali dalle quali, a cerchi concentrici che si dilatano, si apre la dimensione planetaria di un’umanità e di un ecosistema sempre più interdipendenti.
ALCUNE GRANDI QUESTIONI CHE CI PROVOCANO E CI INTERPELLANO
I migranti
Gli incontri, i dati, le nostre esperienze dirette, le riflessioni ci portano a considerare il fenomeno dei migranti non rilevante fra gli altri, bensì quello dirimente; la chiave di lettura interpretativa dell’attuale storia dell’umanità.
• Il fenomeno migratorio che ha sempre caratterizzato la storia, oggi ha assunto una caratteristica planetaria a partire dalla constatazione dei 65 milioni di persone, tanti i minori, che sono in cammino forzato sul Pianeta.
• I migranti ci rivelano le situazioni del mondo: la povertà, le violenze e la violazione dei diritti umani, le guerre, i disastri ambientali, il più delle volte provocati dal potere dei molti soldi nelle mani di pochi. Arrivando fra noi, i migranti ci rivelano chi sono: diversi per cultura e fede religiosa. Questa loropresenza ci provoca a liberarci dalla convinzione secolare che ha identificato il mondo con il “nostro” mondo e che ha indotto a considerare gli altri mondi comunque inferiori e quindi da poter dominare, opprimere e sfruttare.
• I migranti, allo stesso tempo, ci ricordano chi siamo stati. Il nostro mondo si chiama fuori dalle gravi responsabilità nella storia passata e recente nei loro confronti, come se loro stessi fossero causa dei loro esodi costretti. Volutamente, con ignoranza consapevole e colpevole, dichiariamo la nostra innocenza e con ipocrisia proponiamo, ora che arrivano da noi, di intervenire nei loro paesi per fermarne i flussi. Riflettendo sulle esperienze quotidiane di accoglienza, cercando di leggere la realtà, avvertendo la complessità di questa grande, dirimente questione ci sentiamo di dire che manca un progetto mondiale, europeo, italiano e regionale che assuma contemporaneamente due finalità: intervenire sulle cause strutturali delle forzate partenze e predisporre un piano di accoglienza e di inserimento nelle nostre società. L’Italia e la regione FVG rispondono in modo parziale alla prima accoglienza eppure, anche se arduo, sarebbe un compito indispensabile per non favorire indifferenza, paura, antagonismi e rifiuti.
• Interrogativi, perplessità e paure sono comprensibili, espressione di un contesto sociale, culturale, umano e religioso segnato da difficoltà personali e relazionali, economiche, etiche e politiche. Le paure, soprattutto, sono un vissuto da riconoscere e su cui riflettere; non sono da sminuire ed esorcizzare. Esigono risposte credibili. Molte situazioni di rifiuto che fanno capo a ideologie di stampo razzista non suscitano purtroppo indignazione perfino nel nostro mondo cattolico: si tratta di una situazione che ci interroga sul mutamento profondo del modo di pensare e di comportarsi.
• Non abbiamo la capacità di indicare progetti concreti di grande scala. Operiamo entro contesti ristretti, ma nel piccolo, per come ci è possibile, cerchiamo di vivere l’accoglienza delle persone che fanno fatica, senza distinzioni fra residenti e immigrati. Per quanto riguarda gli immigrati, riteniamo che lo Stato e la Regione dovrebbero orientarsi a progetti d’inserimento lavorativo in zone spopolate e abbandonate dove è necessaria la presenza di persone e un impegno lavorativo che riguardi l’ambiente, l’agricoltura, l’allevamento, la lavorazione dei prodotti; e questo coinvolgendo insieme italiani e stranieri. Si pensi, ad esempio, alle zone di montagna del pordenonese, della Carnia, delle Valli del Natisone. Ci permettiamo ancora di indicare la necessità dell’indispensabile e continua formazione culturale, etica, spirituale all’incontro e alla relazione con l’altro, con ogni altro: e questo nei vari ambiti e situazioni fra cui la scuola assume un’importanza particolare.
• Il fenomeno migratorio esige una considerazione globale sugli oltre 5 milioni di migranti che si sono inseriti, spesso con grandi sacrifici, nei decenni scorsi nel nostro Paese, arricchendoci culturalmente, demograficamente ed economicamente.

I poveri
I problemi reali nelle nostre città sono tanti e di varia natura. È paradossale che quello delle strade da “ripulire” dalla povera gente appaia il principale impegno da affrontare per un’amministrazione pubblica. Si sente parlare, per di più in maniera abbastanza clamorosa, di amministrazioni comunali che decidono (novelli Rudy Giuliani) di “fare pulizia” nella propria città. Ciò che più preoccupa, è che il termine venga riferito alla presenza ingombrante di gente ai margini, povera, indicata come mendicante, immigrata, che “importuna” con la questua, presenze scomode che “deturpano” (sic) i siti urbani più adatti a una presentazione della città in modo adeguato che a ospitare visioni… puzzolenti di gente che trascina la propria disgrazia, non raramente ostentata attraverso vere o false menomazioni.
Si amplificano le tinte, si esaspera la rappresentazione degli scenari: le amministrazioni reagiscono minacciando sanzioni, multe, repressione e non raramente forme di “deportazione urbana”. Le minacce si estendono dalla povera gente questuante agli occasionali donatori di elemosine che per vari motivi decidono di aiutare la persona in difficoltà. Senza negare che qualche provvedimento vada preso, crediamo sia giusto non minacciare in maniera plateale e spesso a scopi elettoralpropagandistici, ma farsi carico, in quanto amministrazione pubblica, del problema della povertà diffusa allo scopo di risolverlo. Far rispettare la legge e contemporaneamente rispettare la dignità delle persone: sono due doveri che non possono venire scissi. Leggiamo sempre più spesso che gli amministratori locali, per giustificare l’intervento repressivo, accampano la presenza di un vero e proprio racket alle spalle dei questuanti. Si tratta di fatti concreti o di voci che ad arte vengono amplificate per motivi anche elettoralmente non proprio nobili? Se la presenza criminale è accertata, l’Amministrazione Comunale, custode e garante della legalità, si rivolga alle forze dell’ordine, alla Procura della Repubblica, presenti formale e documentata denuncia dei fatti; non si accanisca contro l’ultimo anello della catena. La persona rimane tale e la sua dignità richiede di essere rispettata in tutte le circostanze soprattutto in quelle di maggior fragilità. I cristiani che in qualche modo aderiscono al messaggio evangelico, non possono dimenticare che Francesco, il vescovo di Roma, ha definito, in linea con il Maestro di Nazareth, che i poveri «sono la carne di Cristo». Una città che vuol spazzar via i poveri si troverà a breve impoverita dei valori che l’hanno, negli anni, caratterizzata. Certamente le povertà sono tante e diffuse: materiali, relazionali, culturali, economiche, etiche. Drammatiche sono le perdite del lavoro e la ricerca che non trova riscontri positivi. E questo ha ricadute preoccupanti sull’identità stessa e sul senso della vita delle persone.
La violenza
La violenza ci attraversa e può insinuarsi in noi e negli altri. Si esprime in modo implicito ed esplicito, brutale in parole, atteggiamenti, azioni anche nei confronti di chi si dichiara di amare. Avvertiamo l’importanza di studiare costantemente la dinamica della distruttività disumana che oggi trova eco ampia e incontrollata sui social media come facebook e di sollecitare e partecipare a processi educativi volti alla liberazione dalla aggressività con scelte di non violenza attiva, con parole, gesti e azioni di pace. La guerra è la massima manifestazione della violenza, la sua brutale e distruttiva organizzazione. Ricordiamo l’insegnamento chiaro ed esplicito di papa Francesco che finalmente ha liberato Dio da qualsiasi possibile utilizzo per legittimare la guerra e ogni forma di terrorismo.
Il rapporto con la Terra e con i viventi
L’Enciclica Laudato sii di Papa Francesco è un documento straordinario per denuncia, coinvolgimento, prospettiva, richiesta d’impegno: il mondo com’è organizzato ora è destinato alla morte! Il superamento dell’antropocentrismo, dell’assoluto della scienza e della tecnica, dell’onnipotenza della finanza diventa possibile con l’assunzione di un nuovo paradigma: quello della prossimità, del sentirci, cioè, parti vive di un unico sistema vivente in cui tutto e tutti sono in relazione. Esprimiamo il nostro dispiacere constatando che un testo così significativo – anche perché frutto del concorso e della collaborazione di tante persone competenti sia pressoché sparito dai progetti delle diocesi e delle parrocchie: speriamo non dai corsi di teologia. A nostro avviso questa Enciclica dovrebbe essere oggetto di studio e riflessione nelle scuole, con la mediazione soprattutto degli insegnanti di religione.
LA CHIESA NEL MONDO
La diminuzione drastica e inarrestabile dei preti dovrebbe sollecitare a percorrere altre strade, ad aprirsi ad altre possibilità con una decisione prioritaria, irrinunciabile che, ad enunciarla, potrebbe sembrare scontata, ma tale non è: quella del ritorno sine glossa, senza parentesi, adeguamenti, facilitazioni e scorciatoie al Vangelo di Gesù di Nazareth, alla rivoluzione del Vangelo, perché tale è, e a scelte di vita conseguenti come persone, come comunità, come Chiesa. Quale Chiesa, allora, nel momento dell’accorpamento delle parrocchie, delle decisioni sulle zone e sulle cosiddette collaborazioni pastorali? Ci pare che si sia perso tempo, con la chiusura nelle tradizionali ma presunte sicurezze clericali di essere sicuri, bravi ed efficienti. Si sono persi decenni senza promuovere e riconoscere il protagonismo attivo di donne e di uomini di fede disponibili e responsabili, di diaconi – donne e uomini – che oggi potrebbero assumere, senza essere pallide e conformiste controfigure del clero, compiti significativi di guida, animazione, coordinamento delle esperienze comunitarie. Avvertiamo ancora titubanze e freni anche rispetto alle celebrazioni delle comunità senza la presenza del prete; eppure si tratta di esperienze che sono vissute da decenni in migliaia di comunità in Africa, America Latina e altrove nel mondo. Pensiamo poi che le urgenze storiche sollecitino le convinzioni e le richieste che da decenni emergono dalla base delle comunità cristiane, uscendo da una visione clericale e separata del presbiterato: che i diversi ministeri nelle comunità siano diversificati in modo aperto e pluralista e che il ministero del presbiterato possa essere esercitato da uomini celibi, da uomini sposati nelle condizioni di poter essere ordinati, da preti che si sono sposati e a motivo della legge del celibato obbligatorio hanno dovuto lasciare il loro ministero ma sentono giusto e importante poterlo esercitare nuovamente; da donne ordinate prete. Soprattutto queste ultime potrebbero portare alla comunità, come tante di loro già fanno senza riconoscimento ufficiale, la ricchezza della loro diversità di genere. Questa Chiesa sarebbe più umana, più coinvolta nella vita delle persone, più credibile, certo sempre in stretto, continuo e vivo rapporto con Gesù e il suo Vangelo e con la fedele e coerente testimonianza.
CHI E CHE COSA PUÒ SALVARCI?
Coinvolti in questa situazione complessa e tribolata, in cui non mancano certo i segni di speranza che incontriamo nelle esperienze di sensibilità e di pratica del bene, ci chiediamo coinvolgendo anche voi nella domanda e nella ricerca di risposta: «Chi e che cosa potrà salvarci? Come, lentamente ma progressivamente, ne usciremo?». Il pensiero, la scienza, la tecnica sono stati straordinari, sono indispensabili e hanno contribuito e contribuiscono a tante situazioni umane positive. Guardando le situazioni drammatiche del mondo attuale dobbiamo però constatare che non ci salvano: non ci salvano dalla fame, dalle guerre, dalle migliaia di morti in mare, dalla distruzione dell’ambiente vitale. E questo, soprattutto, perché si sono configurate come concentrazione di potere, perseguendo un’illusione di onnipotenza e perché non hanno saputo convertire la ricchezza delle loro scoperte e realizzazioni al servizio umile e disinteressato del bene comune. Da questa indispensabile verifica etica escono giudicate molto severamente.

Potrà salvarci la fede?
La fede è fiducia e affidamento nel Dio di Gesù che ci salva: in una reciprocità gratuita di amore da Lui donato, da noi vissuto e comunicato agli altri. La fede può salvarci se noi, sentendoci salvati, portiamo segni di salvezza nella storia: «Il Regno di Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi», non in un aldilà di proiezioni consolatorie. L’apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, nella pagina definita “l’inno all’amore” conclude con un’espressione profonda, provocatoria e coinvolgente: «Ci sono quindi tre cose che contano: la fede, la speranza e l’amore, ma più grande di tutte è l’amore». La fede senza amore può diventare facilmente spiritualismo astratto, istituzione di potere, ritualismo vuoto. Solo l’amore sollecita la fede a farsi concreta prossimità, a incarnarsi nella storia per contribuire a renderla più umana. La speranza senza amore può essere illusione temporanea, volontarismo affannoso; l’amore rende consistente la speranza che, così, può esprimere parole e gesti di bene, riprendendo energia e forza interiore dopo sconferme, stanchezze e avvilimenti. L’esperienza ci insegna che la speranza rifiorisce quando incontriamo donne e uomini che, animati dall’amore, ci comunicano il bene che, entrando in noi, riavvia energie e dinamiche positive di vita. Accogliamo l’amore di Dio con gratitudine e con la disponibilità a condividerlo con gli altri; a ricevere la loro ricchezza umana e a comunicare la nostra. Con umiltà, amore, resistenza, pazienza attiva e perseveranza, continuiamo il nostro cammino con tutta l’umanità, attenti ai segni che incoraggiano speranza e apertura. Ne ricordiamo uno che può diventare esemplare. Una bambina di sette anni in un incontro pubblico a scuola racconta la sua esperienza; la mamma è cristiana e il papà musulmano; la invitano con serenità e delicatezza a cominciare a considerare la scelta fra le due religioni. Lei risponde che vorrebbe sceglierle tutte e due. Mamma e papà le dicono che non è possibile, mentre lei sente che può esserlo. Un’intuizione straordinaria, certo legata alla relazione affettiva con i genitori, ma che prospetta l’accoglienza della bontà dei principi ispiratori di religioni diverse e soprattutto la loro attuazione nella storia con la fedeltà e coerenza di vita.
* I preti firmatari: Pierluigi Di Piazza, Franco Saccavini, Mario Vatta, Pierino Ruffato, Paolo Iannaccone, Giacomo Tolot, Piergiorgio Rigolo, Renzo De Ros, Luigi Fontanot, Alberto De Nadai, Albino Bizzotto, Antonio Santini.
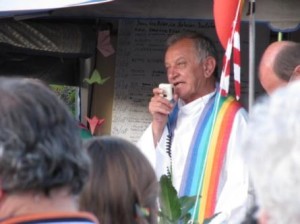



 Altre strade non ci sono. Chi prospetta i respingimenti come soluzione di entrambi i “problemi”, profughi e terrorismo – presentandoli per di più come legati, mentre non c’è maggior nemico del terrore di chi è fuggito da una guerra o da una banda di predoni – inganna sé e il prossimo. Un blocco navale per riportarli in Libia? Bisognerebbe conquistare anche tutta la costa libica, come ai tempi di quell’Impero che chi prospetta questa soluzione forse rimpiange. E poi gestire in loco i campi di concentramento; o di sterminio. O affidarsi a un accordo con le autorità locali, che per ora non hanno alcun potere né alcun interesse ad assumere un ruolo del genere se non lautamente retribuiti (come la Turchia). Per poi minacciare in ogni momento di aprire le dighe (come aveva fatto a suo tempo Gheddafi e come minaccia di fare Erdogan). Nel migliore dei casi le persone trattenute o “rimpatriate” riprenderanno la strada del deserto e del mare appena possibile. Nel peggiore… Riportare i profughi nei paesi di origine o di transito, posto che sia possibile costa carissimo: tra viaggio, Cie resuscitati col plauso dell’Europa, costo degli accordi, apparati polizieschi e giudiziari, più di quanto basterebbe per dare casa, istruzione e lavoro a ognuno dei profughi da rimpatriare. Infatti lo si fa con pochissimi. Agli altri a cui non si riconosce il diritto di restare, si consegna un foglio di via intimandogli di abbandonare il paese entro sette giorni: senza soldi, senza documenti, senza conoscere la lingua, senza alcuna relazione con la popolazione. Vuol dire metterli per strada, consegnarli al lavoro nero; o alla criminalità, allo spaccio e alla prostituzione; o, cosa da non trascurare, al reclutamento jihadista. L’appello a impossibili respingimenti crea solo illegalità, criminalità, terrorismo. I morti nell’attraversamento del deserto sono più di quelli (5.000 solo nel 2016) naufragati nel Mediterraneo. Ma gli uomini, le donne e i bambini che sopravvivono a quella traversata sono fatti oggetto di stupri, rapine, schiavitù e sfruttamento di ogni genere; o vengono imprigionati in locali al cui confronto Cona e Mineo sono Grand Hotel: affamati, maltrattati e umiliati in ogni modo. E’ questa la soluzione? Quella finale? Condannarli a una fine del genere è cosa di cui domani i nostri figli e nipoti ci chiederanno conto. E i popoli respinti anche: e in modo tutt’altro che delicato.
Altre strade non ci sono. Chi prospetta i respingimenti come soluzione di entrambi i “problemi”, profughi e terrorismo – presentandoli per di più come legati, mentre non c’è maggior nemico del terrore di chi è fuggito da una guerra o da una banda di predoni – inganna sé e il prossimo. Un blocco navale per riportarli in Libia? Bisognerebbe conquistare anche tutta la costa libica, come ai tempi di quell’Impero che chi prospetta questa soluzione forse rimpiange. E poi gestire in loco i campi di concentramento; o di sterminio. O affidarsi a un accordo con le autorità locali, che per ora non hanno alcun potere né alcun interesse ad assumere un ruolo del genere se non lautamente retribuiti (come la Turchia). Per poi minacciare in ogni momento di aprire le dighe (come aveva fatto a suo tempo Gheddafi e come minaccia di fare Erdogan). Nel migliore dei casi le persone trattenute o “rimpatriate” riprenderanno la strada del deserto e del mare appena possibile. Nel peggiore… Riportare i profughi nei paesi di origine o di transito, posto che sia possibile costa carissimo: tra viaggio, Cie resuscitati col plauso dell’Europa, costo degli accordi, apparati polizieschi e giudiziari, più di quanto basterebbe per dare casa, istruzione e lavoro a ognuno dei profughi da rimpatriare. Infatti lo si fa con pochissimi. Agli altri a cui non si riconosce il diritto di restare, si consegna un foglio di via intimandogli di abbandonare il paese entro sette giorni: senza soldi, senza documenti, senza conoscere la lingua, senza alcuna relazione con la popolazione. Vuol dire metterli per strada, consegnarli al lavoro nero; o alla criminalità, allo spaccio e alla prostituzione; o, cosa da non trascurare, al reclutamento jihadista. L’appello a impossibili respingimenti crea solo illegalità, criminalità, terrorismo. I morti nell’attraversamento del deserto sono più di quelli (5.000 solo nel 2016) naufragati nel Mediterraneo. Ma gli uomini, le donne e i bambini che sopravvivono a quella traversata sono fatti oggetto di stupri, rapine, schiavitù e sfruttamento di ogni genere; o vengono imprigionati in locali al cui confronto Cona e Mineo sono Grand Hotel: affamati, maltrattati e umiliati in ogni modo. E’ questa la soluzione? Quella finale? Condannarli a una fine del genere è cosa di cui domani i nostri figli e nipoti ci chiederanno conto. E i popoli respinti anche: e in modo tutt’altro che delicato.