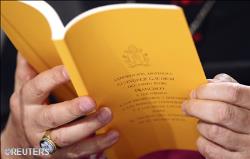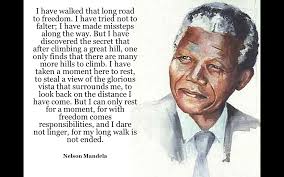La chiesa non può essere auto-referenziale, è “chiesa in uscita” (cfr. EG 24), perché la Parola di Dio chiama il credente, lo manda verso terre nuove, lo sprona ad andare verso l’altro (cfr. Gn 12,1-3; Es 3,10; Ger 1,7).
Dopo la sezione introduttiva, che presenta in un certo senso lo sfondo del suo programma pastorale, l’Evangelii Gaudium affronta in cinque capitoli alcune delle questioni più rilevanti per l’evangelizzazione oggi. La prima è quella di una trasformazione missionaria, la quale comporta una vera e propria riforma della chiesa (EG 19-49).
L’approccio di papa Francesco può essere spiegato ricorrendo alla categoria dello stile, studiata dalla riflessione teologica di Christoph Theobald, tra i principali interpreti del Vaticano II. Lo stile, a grandi linee, è la corrispondenza tra la forma e il contenuto. Perciò, una pastorale di evangelizzazione che assume una determinata fisionomia richiede, per realizzarsi, un volto di chiesa coerente con essa. È la medesima questione sottesa all’interpretazione del Vaticano II, il quale è stato un concilio pastorale e non convocato per definire delle dottrine. Per questo si è tentato di sminuirne l’importanza. Invece, la presa di coscienza di un nuovo rapporto tra la chiesa e il mondo contemporaneo, all’insegna del dialogo e dello scambio, piuttosto che dell’estraneità e della contrapposizione, implica anche una rinnovata comprensione della dottrina cattolica.
È importante identificare i riferimenti della conversione missionaria prospettata dal papa. Il più prossimo è il documento della conferenza dell’episcopato latinoamericano ad Aparecida nel 2007, ma il fondamento è costituito dalla visione di chiesa elaborata da Paolo VI a partire dall’enciclica Ecclesiam suam e sviluppata dal Vaticano II. Massimo Faggioli ha parlato di «riabilitazione pubblica di un magistero conciliare e post-conciliare».
Tornando al testo dell’esortazione, la missione è l’effetto della gioia del Vangelo che vuole comunicarsi. Non alla maniera del proselitismo, ma di una diffusione di sé che è farsi prossimo, coinvolgimento con chi si incontra alla maniera alla maniera del Signore. «Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: “Sarete beati se farete questo” (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quando duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di tenere conto dei limiti» (EG 24).
Non è una posizione ideologica o l’adeguamento a una moda. È lo stile di Gesù nel suo relazionarsi alle persone e accogliendole con le loro fatiche e i loro peccati, senza la pretesa di separare subito il grano dalla zizzania, con il rischio di perdere l’uno con l’altra. Così i cristiani non devono avere l’ansia di etichettare e giudicare le persone, bensì lasciare loro la possibilità della crescita, della piena maturazione. Devono anzi incoraggiarla.
Affinché questo avvenga, tutta la chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa per riconoscere che c’è una differenza tra come il Signore la sogna e la sua realtà storica: da qui scaturisce il bisogno di una riforma perenne dell’istituzione ecclesiale, che nasce dall’esigenza di fedeltà a Cristo e alla propria vocazione (cfr. EG 26; Paolo VI, Ecclesiam suam 10; Concilio Vaticano II,Unitatis redintegratio 6).
Il rinnovamento è ritenuto improrogabile da papa Francesco e dovrebbe trasformare ogni aspetto della vita ecclesiale (consuetudini, stili, orari, linguaggi, strutture…) in senso missionario, in vista di una pastorale più espansiva e aperta (cfr. EG 29).
Il punto di partenza è la parrocchia, che rimane la “prima linea” della missione, in quanto chiesa tra le case degli uomini (cfr. Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 26), a patto che sappia assumere con plasticità forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività del pastore e della comunità (cfr. EG 28). Bergoglio riconosce che il rinnovamento delle parrocchie è uno dei capitoli inattuati della riflessione ecclesiale recente. Per definire le parrocchie, egli ricorre alla terminologia delle “comunità di comunità”, ma a indicare che non devono essere grandi strutture anonime, ma comunione di realtà diversificate e vive, dove si sperimentano rapporti ravvicinati, si condivide il quotidiano e la ricerca di fede, si vive la fraternità.
In questo discorso s’inserisce il riferimento ai movimenti, ridimensionati rispetto all’enfasi di altri pronunciamenti, insieme ad associazioni e comunità di base, la cui originalità è vista in funzione dell’integrazione nella realtà parrocchiale e non per costituirsi come realtà parziali e separate (cfr. EG 29).
L’appello al rinnovamento è esteso alle diocesi e ai loro vescovi. A questi ultimi, in particolare, l’invito è a valorizzazione gli organismi di partecipazione e altre forme di dialogo per esercitare il proprio ministero di guida e sintesi a partire dall’ascolto di tutti e non da un assenso servile (cfr. EG 31).
Neppure il papato è esentato dal rinnovamento e qui abbiamo il fatto insolito di un pontefice che chiede suggerimenti al riguardo. Viene così recuperata la richiesta inevasa di Giovanni Paolo II di ripensare la forma di esercizio del ministero petrino (cfr. Ut unum sint, 95). L’enciclica si riferiva all’ecumenismo, ma implica, e l’esortazione lo specifica, di dare corpo alla collegialità stabilita dalla Lumen gentium: non il papa da solo, come un monarca, ma il papa insieme ai vescovi e alle conferenze episcopali, intese come veri e propri soggetti ecclesiali dotati anche di una qualche autorità dottrinale (cfr. EG 32). Questa potrebbe essere una reale decentralizzazione che darebbe corpo al pluralismo di una chiesa mondiale unita nella fede.
L’esortazione non offre indicazioni molto dettagliate per il rinnovamento, proprio perché intende attivare la corresponsabilità audace e creativa dei battezzati a tutti i livelli e non dettare ogni decisione dall’alto (cfr. EG 33).
Ciò che conta, vale la pensa di ribadirlo, è assumere lo stile evangelico. Il che per Bergoglio significa anche un annuncio che non si fissa su aspetti secondari, senza manifestare il cuore del messaggio di Gesù. «Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume una pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario» (EG 35). Richiamando il Vaticano II e ancora prima Tommaso d’Aquino, il papa ricorda che c’è una gerarchia delle verità in campo sia dogmatico sia morale, per cui va evidenziato quel che è centrale e dà significato a tutto il resto.
«Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi per ricercare il bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza!» (EG 39). Il centro è la fiducia nell’amore di Dio per noi che ci rende capaci di amare e ci salva.
È detto per chi riduce l’annuncio cristiano a messaggio etico e ne fa metro per giudicare gli altri; è detto per chi sbandiera la propria ortodossia, ma dice parole cristiane senza Cristo riducendole a un falso Dio o a un ideale umano. «In tal modo siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la sostanza» (EG 41).
Il Vangelo deve parlare oggi. La ricerca delle modalità di comunicare l’essenziale in un mondo che cambia richiede di armonizzare una varietà di visioni teologiche e pastorali, più che la difesa senza sfumature di una dottrina monolitica (cfr. EG 40). Tutto ciò incoraggia ad abbandonare norme e precetti non essenziali e non incisivi nel nostro tempo (cfr. EG 43), così da tenere conto della condizione reale delle persone su cui non si possono esercitare forme d’ingerenza spirituale. «Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza importanti difficoltà» (EG 44).
È una chiesa aperta, quella evocata dal documento, che invita a entrare e accoglie. «Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi» (EG 47). Vale in particolare per il Battesimo e l’Eucaristia che non sono riservati a una ristretta cerchia di perfetti, ma sono dono, cibo, medicina, sostegno… Una chiesa così privilegia i poveri, gli infermi, i disprezzati e li cerca anche a costo di essere accidentata e ferita, piuttosto che rinchiudersi nelle proprie sicurezza e nei propri procedimenti.
«Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiudersi nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranqulli» (EG 49).
Continua questa lettura, per me impegnativa ed entusiasmante, con cui sto cercando di presentare l’esortazione di papa Francesco e la sua importanza per il futuro della chiesa cattolica.
3
Se l’evangelizzazione è una sfida che mette in crisi le sicurezze del passato e richiede un rinnovamento della chiesa cattolica e della pastorale, è indispensabile comprendere le ragioni di questo passaggio travagliato. È questo l’argomento del secondo capitolo dell’Evangelii Gaudium (nn. 50-109), divisibile in due parti: la prima è un’analisi del nostro tempo e dei cambiamenti che interpellano il nostro stile ecclesiale (nn. 52-75), mentre la seconda è dedicata alle patologie che dentro la chiesa rendono poco credibile o efficace l’annuncio (nn. 76-109).
Papa Francesco è consapevole che in molti documenti ecclesiali c’è un eccesso di analisi, senza una corrispondente offerta di proposte adeguate. Egli infatti dichiara che non è suo compito offrire una lettura completa e dettagliata della realtà contemporanea ed esorta tutte le comunità cristiane a impegnarsi a propria volta nella lettura dei “segni dei tempi”. Questa espressione, proveniente dal Vangelo (cfr. Mt 16,2-3), è stata impiegata in particolare nella teologia francese del Novecento ed è divenuta ricorrente nel linguaggio di papa Giovanni XXIII, il quale se ne avvalse per descrivere le tracce nascoste della venuta del Signore nel mondo che solo lo sguardo di fede sa riconoscere. Uno sguardo che sa cogliere il positivo attorno a sé e non è condizionato da un pregiudizio di contrapposizione tra la chiesa e la modernità.
Non si tratta di elaborare interpretazioni sociologiche, quanto di operare un “discernimento evangelico” (EG 50), cioè saper leggere il proprio mondo e il proprio tempo con occhi allenati dall’ascolto della Parola e dalla preghiera. Più che emanare giudizi e direttive, bisogna riconoscere che cosa va nella direzione del Regno di Dio e che cosa no, che cosa ci rende più umani e che cosa invece ci disumanizza, a prescindere dal fatto che abbia o meno un’etichetta cattolica. Ecco perché la priorità di Francesco, nel descrivere la nostra epoca, è evidenziare gli effetti perversi di quella che definisce “cultura dello scarto”.
«Così come il comandamento “Non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e dell’iniquità”. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti di borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è iniquità» (EG 53).
Qui si chiarisce che cosa sia il male del relativismo: non è una sorta d’inferiorità etica di chi non condivide la visione del mondo cattolica, come spesso è stato inteso usandola quale arma dialettica nei dibattiti pubblici. C’è stato un uso di questo concetto tale per cui il disaccordo con l’etica cattolica è stato inteso come relativismo, come assenza di valori e del senso della verità e del bene. Papa Francesco presenta piuttosto il relativismo come non riconoscimento della persona umana e del suo volto, al punto da considerarla irrilevante, persino nella sua indifferenza.
Alla radice c’è un’idolatria del denaro, un nuovo dio a cui si offrono sacrifici umani: l’esclusione di molti per il benessere di pochi (cfr. EG 54-56). A tale proposito, ambienti conservatori, soprattutto negli USA, hanno accusato il papa di essere socialista. Appartiene a loro, invece, l’ideologia che fa diventare la crescita economica e l’accumulo di profitto un dogma, anche quando in suo nome si producono vittime. Il monito del papa è la denuncia di un’economia fine a se stessa per cui l’etica dimentica l’uomo invece di essere in suo favore. Non è un fatto di sistema politico o di partiti, ma di essere consapevoli del fine delle attività umane economiche e di governo.
«In tal senso, esorto gli esperti finanziari e i governanti dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio dell’antichità: “Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma loro”» (EG 57).
Sono parole di un padre della chiesa, Giovanni Crisostomo. Il discorso del papa va alla radice spirituale delle scelte economiche e politiche. la cultura dell’individualismo e della gratificazione istantanea suscita l’illusione di salvarsi per messo del denaro e del consumo, comprando il soddisfacimento dei propri bisogni. È un’assolutizzazione dell’eco che non sa più vedere l’altro uomo e Dio (cfr. EG 67).
La povertà degli esclusi crea le condizioni per il diffondersi di una violenza che non si risolve con l’ossessione per la sicurezza e le risposte armate, le quali non fanno altro che alimentarla. Il punto è cambiare un sistema che è ingiusto a partire dalla sua origine, la quale sta in una malattia interiore, una falsa visione del mondo e dell’uomo. Tutte le relazioni ne sono corrose, da quelle familiari a quelle civili.
In un contesto del genere, si rende necessario educare a una fede che non si limiti a pratiche esteriori, devozioni sentimentali, assolutizzazione di pretese rivelazioni private. Sarebbe un vissuto individualistico che si concentra sulla rassicurazione personale e su un miracolismo emozionale per cui ci si rinchiude in un proprio guscio separato dove ci si sente protetti. È una forma di indifferenza religiosa. Il papa auspica una vita ecclesiale e di fede che sappia intersecarsi con le culture che palpitano, si progettano e coesistono nelle nostre città ormai pluraliste.
Non è possibile giudicare e rifiutare tutto ciò che non appartiene alla tradizione. Si tratta piuttosto di abitare la città e le sue culture rendendo possibile nei tanti percorsi esistenziali una ricerca di senso, all’insegna della semina, e non di un’irrealistica e anti-evangelica riconquista.
«Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima della città» (EG 74). Il Vangelo non è un prodotto da collocare sul mercato o un’idea da propagandare; è una voce che dischiude all’uomo nuove possibilità di vita e di fiducia nell’incontro con ogni cultura e ogni percorso esistenziale. Nel Vangelo c’è un messaggio perenne che scalda il cuore, che risponde al desiderio di autenticità e vita buona presente in ogni fede, cultura e vicenda umana. Si tratta di farlo emergere, senza perdere le ricchezze della tradizione cristiana, ma anche senza ristagnare nell’immobilismo di pratiche e linguaggi più adatti ad altre epoche.
Affinché questo possa avvenire, l’esortazione passa in rassegna una serie di tentazioni a cui sono soggetti i cattolici impegnati nella pastorale per mettere in guardia contro di esse. Questo, però, non senza aver prima ricordato l’enorme apporto attuale della chiesa nel mondo d’oggi nei più diversi contesti di servizio gratuito all’uomo (cfr. EG 76).
La prima tentazione segnalata è il confondere la vita spirituale, che dovrebbe essere il fondamento dell’esperienza cristiana, «con alcuni momenti religiosi che offrono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno nel mondo, la passione per l’evangelizzazione» (EG 78).è il rischio di una religione su misura che diventa rifugio e gratificazione per l’io. Ad esso si ricollega quell’accidia che è la fatica a perseverare nei tempi lunghi, nella mancanza di risultati immediati a fronte di sogni irrealizzabili, nelle contraddizioni. Ne derivano un ripiegamento disimpegnato su se stessi e una riduzione della vita ecclesiale a grigio pragmatismo abitudinario che è all’opposto della gioia del Vangelo (cfr. EG 82-83). Ancora Francesco mette in guardia dal pessimismo sterile che immobilizza, perché “tanto è tutto inutile”, come già fece Giovanni XXIII aprendo il Concilio quando prese le distanze dai profeti di sventura che annunciano sempre il peggio e non vedono altro che rovine e guai (cfr. EG 84). Quando prevalgono questi atteggiamenti, manca allora un contatto vivificante con il Vangelo che alimenta nuove relazioni, nuove opportunità d’incontro e solidarietà, superando il sospetto e la sfiducia permanente (cfr. EG 87-88).
«L’isolamento, che è una versione dell’immanentismo, si può esprimere in una falsa autonomia che esclude Dio e che però può anche trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso individualismo. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni ambigui. Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di mola gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con l’altro» (EG 89).
La differenza tra vera e falsa spiritualità si coglie nella misura in cui l’esperienza di fede porta all’incontro, all’accoglienza, al farsi prossimi, al fare comunità.
Per gli stessi motivi, papa Francesco dice no alla mondanità spirituale, propria di chi cerca nella fede solo una conferma dei propri sentimenti o ragionamenti o di chi si sente superiore agli altri in forza della propria adesione a un certo stile cattolico del passato. Significa in definitiva contare su se stessi, sulla propria integrità religiosa, più che su Dio. «È una presenta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo a un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare» (EG 94). Bergoglio riserva le parole più dure non ai non cattolici, ma a quei cattolici che smentiscono il Vangelo mettendolo al servizio di se stesso.
Vale anche per la ricerca di potere dentro la chiesa o di conquiste sociali e politiche, alimentando la vanagloria e respingendo la profezia (cfr. EG 95-97). E così si perdono energie in illusori piani di espansionismo apostolico o in guerre contro altri fratelli di fede, fino ad assumere atteggiamenti persecutori, perché la diversità di idee mette in discussione l’ego di chi conta su se stesso e lo proietta sulla religione (cfr. EG 98-100).
Il secondo capitolo dell’EG si chiude richiamando alcuni soggetti ecclesiali a cui prestare particolare attenzione in una comunità cristiana che non si identifica con la gerarchia:
– i laici, che non assumono in pieno responsabilità importanti sia per mancanza di formazione sia per non aver trovato spazio nelle loro chiese particolari a causa di un eccesivo clericalismo (cfr. EG 102);
– le donne, i cui legittimi diritti derivanti dalla loro pari dignità «pongono alla chiesa domande profonde che la sfidano e che non si possono facilmente eludere» (EG 104);
– i giovani, che «nelle strutture abituali spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità, problematiche e ferite» (EG 105);
– i seminaristi, rispetto ai quali bisogna operare una selezione per escludere motivazioni legate a insicurezze affettive, a ricerca di forme di potere, gloria umana o benessere economico (cfr. EG 107).
Il capitolo si chiude con l’invito alle comunità a proseguire in queste riflessioni, mantenendosi sempre in una prospettiva di rinnovamento e di dinamismo fiducioso.
«Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piene di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria!» (EG 103).
4.
La terza parte dell’Evangelii Gaudium prende in esame le costanti dell’evangelizzazione, gli elementi irrinunciabili al di là dei contesti storici e geografici (nn. 110-175). È la sezione in cui mi sembra maggiormente presente il materiale elaborato durante il sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione del 2012. La mano di papa Francesco è meno evidente, mentre si cogli una certa disomogeneità, forse dovuta alla varietà dei contributi di cui si è cercato di fare sintesi
Al di là delle valutazioni personali, il tratto unificante e la chiave interpretativa del capitolo è il primato della proclamazione di Gesù Cristo in ogni attività di evangelizzazione (cfr. EG 110). Qui papa Bergoglio cita Giovanni Paolo II, dall’esortazione Ecclesia in Asia del 1999. Una delle caratteristiche del documento, infatti, è di citare ampiamente testi papali rivolti alle chiese dei cinque continenti insieme ai pronunciamenti di alcune conferenze episcopali. È un dettaglio in cui si coglie l’assunzione di uno sguardo ampio, abbracciando l’universalità della chiesa cattolica, senza rimanere circoscritto al punto di vista occidentale che dal Medio Evo fino al XX secolo ha pressoché monopolizzato il cattolicesimo nel bene e nel male. Secondo il gesuita Karl Rahner, il Concilio Vaticano II ha contrassegnato la transizione da una chiesa eurocentrica a una chiesa mondiale, un vero e proprio passaggio d’epoca paragonabile alle grandi svolte storiche e che ha incontrato forti resistenze.
Il capitolo è suddiviso in quattro parti. Nella prima il tema è il soggetto dell’annuncio: chi evangelizza? (cfr. EG 111-134). «L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio» (EG 111). Infatti, più avanti il papa sottolinea che ogni membro del popolo di Dio, in forza del Battesimo, è discepolo missionario, il che comporta un nuovo protagonismo di tutti i battezzati (cfr. Mt 28,19; EG 120).
Il presupposto è il legame tra la realtà profonda della chiesa e la comunione trinitaria. La chiesa non nasce per iniziativa solo umana, ma ha all’origine un sogno di Dio, una chiamata: c’è un primato della grazia che precede l’organizzazione umana (cfr. EG 112).
Dio non salva l’uomo isolatamente, ma convoca un popolo unito in una fraternità che oltrepassa le differenze sociali, religiose, nazionali (cfr. Gal 3,28; EG 113). «La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo» (EG 114). L’amore trinitario, che unisce nella diversità, si rivolge a tutti; il dono di Dio si incarna perciò nella cultura di chi lo riceve (cfr. EG 115).
L’evangelizzazione non è colonialismo culturale, per cui comporta una forma di assimilazione di chi ne è il destinatario, come è avvenuto in altre epoche. Essa avviene invece mediante inculturazione, per cui le diverse culture trovano posto nella chiesa e arricchiscono l’annuncio del Vangelo, perché contribuiscono ad annunciarlo in modo più ampio e completo (cfr. EG 116).
Le diverse culture sono depositarie della molteplicità dei doni suscitati dallo Spirito santo il quale realizza un’unità in cui non c’è uniformità, ma armonia multiforme.
«Sebbene sia vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio cristiano non si identifica con nessuna di esse e possiede un contesto transculturale. Perciò nell’evangelizzazione di nuove culture o di culture che non hanno accolto la predicazione cristiana, non è indispensabile imporre una determinata forma culturale, per quanto bella e antica, insieme con la proposta evangelica» (EG 117).
È l’umano a essere a immagine e somiglianza di Dio, è l’umano il luogo dell’incarnazione, non una particolare cultura. Farla coincidere con il cattolicesimo sarebbe limitare la ricchezza della Parola di Dio, sacralizzando viceversa un’opera umana. Da questo travisamento possono emergere vere e proprie forme di fanatismo.
Un aspetto dell’inculturazione sono le molteplici forme della pietà popolare che, se correttamente intese, diventano forme di accesso all’esperienza cristiana alla portata di tutti (cfr. EG 122-126). L’importante, osservo a titolo personale, è non assolutizzarle fino a renderle pesi o obblighi che allontanano altri. Si tratta di presentarle come risorse simboliche nel contesto della ricca varietà dell’esperienza cristiana. Così come, tornando all’esortazione, non vanno assolutizzare le formule con cui è annunciata la fede, dal momento che il Vangelo può essere espresso con le categorie (variabili nel tempo) proprie di ciascuna cultura (cfr. EG 129), e nemmeno i particolari carismi ecclesiali; questi ultimi, se sono suscitati dallo Spirito, non hanno bisogno di affermarsi a spese di altre spiritualità e doni (cfr. EG 130). È detto per gli ambienti ecclesiali che manifestano intolleranza per linguaggi ed esperienze diversi dai propri.
Anche il dialogo con le diverse scienze e la filosofia è indispensabile per l’inculturazione della fede e qui occorre il contributo dei teologi con la loro attività di ricerca (cfr. EG 132-134).
Ben due sezioni del capitolo sono dedicate rispettivamente all’omelia (cfr. EG 135-144) e alla sua preparazione (cfr. Eg 145-159). In effetti si tratta pur sempre del principale momento di contatto con la predicazione ecclesiale da parte delle persone. Eppure, risulta spesso poco efficace e significativa. Si sa quanto Bergoglio conti su questo momento: le sue omelie mattutine a Santa Marta sono seguite in tutto il mondo per la loro immediatezza. Certo, desta sorpresa il fatto che ci sia bisogno d’intervenire così intensamente su quella che è la più frequente modalità di comunicazione pastorale a motivo della problematicità in cui versa. È indice di una chiesa non ancora abituata a una comunicazione estroversi, come se ritenesse di avere ancora tutte le pecore nel proprio recinto, invece di preoccuparsi di raggiungerle.
Nell’omelia il prete non deve intavolare un monologo in cui mette in mostra se stesso, ma riaprire il dialogo tra il Signore e il suo popolo (cfr. EG 137), dischiudendo a quest’ultimo il tesoro della Parola. Appartenendo a un contesto liturgico, deve essere breve (cfr. EG 138) ed esprime la maternità accogliente della chiesa con la cordialità, la gestualità, la voce (cfr. EG 139).
È parola vitale, non comunicazione di servizio o lezione. Poiché la fede nasce dall’ascolto della parola di Cristo (cfr. Rm 10,17), l’omelia deve trasmettere il messaggio evangelico e non verità dottrinali o prescrizioni morali (cfr. EG 142-143). Questo non si improvvisa; richiede da parte del prete di dedicare tempo alla Parola, non semplicemente studiandola, ma accostandola con un cuore in preghiera. La preparazione dell’omelia è un’esperienza spirituale, prima che intellettuale. Altrimenti, si diventa come i farisei, deprecati da Gesù perché esigevano dagli altri senza essersi lasciati illuminare dalla Parola di Dio, non l’hanno contemplata, non l’hanno resa viva ed efficace prima di tutto in sé (cfr. Eb 4,12). Il predicatore non è una persona perfetta che si mette in cattedra, ma una persona che cresce nella sua vita interiore e nella sua umanità in quanto davvero ascolta la Parola e le è docile (cfr. EG 145-151).
Papa Francesco raccomanda il ricorso alla lectio divina, il tradizionale metodo monastico di lettura orante della Bibbia, al cui rilancio ha dato grande impulso Carlo Maria Martini, per cogliere il significato proprio del testo biblico insieme a quello che il Signore vuole dire al lettore tramite il testo. Dio rivolge a ognuno la sua parola (cfr. EG 152-153).
Ma non basta. «Il predicatore deve anche porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un predicatore è un contemplativo della Parola e anche un contemplativo del popolo» (EG 154). Non è un fatto di strategia, ma di sincera premura per le persone e di fedeltà allo stile di Gesù. Ciò richiede anche di prestare attenzione al linguaggio impiegato, alla semplicità, all’uso di immagini che coinvolgono l’ascoltatore, puntando sulla positività del messaggio (cfr. EG 156-159). Era così che Gesù comunicava, incontrando le persone nei luoghi della convivenza, recependo le loro domande e bisogni, aderendo alla concretezza e accendendo l’immaginazione con le parabole.
C’è una breve considerazione che non andrebbe sottovalutata: «Che cosa buona che sacerdoti, diaconi e laici si riuniscano periodicamente per trovare insieme gli strumenti che rendono più attraente la predicazione» (EG 159). Sarebbe un bel passo verso una chiesa meno clericale.
La quarta e ultima parte del capitolo (nn. 160-175) è dedicata all’annuncio delkerygma, cioè il primo annuncio e l’annuncio principale, «quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi» (EG 164). Ci si ricollega così ai nn. 34-36 con l’invito a concentrarsi sul cuore del Vangelo, sul suo nucleo fondamentale che è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. La risposta di fede a questo amore è l’amore del prossimo (cfr. EG 160). Se viene oscurato questo senso principale, tutto il messaggio cristiano viene alterato. È a partire dagli anni Trenta del XX secolo, con un libro dello storico della liturgia Joseph Jungmann, che si è reclamato un recupero del senso originario del Vangelo a fronte di una predicazione che si riduceva a esposizione dottrinale lontana dalla vita.
«La centralità del kerygma richiede alcune caratteristiche dell’annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna» (EG 165).
L’esortazione fa riferimento anche alla catechesi mistagogica, che coinvolge tutta la comunità in un cammino di formazione progressivo in cui sono valorizzati i segni liturgici (cfr. EG 166), e alla “via della bellezza”, la quale richiede di trovare nuovi segni e simboli per esprimere l’annuncio al di là del linguaggio concettuale ricorrendo a forme non convenzionali di bellezza che oggi hanno una particolare efficacia comunicativa (cfr. EG 167).
L’annuncio è un percorso personale che richiede accompagnamento, un’arte della vicinanza, del saper suscitare domande e stimolare alla ricerca (cfr. EG 169-173). Ci vogliono padri e madri nella fede, persone affidabili e autorevoli, ma anche rispettose, che non esercitino un’ingerenza spirituale, perché sanno che l’altro è una “terra sacra” davanti a cui togliersi i sandali (cfr. Es 3,5). L’accompagnamento può rendere possibile l’esperienza di vede, ma non deve forzarla o determinarla; non è e non può essere il conformarsi a uno schema scandalizzato, è unica per ciascuno.
La Parola di Dio come fonte e fondamento dell’evangelizzazione è richiamata in chiusura del capitolo (cfr. EG 175-176). La chiesa evangelizza solo se si lascia prima continuamente evangelizzare dalla Parola, la quale dovrebbe stare al cuore di ogni attività ecclesiale. Trovo un punto debole del documento aver posto solo a questo punto un tema di tale importanza.
Parola e sacramento; mensa della Parola e mensa eucaristica sono un tutt’uno nell’alimentare il cammino di fede, ma lo spazio della prima è ancora limitato nell’esperienza ordinaria dei credenti, nonostante la fine del suo esilio grazie al Vaticano II con la Dei Verbum.
«Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale che la Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede. L’evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le organizzazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante personale e comunitaria» (EG 175).
5.
«L’ideologia marxista è sbagliata. Ma nella mia vita ho conosciuta tanti marxisti buoni come persone, e per questo non mi sento offeso».
Questa frase di papa Francesco, nell’intervista su La Stampa del 15 dicembre 2013, ha fatto il giro del mondo. Il riferimento è alle polemiche sollevate da alcuni ambienti conservatori, per lo più statunitensi, che lo hanno accusato di essere marxista per le sue prese di posizione in materia sociale, soprattutto nel quarto capitolo della Evangelii Gaudium (nn. 176-258). Da sempre, il Vangelo è una contestazione del potere e della ricchezza iniqua, ma quando lo si ricorda ci sono reazioni di rifiuto proprio da parte di chi corteggia la chiesa cattolica sui temi etici. È un fatto che dovrebbe far ricordare come non si possa identificare la fede cristiana con l’adesione a un’ideologia politica o economica.
Il capitolo dedicato alla dimensione sociale dell’evangelizzazione è il più esteso dell’esortazione apostolica, a dimostrazione di quanto il tema stia a cuore al papa. I paragrafi iniziali ne spiegano le motivazioni.
Alla radice c’è il contenuto sociale del kerygma, del primo annuncio, perché nel Vangelo sono essenziali la vita comunitaria e l’impegno con gli altri (cfr. EG 177). Poiché Dio è Trinità, comunione di amore, ci ha voluti e ci ama in comunione, insieme: da soli non c’è vera umanità, da soli non c’è salvezza.
Comprendere che siamo amati gratuitamente da Dio ci apre a dare e ricevere amore nei rapporti con gli altri (cfr. EG 178). «La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno di noi» (EG 179; cfr. Mt 25,40). La vita di Dio è “uscita da sé” verso l’altro, e solo nell’uscire da noi stessi realizziamo pienamente la nostra vita, perché non ci rinchiudiamo nella stagnazione e nell’isolamento.
Si parla, beninteso, di un amore concreto, che non ha nulla di sentimentale. Quando Gesù annunciava il regno di Dio, faceva riferimento a un’umanità che sa vivere in giustizia, fraternità, pace, dignità per tutti (cfr. EG 180). Ecco perché la chiesa cattolica non può accontentarsi di insegnare dottrine, ma deve essere esperienza di immersione in tutto ciò che è umano.
Da qui deriva la partecipazione dei credenti e dei pastori al confronto pubblico, in nome dell’uomo e non per acquisire una rilevanza sociale, per contribuire alla costruzione di un mondo migliore e non per esercitare un’egemonia etica (cfr. EG 182-183). Il punto di riferimento è l’insegnamento sociale della chiesa cattolica, ma con una specificazione decisiva: «né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio dell’interpretazione della realtà ecclesiale o della proposta di soluzione per i problemi contemporanei. Posso ripetere qui ciò che lucidamente indicava Paolo VI: “Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre una soluzione di valore universale. Del resto non è questa la nostra ambizione e neppure la nostra missione. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese”» (EG 184; cfr. Paolo VI, enciclica Octogesima adveniens, 4).
Qui c’è una chiesa che si pone come voce dei senza voce, per richiamare i grandi principi della dignità umana, ma allo stesso tempo rinuncia a porsi come autorità sovralegislativa che pretende di determinare norme e decisioni. Non c’è un ordine politico ed economico che si può dedurre dal messaggio cristiano nel quale trovare la risposta a tutte le problematiche sociali.
La chiave di lettura della dimensione sociale dell’evangelizzazione è l’assunzione del punto di vista dei poveri, l’ascolto del loro grido come fa il Dio biblico (cfr. EG 187; Es 3,7-8,10). Le ideologie dominanti escludono i soggetti deboli, si costruiscono sull’indifferenza. La solidarietà cristiana corrisponde perciò a una nuova mentalità, la cui logica è quella della comunità, della priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni (cfr. EG 188). Le conseguenze pratiche sono di vasta portata. Il papa, infatti, ricorda qui la funzione sociale della proprietà e la destinazione sociale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata, come affermato già dai padri della chiesa (cfr. EG 189).
È un principio che ha una radice spirituale, da cui deriva un vero e proprio cambio di prospettiva nella vita sociale ed economica e richiede trasformazioni strutturali nelle relazioni tra le persone e tra i popoli: «il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità» (EG 190) ed è pertanto necessario intervenire sulla iniqua distribuzione dei beni, del reddito e delle opportunità di accesso all’educazione, all’assistenza sanitaria e al lavoro (cfr. EG 191-192).
Da questo punto di vista, sbaglia chi tenta di minimizzare questo discorso presentandolo in chiave di appello a ricordarsi dei poveri, tralasciando però di mettere in discussione il sistema che produce quella stessa povertà. La carità viene così circoscritta a un’elemosina che affronta le emergenze e tranquillizza la coscienza, ma lascia i poveri nella loro condizione. La predicazione cristiana ha spesso indebolito e tralasciato il significato diretto ed eloquente della tradizione biblica e patristica sui temi della fraternità e della giustizia, preferendo concentrarsi su un messaggio religioso in senso stretto: «Non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino di vita e di sapienza. Perché “ai difensori dell’ortodossia si rivolge a volte il rimprovero di passività, d’indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia intollerabili e verso i regimi politici che le mantengono”» (EG 194; cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, istruzione Libertatis nuntius, 18). Questo avviene per il contagio alienante della mentalità consumistica che distoglie dal volto dell’altro (cfr. EG 196).
Se assumere il punto di vista dei poveri corrisponde allo stile di Dio che manifesta una speciale predilezione per loro e si è fatto povero e servo per tutti noi, la chiesa deve assumere un’opzione per i poveri: essere chiesa povera e per i poveri che sa anche imparare da loro, lasciarsi evangelizzare, dal momento che la loro condizione gli permette di accedere a una propria sapienza nel conoscere Dio e la realtà fuori dal condizionamento illusorio del benessere (cfr. EG 198). Tornano qui le istanze maturate negli anni del Vaticano II attorno a personalità come Helder Camara e Giacomo Lercaro, a lungo lasciate nel silenzio, e che hanno dato impulso all’elaborazione della teologia della liberazione. Senza l’opzione per i poveri, l’annuncio del Vangelo è svuotato di significato (cfr. EG 199).
Sul piano della posizione della chiesa nel confronto pubblico, ciò si traduce in una contestazione dell’iniquità che è alla radice di tutti i mali sociali e si deve all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria: il profitto per il profitto, il primato del profitto sulla persona, è il nome di questa iniquità (cfr. EG 202).
«Quante parole sono diventate scomode per questo sistema! Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Altre volte accade che queste parole diventino oggetto di una manipolazione opportunista che le disonora» (EG 202).
Non si può confidare solo sulle forze cieche del mercato, anche perché di per sé non esistono. La realtà è fatta di relazioni che possono rispondere solo a criteri di potere e interesse, oppure essere in qualche modo orientate e regolate. È il compito della politica, che declina la carità a misura del bene comune, a patto che sappia assumere uno sguardo più alto del tornaconto personale, delle lotte di parte e dei calcoli elettorali (cfr. EG 204-206). Tutto ciò non può essere ignorato dalle comunità cristiane, se non vogliono cadere preda di una mondanità spirituale mascherata da pratiche religiose e discorsi vuoti (cfr. EG 207).
Papa Francesco chiude questa sezione del capitolo segnalando alcune fragilità di cui avere particolarmente cura ai nostri giorni: i migranti, da accogliere nella ricerca di nuove sintesi culturali, le vittime delle tratte, le donne che in quanto tali sono doppiamente svantaggiate, i nascituri, senza dimenticare le situazioni che spingono molte madri a cercare l’aborto, e l’insieme del creato di cui siamo custodi (cfr. EG 209-216).
Un altro aspetto della portata sociale del Vangelo è il suo essere seme di pace, a patto di intenderla non solo come assenza di conflitti, che può avvenire quando un parte si impone sulle altre (cfr. EG 217-218). La pace è una condizione per il conseguimento del bene comune, quando scaturisce dallo sviluppo integrale di tutti. Altrimenti, non si fa altro che creare i presupposti di nuove forme di violenza, come attesta la storia recente (cfr. EG 219).
Bergoglio propone quattro principi, ispirati alla dottrina sociale della chiesa, per la costruzione di una convivenza pacifica orientandosi tra le tensioni che attraversano la vita della società (cfr. EG 221).
- Il tempo è superiore allo spazio: significa lavorare a lunga scadenza, senza dare la precedenza ai risultati immediati e preoccupandosi di iniziare processi, più che occupare spazi (cfr. EG 222-225).
- L’unità prevale sul conflitto: quest’ultimo non va ignorato ma accettato, a patto di trasformarlo in anello di collegamento a un nuovo processo che conservi tutti i beni in gioco (cfr. EG 226-230). L’esperienza di Mandela in Sud Africa mi sembra un ottimo esempio.
- La realtà è più importante dell’idea: le elaborazioni concettuali aiutano a comprendere meglio la realtà, ma non possono adattarla a forza nei propri schemi, o degenerano in ideologie (cfr. EG 231-233).
- Il tutto è superiore alla parte: vuol dire saper riconoscere e perseguire il bene più grande che porta benefici a tutti e tiene conto di tutti (cfr. EG 234-237).
«L’evangelizzazione implica anche un cammino di dialogo» (EG 238). È la sezione finale del capitolo (nn. 238-257) che torna su una delle grandi svolte del Vaticano II: in una società pluralista la chiesa deve essere capace di un dialogo aperto e senza preconcetti. Non per strategia, ma perché è un’espressione intima e indispensabile della fede cristiana, come ha sottolineato Francesco scrivendo al giornalista Eugenio Scalfari.
È la questione, ancora da approfondire e sviscerare, del valore teologico del dialogo. L’esortazione indica varie soglie, che ripercorriamo brevemente.
L’annuncio del Vangelo della pace (cfr. Ef 6,15) è il dialogo consistente nella collaborazione con le autorità nazionali e internazionali in vista del bene comune (cfr. EG 239). Entro uno Stato e una società particolari è dialogo con le diverse forze sociali, proponendo con chiarezza i valori fondamentali dell’esistenza umana, ma senza pretendere di risolvere tutte le singole questioni (cfr. EG 240).
C’è poi il dialogo con la ragione e con le scienze, con cui la fede non si sente in opposizione, come ricerca di nuovi orizzonti del pensiero nel rispetto reciproco (cfr. EG 242-243).
Il dialogo ecumenico è un apporto all’unità della famiglia umana, cogliendo come un dono quello che lo Spirito ha seminato nei fratelli separati (cfr. EG 244-246).
Tra le altre religioni, un posto speciale ha l’ebraismo, la cui Alleanza con Dio non è mai stata revocata, e con cui esiste una ricca complementarietà nella lettura dei testi biblici in comune con la tradizioni cristiana (cfr. EG 247-248). Nel rapporto con ogni religione, l’ascolto reciproco può essere occasione di purificazione e arricchimento, che non si oppone all’evangelizzazione, ma ha particolare importanza la relazione con l’Islam: è importante assicurare la libertà dei cristiani vittime del fondamentalismo violento, distinguendolo dal vero Islam e da un’adeguata interpretazione del Corano che si oppone a ogni violenza (cfr. EG 247-253). In ogni religione si trovano canali suscitati dallo Spirito che incoraggiano il cammino verso Dio (cfr. EG 254).
Infine, c’è il dialogo che nasce dalla vicinanza con tutti i ricercatori sinceri di verità, bontà, bellezza e giustizia, anche se non si riconoscono in una fede religiosa, in cui si possono mettere in comune le rispettive scoperte (cfr. EG 257).
6.
Il capitolo finale dell’Evangelii Gaudium (nn. 259-288) a una lettura superficiale può apparire addirittura superfluo. In un documento del magistero che aspira a dare l’avvio a una conversione pastorale in senso missionario e a un rinnovamento di tutta la chiesa cattolica, potrebbe fare la figura di un allungamento del brodo. Non ci sono infatti orientamenti, proposte, prospettive che guardano alla concretezza. Eppure, è un capitolo indispensabile e determinante.
Pochi anni fa, Enzo Bianchi lanciava un allarme sullo scollamento tra realtà ecclesiale e vita spirituale: «Oggi, l’ambito ecclesiale non è più sentito come scuola che introduce all’arte della “vita in Cristo”: la chiesa è divenuta sempre più ministra di parole etiche, sociali, politiche, economiche, e sembra aver smarrito l’uso del suo messaggio proprio… È invalsa l’idea che la vita cristiana corrisponda a un impegno sociale, a uno stile di vita genericamente altruista, tanto che la “vita ecclesiale” è ormai sinonimo di attività organizzativa e pastorale, non di luogo capace di iniziare alla vita umana e spirituale». In questo modo la trasmissione della fede diviene un atto catechetico, nel senso deteriore di insegnamento dottrinale, più che iniziazione a un’esperienza autentica di conoscenza del Signore nella fede.
La spiritualità degenera perciò in una sua declinazione intimistica e individualistica che è in realtà spiritualismo. Il rinnovamento della chiesa viene così reso evanescente. C’è chi dice che le strutture non sono decisive, perché la vera riforma è interiore. Però, questa diventa una scusa per non cambiare mai nulla. Francesco è deciso nel respingere lo spiritualismo intimista (cfr. EG 262): questa religiosità disincarnata è all’opposto della fede cristiana in cui Gesù è narrazione del Dio che abita l’umano. Ci deve essere invece corrispondenza tra vissuto spirituale e vissuto ecclesiale. È una vita trasfigurata dalla presenza di Dio, dall’azione del suo Spirito, a evangelizzare, non le parole (cfr. EG 259).
Impegno e preghiera stanno insieme; azione e contemplazione sono i due poli tra cui si situa l’esistenza cristiana. «Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività» (EG 260).
Nel capitolo sono presentate alcune motivazioni e suggerimenti spirituali. Nonostante sia il più breve del documento, è quello che contiene il maggior numero di riferimenti biblici (circa un quarto del totale). Non è il papa in quanto autorità che parla; bensì il credente in ascolto della Parola di Dio, il peccatore a cui il Signore ha guardato, come lui si definisce nel dialogo con Antonio Spadaro. I tentativi di collocare Bergoglio nello schema “conservatori-progressisti”, per “arruolarlo” dalla propria parte, risentono di una visione di chiesa intesa come luogo di lotta e di potere. È in fondo lo stesso errore degli apostoli che, durante l’ultima cena, discutevano su chi di loro fosse il più grande (cfr. Lc 22,24-27). Ogni autentica fedeltà alla tradizione e ogni autentica riforma della chiesa non sono altro che docilità al Vangelo. È da lì che nascono i più importanti gesti e parole di questo papa. C’è una “trama evangelica” nella quale sono intessuti.
Il punto di partenza è il credere all’amore (cfr. 1 Gv 4,16), che non è un generico senso di fascino e timore sacro per Dio. Dio nessuno l’ha mai visto (cfr. Gv 1,18; 1 Gv 4,12); è l’uomo Gesù che ci ha raccontato il suo amore: l’evangelizzatore è un contemplativo del Vangelo, lì ha trovato una fiducia fondamentale che lo umanizza, la orienta a una vita rinnovata (cfr. EG 264).
Il cristiano che evangelizza, perché prima si è lasciato evangelizzare, è colui che ha assimilato lo stile di Gesù, l’unità profonda della sua persona e della sua esistenza. Papa Francesco sembra aver recepito la riflessione teologica di Christoph Theobald in cui questa intuizione è sviluppata e che presenta il cristianesimo come stile.
«Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale» (EG 265).
Era l’arte educativa di Gesù: mettersi a questa scuola significa cercare quel che lui cerca, amare quel che lui ama e corrisponde alle nostre più originarie e profonde necessità umane (cfr. EG 265-267). Tutta la sua vita è stata un “uscire da sé” verso gli altri, a cominciare dal guardarli con attenzione e amore. «Il donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza» (EG 269). È ponendosi alla sequela del Signore che i cristiani si riconoscono come popolo e sono fedeli alla terra, solidali con tutti gli uomini di cui condividono gioie e speranze, tristezze e angosce, nell’impegno comune per la costruzione di un mondo migliore (cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 1).
Nel rapporto con il mondo, perciò, i cristiani non guardano l’altro dall’alto in basso; sono invitati a rendere ragione della propria speranza con dolcezza e rispetto, vivendo in pace con tutti (cfr. 1 Pt 3,16; Rm 12,18), non come nemici che puntano il dito e condannano. «Questa non è l’opinione di un papa, né un’opzione pastorale tra altre possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni» (EG 271).
Per Francesco tutto nella chiesa, anche il ministero del papa, richiede innanzitutto fedeltà al Vangelo. È detto per chi sacralizza l’istituzione e la gerarchia facendoli diventare fine piuttosto che strumento. E anche per chi vede l’essere cristiani come contrapposizione al mondo e alla storia che sono invece benedetti da Dio, mentre la Scritture respinge in realtà la mondanità, la mentalità anti-evangelica che Gesù condannava con parole dure rivolte proprio agli uomini religiosi.
La mentalità religiosa del sacro tende alla separazione, la logica del Vangelo, invece, all’incontro. «Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera la felicità degli altri. Questa apertura del cuore è fonte di felicità, perché “si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35). Non si vive meglio fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivisione, se si resiste a dare, se ci si rinchiude nella comodità. Ciò non è altro che un lento suicidio» (EG 272). Ognuno è degno di attenzione, indipendentemente dal suo aspetto, dalle sue capacità, dalle sue convinzioni (cfr. EG 274).
È un atteggiamento libero, gratuito, senza calcoli e senza pretese, che non guarda anzitutto al risultato, anche a costo i patire il fallimento e l’incomprensione perché si fonda sulla fede nel Signore che è risorto, passando però per la morte (cfr. EG 275).
La fiducia del cristiano è paziente, tenace, non conta su un potere della chiesa, ma sulla forza umile e nascosta del Regno di Dio che è come il seme che cresce senza che dipenda dal contadino, come il lievito che fa fermentare la pasta, come il grano che cresce in mezzo alla zizzania. I segni ci sono, ma sono visibili solo allo sguardo contemplativo della fede, educato dalla preghiera (cfr. EG 278-279).
Gli altri sono portati dentro lo spazio della preghiera: lo sguardo contemplativo non li vede come avversari o come terra di conquista, ma li porta nel cuore (cfr. Fil 1,7), intercede per loro, rende grazie per loro (cfr. EG 281-282). La mentalità mondana cerca di possedere l’altro e di dominarlo, altrimenti lo vuole eliminare; la mentalità evangelica vede l’altro come un dono per cui ringraziare.
L’icona biblica di queste disposizioni spirituali è Maria, che è madre della fede, a cui è dedicato il finale dell’esortazione (nn. 284-288). Un’icona femminile in una chiesa in cui ha prevalso l’impronta maschile e che dovrebbe invece acquisire uno stile mariano. Quel che più conta per Maria non sono privilegi, prodigi, opposizioni, presunte rivelazioni, bensì l’atteggiamento spirituale che ha contraddistinto la sua vicenda, tutta intrecciata con quella del suo figlio e Signore.
«Ella è la donna di fede che cammina nella fede. (..) Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un destino di servizio e fecondità. (…) In questo pellegrinaggio di evangelizzazione non mancano le fasi di aridità, di nascondimento e persino di una certa fatica, come quello che visse Maria negli anni di Nazaret, mentre Gesù cresceva» (EG 287).
Maria donna della terra, dunque, di una fiducia vissuta nelle contraddizioni della sua storia, prima che donna del cielo. A lei Francesco si rivolge, al termine del documento, presentando la svolta che attende la chiesa.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne (EG 288).