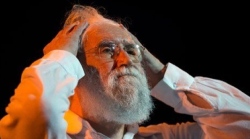è importante diffondere il testo ampio, denso e stimolante, che contiene le risposte al ‘questionario sulla famiglia’, approvato dalla Comunità Pastorale di Saronno. Una pastorale della famiglia, non per la famiglia, e alla luce del vangelo: oltre il familismo e l’esaltazione acritica della famiglia, che hanno dannosamente segnato in tempi recenti la vita della comunità ecclesiale
Una pastorale della famiglia, non per la famiglia
Risposte alquestionario
di Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA, SU MANDATO DELLA DIACONIA E DEL CONSIGLIO
PASTORALE, ALLE DOMANDE FORMULATE NEL DOCUMENTO PREPARATORIO DELLA III ASSEMBLEA
GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI
Premesse generali
Le risposte alle domande formulate nel documento
Le sfide pastorali sulla famiglia nelcontesto dell’evangelizzazione sono elaborate a partire da alcune considerazioni metodologiche.
Si avrà cura di evitare un’ottica particolaristica e settorializzata. Da una parte, cioè, non si
considererà solo la famiglia in sé, ma all’interno dell’intera Comunità ecclesiale. D’altra parte econseguentemente, non si considererà il
settore della ‘pastorale familiare’, ma le sfide sulla famiglia
poste all’intera pastorale della Chiesa nel suo complesso. Con questo approccio comunitariocomunionale
complessivo, cioè pienamente e globalmente ecclesiale, si eviteranno visioni
parcellizzate, da atomismo pastorale o da compartimenti stagni: la Chiesa non è una federazione di
singole famiglie e la famiglia non si vede nella Chiesa come un’isola in un arcipelago.
La pastorale familiare non può più essere considerata come un settore a parte della
programmazione della comunità ecclesiale, ma è essa stessa ossatura portante del ministero di
evangelizzazione della Chiesa: dall’ottica
della famiglia, e non per la famiglia, va impostata la
pastorale nel suo insieme.
La stessa nuova metodologia, che prepara il Sinodo dei Vescovi con un itinerario ‘sinodale’
che coinvolge l’intero Popolo di Dio, muove da questa impostazione comunionale complessiva e la
sollecita.
Così la famiglia viene vista all’interno dell’annuncio della salvezza: della Buona Novella di
Gesù; dunque nella grande e fondamentale prospettiva della liberazione evangelica. Dalla
liberazione evangelica si ricavano le linee essenziali e prioritarie di una pastorale di misericordia;
all’interno di tali linee si mettono a fuoco le sfide sulla famiglia, operando il discernimento sui
vissuti storici reali, cioè leggendo i segni dei tempi, per una pastorale incarnata nella storia del
Popolo di Dio e in grado di avviare nuovi processi storici di evangelizzazione e di liberazione:
liberazione dal peccato e dalle conseguenze del peccato, solidificate in strutture di ingiustizia e di
male sociale.
Questo approccio ha conseguenze ovvie anche sul piano dei riferimenti magisteriali
preminenti, che non sono più solo quelli dei documenti dedicati alla famiglia (
Gaudium et Spes 48,
Humanae vitae
e Familiaris consortio) o i nn. 1601-1658 e 2331-2391 del Catechismo, ma sono
anche i documenti sul mistero della Chiesa (
Lumen gentium), l’intero insegnamento sociale
pontificio, il magistero sull’evangelizzazione (dalla
Evangelii nuntiandi alla Evangelii gaudium).
Si vuole altresì evitare il rischio del
familismo cioè di un’esaltazione totale ed acritica
dell’istituto familiare (che dimentica che il matrimonio e la famiglia possono essere anche ostacoli
all’accoglimento del Vangelo e delle vocazioni cristiane e che, sul piano storico, sono stati spesso
luoghi di oppressione delle libertà personali). Tale rischio non è puramente ipotetico, perché si è
visto anche recentemente – e all’interno della comunità ecclesiale – che un familismo ideologico è
stato brandito come bandiera identitaria per mobilitazioni politiche o parapolitiche di istanze
ecclesiali in quanto tali, alla ricerca di (improbabili e, comunque, fragili) egemonie sociali e
politiche.
L’urgenza nella formulazione delle risposte – con il conseguente poco tempo per la loro
elaborazione – impedisce che si possano avviare nuove analisi statistiche e sondaggi diretti e mirati.
Si sono utilizzati pertanto i dati raccolti e le relative riflessioni sviluppate in occasione
dell’itinerario saronnese (2011-2012) di preparazione al VII Incontro mondiale delle Famiglie
(Milano, 30 maggio-3 giugno 2012) e successivi approfondimenti collegiali condotti all’interno
della Commissione Famiglia della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno.
La metodologia della stesura di questo testo ha seguito il seguenteiter (il più comunitario
possibile, dati i tempi stretti): sulla base dei dati e delle riflessioni sopra citate, si è stesa una prima
bozza, che è stata mandata a tutti i membri del Consiglio Pastorale e della Commissione Famiglia
cittadina. Le osservazioni pervenute sono state integrate nel testo. In alcuni casi (Parrocchia di S.
Giuseppe: gruppo delle famiglie), vi è stato un confronto di approfondimento. Vi è stato infine un
incontro di lavoro della Commissione Famiglia cittadina (con la partecipe presenza della Coppia
responsabile della Commissione decanale). Tutte le osservazioni raccolte sono state integrate in una
redazione finale, inviata ancora a tutti i membri del Consiglio Pastorale.
Nn. 8 e 1: Sul rapporto tra famiglia e persona e Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia
In coerenza con quanto già affermato sul piano metodologico, si è pensato di rispondere,
congiuntamente, alle domande formulate al n. 8 (Sul rapporto tra famiglia e persona) e al n. 1(
Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia) per
evitare un’impostazione astrattamente dottrinale, deduttivistica, apodittica e dogmaticamente
assertiva. Non è questo, ci pare, che viene richiesto al Sinodo. Si tratta di crescere nell’intelligenza
della Parola di Dio e del dogma, per avere formulazioni più comprensibili e risposte più adeguate
alla vita reale del Popolo di Dio, praticando quellaggiornamento auspicato dal Beato Giovanni
XXIII e che ha animato il Concilio Vaticano II (principale orientamento magisteriale, nella lettera e nello spirito).
Si deve allora osservare, con un sintetico ancorché necessario sguardo storico, che negli anni
’50 e ’60 (fino all’avvio degli anni ’70) del secolo scorso, nel periodo cioè che è stato definito “l’età
dell’oro del capitalismo”, vi sono stati un grande sviluppo economico – in Italia si è realizzato il
cosiddetto “miracolo economico”, che proprio a Milano ha trovato uno dei suoi centri – nonché lostrutturarsi del
Welfare State, cioè di politiche sociali solidaristiche e di redistribuzione del reddito,
che hanno fatto crescere l’area dei ceti medi e diffuso il benessere. Ciò ha portato, progressivamente
(e contemporaneamente allo sviluppo della paleo-televisione, a indirizzo fortemente pedagogico),
ad un cambiamento dei costumi di vasta portata: si sono, così, avuti, tra l’altro, una maggiore
soggettivizzazione dei vissuti matrimoniali, una più sensibile attenzione alla libertà e ai diritti della
persona e all’uguaglianza di genere, una critica neo-femminista della oppressione maschilista e
della mercificazione della donna, una diversa valutazione della sessualità, meno sottoposta al
controllo sociale e meno univocamente intesa come finalizzata alla procreazione. Tali cambiamenti
di costume, unitamente allo sviluppo della democratizzazione, hanno portato pure, tra l’altro,
all’introduzione del divorzio nella legislazione italiana e, successivamente, alla depenalizzazione dell’aborto.
Se non sono mancati, alla fine degli anni ’60, estremismi neo-marxisti diffusi a livello
giovanile (peraltro presto sconfitti nella loro utopia rivoluzionaria) o istanze minoritarie di
radicalismo libertario borghese (che intendeva l’aborto come “un diritto civile” e non, secondo gli
indirizzi di altri femminismi pure laici, come una dura realtà indubbiamente negativa, ma che non
poteva essere penalmente sancita), se sono lentamente riemerse antiche forme di materialismo
pratico ed è andata crescendo una nuova cultura del consumismo, tuttavia i cambiamenti di costume
e di mentalità hanno propiziato, tra i cattolici, l’accoglimento prima del magistero conciliare (con il
definitivo superamento della visione del matrimonio come “rimedio alla concupiscenza”) e poi del
rinnovamento pastorale avviato da Giovanni Paolo II, per la completa eliminazione di residui
manichei e sessuofobici e per un accoglimento positivo della sessualità umana, in sé e non solo nel
suo fine procreativo. Sono invece emerse quasi subito – anche senza considerare fenomeni di
contestazione e di dissenso ecclesiale – difficoltà nell’accoglimento pieno e completodell’insegnamento dell’Humanae Vitae.
Si può ritenere che questa enciclica abbia svolto, per
qualche tempo, una non trascurabile funzione positiva per richiamare alla responsabilità
sull’importanza evangelica di una visione non banalizzata e semplificata dell’amore umano di
coppia. In ogni caso, se, sul piano teologico, si è tempestivamente osservato che, per quanto
riguardava le indicazioni di specifici ‘metodi’, si trattava di doctrina reformabilis (Rahner), sul
piano della ‘base’ si è progressivamente prodotto quello che è stato definito uno “scisma sommerso”
(Prini), con una indifferenza di massa delle coppie cattoliche alle indicazioni, date dall’enciclica
montiniana, sui metodi anticoncezionali.
Dagli ultimi decenni del Novecento a questo avvio del XXI secolo la situazione complessiva
è profondamente mutata. La globalizzazione neoliberale ha, da una parte, esaltato l’individualismo
(e le relative espressioni sul piano della mentalità e dei costumi) e, dall’altra, ha segnato l’egemonia
non tanto di un relativismo nichilista quanto piuttosto di un materialismo pratico (con l’assunzione
solo di ciò che è materialmente sensibile e godibile come valore-guida dei comportamenti):
abbiamo, così, una “società materialista, consumista e individualista” (Francesco,Evangelii gaudium, n. 63, ma cfr. anche nn. 80, 99).
Queste profonde trasformazioni culturali, sociali, etico-comportamentali hanno
accompagnato una ideologia economica, che presto ha dominato su ogni ideologia politica e che ha
imposto una ‘deregolamentazione’ del mercato, una assolutizzazione del profitto, una proliferazione
incontrollata della speculazione finanziaria, un progressivo smantellamento delWelfare State, una
crescita delle diseguaglianze (cfr. Benedetto XVI,Caritas in Veritate, nn. 25, 32, 35, 36, 40, 45;Francesco,
Evangelii gaudium, nn. 52-59). Dobbiamo dunque dire che “il sistema sociale edeconomico è ingiusto alla radice”
(Francesco,Evangelii gaudium, nn. 59, 202).
La ‘colonna sonora’ di questa età del neoliberismo aggressivo è stata data dalla neotelevisione,
cioè dal dominio del codice comunicativo della televisione commerciale (che si è
imposto anche sulla televisione pubblica, smantellandone ogni intento ‘pedagogico’): esaltando
l’edonismo, la banalità volgare, la reificazione del corpo e della sessualità e popolarizzando una
subcultura fondata sui ‘valori’ delle tre esse (sesso, soldi, successo). Vi è stata così, negli ultimi
decenni, una complessiva mercificazione simbolica (e non solo) del sesso e una pornografizzazione
antropologica delle culture di massa (televisive, ma soprattutto ormai telematiche), dei linguaggi,
dell’immaginario sociale: con la tendenziale sparizione dell’erotismo, con il fragilizzarsi della
profondità psicologica delle relazioni amorose, con l’interdizione simbolica della dialettica
desiderio-legge.
Come fenomeno globale, il neoliberalismo ha travolto ogni residuo di totalitarismo, ma
anche ogni orizzonte universale di senso e di verità e ogni ipotesi razionale di trascendimento
migliorativo del sistema sociale dato, leggendoli come ideologie superate, come Grandi Narrazioni,
tipiche del Moderno: andando, invece, verso il post-ideologico e il Post-moderno.
Si è trattato di uno tsunami culturale, che ha devastato i vissuti e generato un disastro
antropologico di lunga durata. Sul piano sociale, oltre a provocare povertà nel Sud del mondo e
conseguenti movimenti migratori verso Nord di ‘masse di persone disperate’, questi decenni, con il
loro sbocco finale nella crisi (prima finanziaria, poi economica, infine sociale), hanno ripolarizzato
la società, assottigliato l’area dei ceti medi e del benessere, ridotto in povertà molte famiglie. Più in
generale hanno reso difficile ai giovani porre le premesse (di reddito e di abitazione) per una vita
familiare. Hanno indotto incertezza e pessimismo sul futuro: sia della propria vita privata sia della
società nel suo complesso.
Il rapporto famiglia-lavoro si è reso drammatico: difficoltà di occupazione per i giovani,
crescente disoccupazione per i lavoratori, aumento delle forme di lavoro precario, insicurezza delle
condizioni lavorative (con incidenti sul lavoro, anche gravi), aumento stressante dei tempi di lavoro
(durante la giornata, nella settimana, nell’anno e nella vita).
I decenni di accentuato individualismo hanno fatto entrare ‘in sofferenza’ ogni legame
sociale disinteressato: da quello tra i coniugi nella comunità domestica a quello tra educatori ed
educandi in ogni agenzia educativa (si veda il fenomeno del burn out), da quello tra militanti di
partito ed elettori a quello, in qualche misura, tra clero e laicato (o tra operatori pastorali e fedeli)
nella comunità ecclesiale. Pertanto “La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte
le comunità e i legami sociali. […] L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile
di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura i vincoli
familiari” (Francesco,Evangelii gaudium, nn. 66-67).
La nuova cultura diffusa ha reintrodotto, in dosi massicce, il maschilismo, ha emarginato il
femminismo (laico e cattolico), ha incentivato la reificazione della donna e della relazione sessuale,
ha assottigliato la profondità del sentimento morale e della forza di carattere, ha determinato una
infantilizzazione pulsionale con l’inibizione dell’autocontrollo adulto, ha visto pertanto crescere
esponenzialmente la violenza sulle donne – commessa soprattutto all’interno del contesto familiare
– e perfino i casi di femminicidio. Ciò è doppiamente grave quando si innesta su problematiche di
povertà (cfr. Francesco,Evangelii gaudium, n. 212).
Così “Nel caso di culture popolari di popolazioni cattoliche, possiamo riconoscere alcune
debolezze che devono ancora essere sanate dal Vangelo: il maschilismo, l’alcolismo, la violenza
domestica” (Francesco, Evangelii gaudium, n. 69). Perfino la piaga della pedofilia ha una sua realtà
di dramma domestico e di patologia familiare, come pure “l’abuso e lo sfruttamento di minori,
l’abbandono di anziani e malati, varie forme di corruzione e di criminalità” (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 75).
Complessivamente i fronti critici, le morfologie della sofferenza e gli universi attraversati
dalla difficoltà e dal dolore, della famiglia e nella famiglia, sono molto cresciuti. Il neoliberalismo
aggressivo – oggi meno culturalmente arrogante, a causa della crisi – rimane una solida e radicata
struttura sociale di peccato che ostacola la liberazione evangelica, anche – o soprattutto –
nell’ambito dei vissuti familiari reali.
La nuova situazione multiculturale e multireligiosa, creata dai movimenti migratori, peraltro,
se ha sollecitato egoismi localistici e chiusure xenofobe, cioè sentimenti e atteggiamenti
antievangelici (vergognosi in un popolo, come quello italiano, che è stato per decenni di emigranti:
come mostra, tra l’altro, la vicenda familiare dell’attuale pontefice), ha pure suscitato – nella
comunità ecclesiale – spinte all’accoglienza e alla solidarietà e ha comportato, comunque,
un’inevitabile evoluzione civile e istituzionale verso l’interculturalità e la laicità inclusiva e interreligiosa.
Tuttavia, ancorché minoritari e spesso dissimulati, non sono mancati casi in cui la
mentalità xenofoba e ostile alle famiglie straniere ha fatto breccia anche nella comunità ecclesiale,
autogiustificandosi come difesa delle ‘tradizioni cattoliche’ e costituendo un ulteriore ostacolo alla
liberazione evangelica e alla piena ricezione dell’insegnamento della Chiesa.
Peraltro la trascrizione politica del neoliberalismo ha preso in Italia (a partire proprio da
Milano), per un lungo periodo, ormai ventennale, forme di leaderismo che giustificavano ed
esaltavano la “subcultura delle tre esse”, trovando sponde in alcuni settori apicali della comunità
ecclesiale, con incomprensione (o perfino scandalo) di alcuni fedeli e con il disorientamento di
molti. Sembrava che nella Chiesa ci fosse una ‘dissonanza cognitiva’ tra gli insegnamenti di etica
familiare e la giustificazione di politici evidentemente in controtendenza rispetto a tali
insegnamenti: eppure presentati come difensori della famiglia (cioè dell’ideologia familista) e più o
meno apertamente fiancheggiati da istanze ecclesiali. Se si vuole avere un quadro non omissivo,
non omertoso (e perciò colluso) né edulcorato di ciò che si è prodotto nella Chiesa italiana nel
recente passato e di come ciò abbia inciso (e continui a incidere) sull’azione pastorale ed educativa
della Chiesa stessa rispetto alle famiglie e ai giovani, non si può avere paura di dire con chiarezza
queste cose. Naturalmente non si tratta di fare politica, ma di analizzare le sfide pastorali, notando i
guasti provocati da scelte queste sì politiche o filo-politiche del recente passato.
La Chiesa cattolica, in questi decenni, si è comunque complessivamente impegnata a
resistere a tale ondata neoliberale: è questo peraltro un terreno in cui si possono mettere a frutto
convergenze ecumeniche, intese inter-religiose e dialogo con uomini e donne di buona volontà. C’è
da osservare, comunque, che questi poderosi processi di globalizzazione neoliberale aggressiva
hanno trovato altri oppositori, così che non si può dire che visioni universalistiche (come quelle
dell’ONU, dell’UNESCO e dell’UNICEF), da una parte, e movimenti a sfondo etico, come quelli
no-global o degli “indignati”, dall’altra, abbiano avuto una rilevanza storica trascurabile.
Nella Chiesa di Milano, poi, il magistero del card. Martini, prima, con il richiamo al primato
della Parola e ai nuovi ‘stili’ di evangelizzazione, e quello del card. Tettamanzi, poi, con un piano
pastorale in tre tempi mirato proprio sulla famiglia (e con l’istituzione di un Fondo di Solidarietà
per aiutare le famiglie in difficoltà), hanno indicato le vie per un vero rinnovamento pastorale
complessivo, a partire dalla famiglia, coadiuvati dall’impegno del compianto don Silvano Caccia.
Naturalmente non si può dire che la realtà pastorale ambrosiana, anche guardando dal limitato punto
di vista saronnese, si sia subito e profondamente rinnovata: l’attuale situazione è diseguale per
parrocchie e, anche in generale, presenta luci e ombre. Ma, ancorché molto ancora si possa fare,
complessivamente un cammino ben documentabile è stato compiuto: e si tratta di un cammino
positivo.
Nella diocesi è cresciuta una partecipazione dei movimenti di spiritualità familiare e delle
coppie all’impegno di testimonianza e di evangelizzazione. La scelta da parte del card. Tettamanzi
di porre a capo dell’Ufficio Famiglia diocesano, accanto a un sacerdote, una coppia di sposi è stata
profetica e indicativa di un cammino da perseguire nel coinvolgimento dei laici in primo piano per
tutto ciò che concerne la famiglia. Lo schema di una triade (coppia e sacerdote) si realizza anche a
livello zonale nella diocesi e dovrebbe costituire un modello efficace per la pastorale familiare.
Riguardo alla conoscenza del Magistero della Chiesa sulla famiglia, bisogna constatare che è
generalmente considerato come un insieme di testi per “gli addetti ai lavori” o per preti: scritto in un
linguaggio tecnico-teologico, si pensa che non sempre aiuti a cogliere ed approfondire le ragioni di
una fede matura e dell’amore cristiano, nonché la profonda dimensione liberatrice del sacramento
del matrimonio.
Tra i fattori culturali che ostacolano la piena ricezione del Magistero si percepisce una
distorta idea di Chiesa: giudicante, chiusa, lontana dalla realtà, che non valorizza l’amore umano e
la sessualità. Forse queste distorsioni sono state generate da catechesi rimaste ad un livello infantile
e non elaborate, nonché da chiusure negli atteggiamenti pastorali e nella stessa predicazione.
Occorrerebbe forse uno sforzo, da parte dei Pastori, per una formulazione più aggiornata, più
‘esistenziale’, più calda del discernimento ecclesiale sui vissuti reali (che vanno conosciuti meglio):
per parlare ai cuori e alle coscienze dei giovani e delle giovani di oggi, ben consapevoli, peraltro,
“che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede
cristiana” (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 70).
Una corretta catechesi su quanto Cristo e la Chiesa dicono sul matrimonio va perseguita in
tempi di molto precedenti alla fase pre-matrimoniale, all’interno di una crescita umana e spirituale
delle nuove generazioni.
N. 2: Sul matrimonio secondo la legge naturale
I concetti di “natura”, “natura umana”, “diritto naturale” oltre al tema dei rapporti tra natura
e cultura sono oggi molto dibattuti sul piano scientifico e accademico e varie posizioni (anche in
ambito cattolico) si confrontano. Se questioni attinenti la biosfera, i suoi equilibri e le sue leggi,
sono ben vive, il tema del diritto naturale sembra invece abbastanza in ombra (anche fra cattolici al
giusnaturalismo si preferisce il giuspersonalismo). I dibattiti sulla bioetica, sul rapporto corpotecnica,
sulla ‘biopolitica’ sono molto accesi, ma difficilmente mettono capo a esiti unanimemente
condivisi e forti sono anzi le contrapposizioni.
Non pare molto utile affrontare la riflessione pastorale da questo punto di vista. In anni
recenti si è pensato che il Post-moderno (cioè il volto ideologico del neo-liberalismo, come si è
detto) fosse un totalitarismo nichilista al quale bisognasse opporre, in modo rigido e totale, un
‘totalitarismo’ ideologico alternativo: ci riferiamo alla centralità dei cosiddetti principi o valori “non
negoziabili” (prevalentemente riferiti alla bioetica come oggetto e al diritto naturale come
approccio).
Purtroppo il Post-moderno (e il neo-liberalismo che lo sorregge) non è un totalitarismo
ideologico, ancorché sia capillarmente invasivo delle coscienze, bensì la decostruzione preventiva e
perenne in forma neo-scettica (ma in realtà fondata sul materialismo pratico) di ogni totalitarismo,
anche sui generis, di ogni approccio ideologico compatto e rigido, di ogni progetto culturale con
pretese egemoniche: “si tratta piuttosto di una diffusa indifferenza relativista, connessa con la
disillusione e la crisi delle ideologie verificatasi come reazione a tutto ciò che appare totalitario”
(Francesco,
Evangelii gaudium, n. 61). Dunque anche il meta-discorso intransigente sui “principi
non negoziabili” è stato rubricato a maschera di interessi lobbistici e come tale metabolizzato e, di
fatto, reso innocuo, irrilevante, marginale: roba da Convegni.
La strada da seguire non può ancora porsi secondo questo schema astratto e deduttivo, ma –
al contrario – deve partire dai vissuti e dalle loro contraddizioni, cioè dalle sofferenze causate dalle
ingiustizie sociali, morali, culturali e psicologiche. A questo fine può essere più coerente una
rilevazione delle mentalità diffuse e delle prassi.
In questo senso, allora, si può dire che nelle etiche diffuse, se pure non compare
consapevolezza di un “diritto naturale”, vi è un’avvertita sensibilità verso i diritti della persona (di
fatto intesi come diritti universali ed universalistici, non declinati cioè in senso comunitaristico). Si
può ricordare, a questo proposito, un’espressione di don Milani che, quando citata, riscuote, oggi
più di ieri, un vasto consenso del sentire popolare cattolico: “c’è una legge che gli uomini non
hanno ancora ben scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell’umanità
la chiama legge di Dio, l’altra parte la chiama legge della Coscienza. Quelli che non credono né
all’una né all’altra non sono che un’infima minoranza malata. Sono i cultori dell’obbedienza cieca”.
Non è molto presente, invece, il “naturalismo”. Non riscuote cioè consenso, tra cattolici,
quel naturalismo, a base di fondamentalismo biblico (come nei Testimoni di Geova), che rifiuta –
per esempio – le trasfusioni di sangue. Ma non è neppure significativamente diffuso quel
naturalismo di origine roussoviana (condannato da Pio XI nellaDivini Illius Magistri) che considera
la natura buona in sé e accetta solo pratiche ‘naturali’ (Rousseau, per questo motivo, rifiutava la
contraccezione): una versione contemporanea potrebbe essere vista nelle posizioni da New Age, ma
con scarsi echi nel mondo cattolico (almeno da noi).
Nella mentalità cattolica popolare si assume, implicitamente, che la natura sia ‘corrotta’ e
che pratiche ‘artificiali’ (come quelle mediche o terapeutiche in senso lato o igienico-profilattiche)
vadano accolte senz’altro dalle famiglie e dai singoli, quando necessarie alla salute fisica e psichica.
La tematica della “legge naturale” riferita alla famiglia richiama pure il principio di
solidarietà e quello di sussidiarietà: molto presenti nel più recente insegnamento sociale della
Chiesa e applicati non sempre in modo coerente da gruppi e esponenti cattolici. Si segnala che – a
livello generale e anche locale – un’enfatizzazione univoca della ‘sussidiarietà’, slegata dalla
‘solidarietà’ (a cui dovrebbe essere sempre, necessariamente, connessa: cfr. Benedetto XVI,
Caritasin Veritate , n. 58), ha portato ad una diffusione surrettizia, in ambito cattolico, di approcci
neoliberisti o privatistici, secondo logiche di interesse di gruppi particolari e non di bene comune.
Appare invece urgente un forte rilancio della solidarietà – come valore e come prassi – verso le
famiglie e tra famiglie. Peraltro sembra molto esigua una applicazione del ‘principio di
sussidiarietà’ nel rapporto tra famiglie cattoliche e comunità ecclesiale nel suo insieme: solo un
maggiore sviluppo e radicamento dell’ecclesiologia conciliare potrà ovviare a questa lacuna.
A proposito di “legge naturale” (e considerando il livello “istituzionale, educativo e
accademico” a cui si riferisce la domanda 2a), si può fare un’ultima considerazione sulla cosiddetta
“questione del genere” (e del rapporto tra “sesso” e “genere”). Nel dibattito culturale sembra
prevalere una sterile polarizzazione e contrapposizione tra opposti estremismi: tra chi sostiene una
visione tutta e totalmente culturale, basata solo sul “genere” (appunto inteso, unicamente, come
costruzione culturale e volontaria), e chi si attesta su una visione tutta e totalmente fisicistica, basata
solo sul “sesso” (inteso come determinato dalla immodificabile struttura cromosomica
dell’individuo). Al posto di questi ideologici
aut aut, sarebbe preferibile un più sereno e ponderato
approccio
et et: che consideri sia le questioni della psicologia dello sviluppo, nel legame corpopsiche,
sia quelle sociologiche, più culturaliste, relative al rapporto dell’individuo con l’ambiente.
N. 3: La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione
Lo sviluppo della pastorale familiare nella Diocesi ambrosiana, con gli episcopati di Martini
e di Tettamanzi, in sintonia con il
Direttorio di Pastorale Familiare dei Vescovi italiani (e con i
documenti dei Vescovi lombardi) e con l’Ufficio Famiglia della CEI, ha portato a consolidare
esperienze ecclesiali importanti.
I risultati di maggior rilievo possono ritenersi: i Corsi di preparazione al matrimonio e la
diffusione dei gruppi familiari. Più recentemente sono state avviate – e sembrano rilevarsi
promettenti – proposte pastorali di percorsi pre e post-battesimali, rivolte alle famiglie e, in
particolare, ai coniugi (in genere giovani adulti).
I Corsi (o meglio Percorsi), con la loro vastissima diffusione (e nonostante un qualche
leggero declino quantitativo), rappresentano la maggiore iniziativa ‘missionaria’ della Chiesa
locale: si ha cioè la possibilità di accostare per un certo numero di incontri – non altissimo, ma
neppure insignificante – coppie di giovani adulti che, pur dicendosi cattolici, hanno, per la gran
parte, affievolito o abbandonato ogni rapporto significativo con la Comunità ecclesiale e hanno
un’esperienza, meno che saltuaria, di partecipazione all’eucaristia domenicale. Si tratta di
un’occasione importante di ‘secondo annuncio’ che si cerca di sviluppare al meglio. Non mancano,
ovviamente, i problemi. La Commissione per la Pastorale familiare (della Comunità Pastorale di
Saronno) sta riflettendo sulle forme più adeguate per rispondere alle sfide che i Percorsi pongono: a
cominciare dal problema della relazione, successiva al matrimonio, tra le giovani famiglie e la
Comunità ecclesiale. Si può comunque già osservare che la sempre più frequente richiesta del
matrimonio da parte di battezzati non praticanti deve essere accolta con misericordia e come
un’opportunità per risvegliare una fede accantonata, ma ancora viva. Si dovrebbero pertanto
studiare proposte realistiche di ‘secondo annuncio’ specificamente mirate a tali situazioni, in
appoggio agli attuali Percorsi.
I gruppi familiari – nell’ambito di movimenti di spiritualità familiare o a dimensione
parrocchiale (e secondo le indicazioni del Direttorio di pastorale familiare) – sono oggi una realtà
importante, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello dell’impegno, per l’intera Diocesi
ambrosiana (come i Convegni zonali del 2008 hanno dimostrato) e, più particolarmente, per la
nostra Comunità Pastorale e per il Decanato di Saronno.
Tali gruppi sono realtà nati spontaneamente da coppie di sposi desiderosi di avere un
cammino spirituale che si moduli con le esigenze della vocazione matrimoniale, in comunione con
altre coppie, con o senza la presenza di un prete. Nella diversità dei metodi adottati, delle tematiche
e degli eventuali sussidi, vale per tutti che questa realtà potrebbe costituire una forma nuova di
evangelizzazione, che ha luogo non più negli ambienti ecclesiali, ma nelle case, dove la fede “si
incarna”. Tali esperienze, che spesso non hanno vita breve, ma durano anche dopo la vedovanza,
costituiscono inoltre una forma di testimonianza verso i figli, che
vedono i genitori dedicarsi a
momenti di riflessione e preghiera, in spirito fraterno, liberamente e responsabilmente.
In qualche parrocchia della Comunità Pastorale saronnese si stanno sperimentando pure
percorsi di giovani coppie che si sono conosciute durante il corso fidanzati. Promossi inizialmente
dal parroco e da una coppia-guida, vengono poi portati avanti da qualche coppia giovane più
sensibile e disponibile.
A lato di queste esperienze, ancorché in sinergia con esse, si colloca la proposta dei ‘gruppi
di ascolto’ (rilevante in alcune parrocchie della Comunità Pastorale).
Considerando il ‘progetto’ complessivo espresso dal magistero della Chiesa (dal Concilio
alla
Familiaris Consortio ai documenti della CEI, a cominciare dai Piani pastorali decennali e dal
Direttorio
) e la sua reale attuazione, emerge un dato più evidente. Se gli aspetti che considerano la
famiglia come ‘oggetto’ della pastorale hanno visto un reale sviluppo e esperienze positive, in quelli
in cui la famiglia appare come ‘soggetto’ di azione pastorale vi sono ancora ampi margini di crescita
e di miglioramento.
La famiglia, attraverso cui passano tutte le età della vita di ogni essere umano, riconosciuta
“chiesa domestica”, espressione del “mistero grande” dell’amore tra Cristo Sposo e la Chiesa
Sposa, nasce e si sostiene, crea vita e si santifica tramite l’amore della
coppia dei coniugi che la
creano. Il matrimonio dunque è condizione privilegiata di santificazione per i coniugi e come tale va
riconosciuto, promosso e sostenuto dalla comunità ecclesiale. Gli sposi dunque siano
soggetti attividella pastorale comunitaria.
Tutte le potenzialità che sono implicate nella “grazia di stato”, che i coniugi e i genitori
hanno – e hanno solo loro – per la vita cristiana della loro famiglia e nella loro famiglia, non sono
tuttora pienamente attuate. Sembrerebbe ancora, infatti, che molte decisioni – anche relativamente
alla vita matrimoniale intima – non possano essere autonomamente e responsabilmente prese dai
coniugi stessi: ciò appare sia incomprensibile, alla luce dell’ecclesiologia conciliare, sia
mortificante della “grazia di stato”, cioè della pienezza di carisma che lo Spirito consegna ai
coniugi.
Così pure, in una visione complessiva di una pastorale di liberazione evangelica, il ruolo e le
relative potenzialità dei coniugi cristiani sono ancora da sviluppare e potrebbero rivelarsi
significativi. I coniugi cristiani vivono oggi – forse perfino inconsapevolmente – un “vissuto
eucaristico” che va dalla cura, sempre più esigente, dei figli, al sostegno morale e psicologico
reciproco (in un tempo che, come si è visto, da una parte spinge verso torsioni narcisistiche e
individualistiche e dall’altra mette in difficoltà, in molti sensi, sul piano del lavoro)
all’accudimento, in molti casi, di genitori anziani e malati. Questo vissuto eucaristico non sempre
viene accolto, riconosciuto come pienamente ecclesiale e perciò valorizzato in quanto tale dalle
Comunità ecclesiali, che pure ne avrebbero tanto bisogno (cfr. Francesco ,evangelii gaudium, n. 28).
Se oggi la pastorale non può non fondarsi sulla ‘relazione’, allora solo portando il vissutoe
familiare nelle comunità ecclesiali le si renderà famiglie di famiglie. Un’indicazione – presente nei
documenti della CEI e molto sottolineata da don Renzo Bonetti, quando è stato coordinatore
dell’Ufficio famiglia della CEI (e venne pure a Saronno per un incontro con gli operatori di
pastorale familiare, a livello decanale) – quasi totalmente disattesa è quella di non avere solo o tanto
‘operatori pastorali’ individuali, ma anche o soprattutto ‘in coppia’: e così essere presenti negli
organismi ecclesiali partecipativi. Ma anche le ultime elezioni dei vari Consigli non hanno previsto
questo approccio. Non che esso sia la soluzione complessiva: ma indicherebbe un’attenzione, una
sensibilità, un segnale di direzione di marcia.
Uno sviluppo possibile – che potrebbe sembrare oggi un’ipotesi remota, ma che merita di
essere segnalato – di questa ministerialità andrebbe nel senso di offrire una speranza viva rispetto ad
un rischio che è oggi presente nel Nord Europa (cioè a pochi chilometri da qui): la mancanza di
presbiteri per la presidenza delle eucaristie. La diminuzione del numero di presbiteri sta, oggi,
spingendo a riorganizzazioni come quella delle Comunità Pastorali: e nella nostra Comunità
Pastorale di Saronno ci sono già Parrocchie che non hanno un presbitero residente (anche se non ci
sono problemi per le eucaristie feriali e festive). In ogni caso, quando – in una Comunità ecclesiale
– sono presenti coniugi anziani, che con la loro vita hanno dato una prova, lunga e duratura, di
fedeltà cristiana e di impegno ecclesiale, perché non giungere alla ordinazione presbiterale del
marito (anche se non vedovo), con un conseguente ministero di presidenza dell’eucaristia nella sua
Comunità? Se i fini sono chiari (assicurare la celebrazione eucaristica in ogni comunità), perché non
ricercare nuovi mezzi per raggiungerli veramente?
Ci conforta quanto afferma papa Francesco: “La pastorale in chiave missionaria esige di
abbandonare il comodo criterio pastorale del «si è fatto sempre così». Invito tutti ad essere audaci e
creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori
delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei
mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con
generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure” (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 33).
N. 4: Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili
Anche nel nostro territorio saronnese si segnalano trasformazioni ormai chiaramente
evidenti. Per riferirci al solo Comune di Saronno, nel 2010 sono stati celebrati 127 matrimoni – 78
religiosi e 49 (38,5%) civili – e ci sono stati 37 divorzi. Nel 2011 sono stati celebrati 121 matrimoni
– 62 religiosi e 59 (48,7%) civili – e ci sono stati 40 divorzi. Sono inoltre aumentate nettamente le
convivenze: non abbiamo dati, tuttavia tra i ‘fidanzati’ che partecipano ai già ricordati Percorsi di
preparazione al matrimonio, un numero crescente nel tempo e ormai decisamente maggioritario è
costituito da coppie conviventi (talvolta anche già con figli).
Vent’anni fa – quando le coppie conviventi erano rarissime – si poteva adottare un codice
rigoristico. Ma oggi avrebbe senso accogliere queste coppie con le parole del Catechismo? Dire
cioè che la loro situazione esistenziale è un’offesa alla castità, come lo sono la lussuria, la
masturbazione, la pornografia, la prostituzione e lo stupro (nn. 2351-2356), e che è un’offesa alla
dignità del matrimonio, come la poligamia, l’incesto, il concubinato (nn. 2387-2391). Avere un
approccio del genere – dottrinalmente ortodosso e coerente – vorrebbe dire semplicemente
allontanare tutti i presenti e non fare più nessun Percorso. Per questo, l’atteggiamento delle coppieguida
dei Percorsi esprime normalmente accoglienza, simpatia, fiducia, apprezzamento per le gioie
dei fidanzati e propone l’itinerario di fede verso il sacramento come un completamento, una
crescita, una maturazione, sul piano umano e cristiano. Non si tratta solo di un atteggiamento
pastorale ragionevole e di buon senso, che parte – con rispetto – dall’interno dei vissuti reali, in ciò
che viene soggettivamente percepito come positivo e bello. Si tratta anche, ormai, di fare anche noi
– Comunità ecclesiale – un cammino e una crescita, come chiediamo alle giovani coppie. Le
posizioni dottrinali con le loro formulazioni catechistiche, cioè, non descrivono più (o almeno in
modo riconoscibile) vissuti reali, si riferiscono a contesti storici (come fatti e come
autoconsapevolezza dei fatti) che non esistono più, appaiono per lo più irrispettose e si devono
omettere o bypassare con giri eufemistici. Si richiede, dunque, una crescita nella comprensione del
dato rivelato e un aggiornamento della sua formulazione.
Non si può dire che i separati, i divorziati e i divorziati risposati costituiscano in sé, nel
nostro contesto, una realtà quantitativamente molto cospicua. Il numero dei divorziati è in crescita:
ma, tra questi, la maggioranza non partecipa alla vita della Comunità ecclesiale, forse per
disinteresse, per scelte ideali diverse, ma forse pure – in qualche caso – per non sentirsi
discriminata. Vi sono anche, sia pure per piccoli numeri, persone che vivono in tali situazioni e che
frequentano, quasi sempre con difficoltà, la Comunità ecclesiale.
Tuttavia dedurre da questa constatazione che tale situazione pastorale non sia, nella nostra
realtà, “rilevante” sarebbe un grave errore. Innanzi tutto ci sono i “mondi vitali” che ruotano attorno
a queste persone: molti membri della Comunità ecclesiale – per non dire tutti – hanno parenti, più o
meno stretti, o quanto meno intimi amici che vivono tali situazioni. Vi è poi l’orizzonte di
aspettativa: sempre più i genitori di adolescenti e giovani assumono, con angoscia, che i loro figli e
figlie possano – con un tasso di probabilità statisticamente significativo – incorrere in situazioni di
fallimento matrimoniale. Anche solo per questi aspetti, la questione è rilevante per molti e forse per
quasi tutti i membri della Comunità ecclesiale: appare inoltre come un punto di coerenza per una
pastorale veramente dell’accoglienza (come richiesto fin da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI),
per un approccio di misericordia e, in fin dei conti, per un profilo di coerenza e di evangelica
bellezza della Chiesa di Cristo, che si piega a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, su cui
giustamente insiste ora papa Francesco.
Si tratta di compiere scelte che valgano soprattutto per il futuro, essendo più facile prevenire
sofferenze, incomprensioni, distacchi, che riparare ciò che è avvenuto nel passato. Certo l’orizzonte
ecclesiale si è desertificato di molto (“si è prodotta una desertificazione spirituale”: Francesco,
Evangelii gaudium, n. 86): siamo caduti nella “tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania” (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 85) e a furia di strappare via la zizzania, si è sradicato ebuttato via anche grano buono (i ‘contesti familiari
e parentali’ della pretesa ‘zizzania’, peresempio), come il Vangelo aveva previsto.
Ora si tratta si smettere di sradicare, ma le zone inaridite
e diserbate non rifioriscono automaticamente ed anzi il terreno si è indurito e si è fatto
impermeabile. Con serenità e fiducia – ma con realismo e senza impossibili illusioni ‘quantitative’ –
bisognerà riprendere la semina. “Crediamo al Vangelo che dice che il Regno di Dio è già presente
nel mondo, e si sta sviluppando qui e là, in diversi modi: […] come il buon seme che cresce in
mezzo alla zizzania (cfr. Mt 13, 24-30), e ci può sempre sorprendere in modo gradito” (Francesco,
Evangelii gaudium
, n. 278).
Anche la questione dei sacramenti va vista in questo contesto complessivo (e non solo sulla
mera statistica di quanti divorziati risposati chiedono l’eucaristia). Vi è un problema di prassi
sacramentale diretta e anche indiretta (divorziati risposati che chiedono di essere padrini). Vi è una
‘anarchia sommersa’ che porta i pastori in cura d’anime ad avere atteggiamenti diversi, se non
opposti. Vi sono forme di ‘nicodemismo’ (vai a fare la comunione in un’altra parrocchia, dove non
ti conoscono, per non creare scandalo).
Ma, soprattutto, l’attuale disciplina che impedisce a tutti i divorziati risposati di accostarsi
all’eucaristia appare molto problematica e bisognevole di approfondimenti che segnino veri
sviluppi.
La negazione pura e semplice dell’eucarestia era perfettamente coerente all’approccio, sopra
ricordato, del Catechismo. Alla coppia convivente si diceva: sei in peccato mortale, abbandona la
convivenza, pentiti, confessati e solo allora ti potrai sposare in Chiesa. Alla coppia di divorziati
risposati si diceva: sei in peccato mortale, non puoi ricevere l’eucarestia, se muori vai all’inferno.
Oggi l’atteggiamento pastorale non è più così rigido e allora si invitano i divorziati risposati alla
‘comunione spirituale’. Ma questa è o non è una via alla salvezza eterna? Se non lo è, cosa cambia?
E se lo è, non abbiamo così un vulnus alla ‘forma eucaristica’ della Chiesa? Nella Chiesa, cioè, ci
sarebbe anche una via di salvezza, pienamente intra-ecclesiale e tuttavia extra-eucaristica.
Non sarebbe più produttivo ricercare la soluzione pastorale – certo non semplice e che non
potrà essere univoca (senza cioè distinguere tra situazioni diverse) – nell’ambito di quella visione
‘medicinale’ del sacramento eucaristico di cui parlano i Padri e che è stata anche richiamata da papa
Francesco nella Evangelii Gaudium (n. 47: “L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita
sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.
Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con
prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come
facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua
vita faticosa”
)?
Non meno problemi suscita l’indicazione che ammette all’eucaristia i divorziati risposati che
vivano tra loro “come fratello e sorella”: cioè non abbiano rapporti sessuali. Sono evidenti tanto
l’inutilità di una simile norma quanto l’amaro sarcasmo che può suscitare in chi vive tali situazioni.
Ma, soprattutto, essa sembra modificare e secolarizzare il sacramento del matrimonio, riducendo al
solo aspetto sessuale la promessa sacramentale.
Il problema che l’attuale disciplina pone non è, dunque, solo una difficoltà per i divorziati
risposati, è anche una difficoltà per la ‘coscienza eucaristica’ di tutti i fedeli e per
l’autoconsapevolezza sacramentale di tutti gli sposi cristiani.
Da parte di alcune delle persone separate o divorziate si percepisce un’esigenza di
continuare a sentirsi parte della comunità, rivestendo comunque dei compiti (p.es. negli oratori) o
partecipando a gruppi di famiglie. C’è un percorso faticoso e profondo da compiere per tutti che è
quello del perdono dentro la coppia e verso la coppia.
Centrale è poi – dal punto di vista della liberazione evangelica – il problema dei ‘piccoli’:
non possono cioè essere trascurati i vissuti di dolore e di sofferenza, che riguardano i figli (specie se
minori) e che si intrecciano, in modo necessariamente diverso, con le difficoltà dei rapporti tra i
genitori. In questo campo, anche dal punto di vista pastorale, vi è una rivoluzione culturale
evangelica da compiere (“Se non ritornerete come bambini…”): assumere il punto di vista del
minore, del rispetto nei suoi confronti, dei suoi diritti psicologici, morali e spirituali. Molte
perplessità suscitano mentalità che assumono l’aver un figlio come un diritto e secondo una logica
proprietaria, nonché visioni adultiste, sul piano delle decisioni di coppia e intra-familiari (con il già
ricordato rischio del ‘familismo’), anche nell’ambito del cammino di fede.
Vi è, infine, da segnalare una ulteriore difficoltà sul piano ecumenico. La comunicazione
in sacris e quindi nell’eucaristia con i fedeli ortodossi è (dal Concilio e, dunque, anche dal Codice di
diritto canonico e dal Catechismo) non solo dichiarata possibile, ma anche consigliabile. Ciò è
rilevante nel nostro contesto, in cui la presenza straniera più numerosa è quella dei rumeni. Ma in
forza dell’attuale disciplina cattolica sui divorziati risposati, l’eucaristia deve essere negata ai fedeli
ortodossi divorziati, che – nella loro Chiesa – possono, invece, ricevere l’eucaristia. Si noti
l’estrema difficoltà – esistenziale, psicologica, ma anche dottrinale – di far interferire la disciplina
di una Chiesa con la coscienza dei fedeli di un’altra Chiesa, trasformando surrettiziamente
l’ecumenismo in proselitismo confessionale.
Rispondendo poi, unitariamente, a domande poste dal questionario (2d, 4f, 8c), si osserva
che – in considerazione delle epocali trasformazioni storiche che stiamo vivendo e che modificano
non solo i vissuti ma anche le percezioni e le valutazioni etiche dei vissuti stessi – sarebbe forse da
approfondire la ‘forma’ stessa del sacramento del matrimonio, superandone la struttura compatta e
totalmente sincronica, verso una struttura più progressiva e diacronica. Il sacramento del
matrimonio, da una parte, è l’unica forma ammissibile di convivenza stabile di coppia tra battezzati,
dall’altra implica – dal momento stesso della sua celebrazione – l’indissolubilità del vincolo.
Tra i religiosi si giunge all’indissolubilità dei voti solenni e perpetui dopo un cammino di
vita che prevede passaggi intermedi e temporanei.
Lo stesso sacramento dell’Ordine prevede una gradualità progressiva, diacronicamente
articolata: prima c’è il diaconato (che per alcuni può essere permanente), poi c’è il presbiterato (che
per alcuni, anzi per la maggioranza, è definitivo) e poi c’è, come pienezza del sacramento,
l’episcopato.
Perché non pensare una gradualità di momenti anche nel sacramento del matrimonio? Una
prima fase di fidanzamento, una seconda di convivenza senza vincolo di indissolubilità, che può
ricevere una benedizione nella Chiesa, infine la celebrazione piena del sacramento (che ovviamente
ha, tra le sue caratteristiche irrinunciabili, l’indissolubilità). Si sarebbe in difficoltà a dire quante
delle giovani coppie, che partecipano ai Percorsi di preparazione al matrimonio, abbiano la piena
maturità di fede personale e di vita comunitaria ecclesiale che la celebrazione del sacramento
presuppone. La via implicitamente suggerita dal questionario (4f: snellimento della prassi canonica
in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale), pur in sé
auspicabile, se vista come soluzione al problema – umano, pastorale, ma anche in sé sacramentale –
dei divorziati da matrimonio canonico, appare una scorciatoia non proprio limpida, non priva di
rischi di disordini, di ingiustizie, di anarchia disciplinare e con qualche ombra di ipocrisia.
La grande via evangelica dell’attenzione personale e della misericordia costituisce, anche in
quest’ambito, la sola portatrice di frutti di gioia, di giustizia e di liberazione: “Pertanto, senza
sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le
possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno” (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 44).
N. 5: Sulle unioni di persone dello stesso sesso
I cambiamenti epocali di costume, a cui si è fatto cenno, hanno reso sempre più sensibile
l’opinione pubblica verso l’omofobia e verso ogni forma di discriminazione relativa alle persone e
alle coppie omosessuali. Capita pure che la prospettiva della liberazione evangelica sia accusata,
con evidente ingiustizia, di omofobia.
Non si può negare che tendenze omofobiche ci siano state in passato e con frequenza tra
cattolici, ma come riflesso di contesti culturali più generali (la stessa Organizzazione Mondiale
della Sanità ha considerato, fino al 1990, l’omosessualità una malattia) e forse anche come
espressione di quei residui sessuofobici manichei, stigmatizzati da Giovanni Paolo II.
Anche in quest’ambito – non foss’altro per far emergere la limpidità e la forza liberatrice del
Vangelo – è auspicabile una crescita in comprensione del dato rivelato e un maggiore impegno di
annuncio e di testimonianza che contrasti ogni, anche dissimulata, tendenza omofobica. Non
dimentichiamo che l’omosessualità appare ancora come un tema difficile, che genera conflittualità,
a partire dall’interno stesso delle famiglie, e perfino violenze.
È da notare che, su questo aspetto, conta molto la conoscenza scientifica delle cause e della
realtà del fenomeno. Se la Sacra Scrittura non può essere una norma sulla teoria scientifica
riguardante l’eliocentrismo, non può esserlo neppure sulla teoria scientifica che riguardi
l’omosessualità. Alla Parola di Dio non ci si rivolge per la conoscenza scientifica dei fenomeni, ma
per la liberazione vera dei contesti umani, oppressi dalla schiavitù del peccato e delle sue
conseguenze sociali disumanizzanti, attraverso l’amore di Dio.
Lo stesso catechismo dice che la genesi psichica dell’omosessualità è ancora non
definitivamente chiarita (n. 2357) e aggiunge: “Un numero non trascurabile di uomini e di donne
presenta