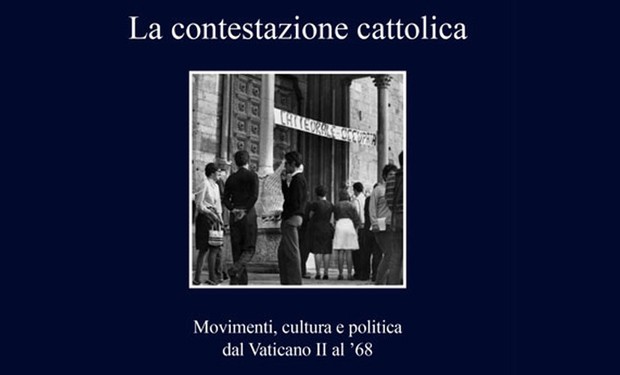la sfida del sacerdozio universale
per liberare la Chiesa dalla malattia del clericalismo
da: Adista Documenti n° 33 del 01/10/2016
Guarire dalla malattia del clericalismo, ritornando al messaggio originale di Gesù. È questa la grande sfida che la Chiesa è chiamata oggi a raccogliere, tornando al passato per proiettarsi nel futuro, superando chiusure e tentazioni autoreferenziali in maniera da aprirsi con fiducia alla modernità. Una sfida la cui importanza è stata chiaramente colta da Iglesia Viva, rivista trimestrale spagnola “di pensiero cristiano” e riflessione militante, che ha deciso di dedicare a questo tema il suo ultimo numero (il 266), dal titolo “Per una Chiesa declericalizzata”, proprio nella consapevolezza, evidenziata nella presentazione da Bernardo Pérez Andreo, che nessun rinnovamento sarà possibile senza estirpare definitivamente quello che è «il male per eccellenza della Chiesa», quel clericalismo che «pietrifica la fede» e la trasforma in un «pesante fardello sulle spalle della gente». Esattamente il contrario di ciò che intendeva Gesù, il quale, come sottolinea il teologo spagnolo Xabier Pikaza in uno degli interventi del numero, ripreso poi in un articolo pubblicato sul suo blog, non aveva altro fine che proclamare e instaurare il Regno di Dio, un Regno di «perdono e concordia universale», a partire «dagli infermi, dagli emarginati e dagli esclusi di Israele». Un progetto, questo, che avrebbe dovuto tenere la comunità cristiana al riparo da ogni struttura clericale e da ogni lusinga del potere, ma a cui la Chiesa ha finito per voltare le spalle, trasformandosi in un’istituzione patriarcale di tipo gerarchico alleata con il sistema dominante. Ed è così che quelli che erano stati pensati appena come servizi funzionali all’organizzazione comunitaria – quelli dei servitori (diaconi), degli anziani (presbiteri) e dei supervisori (vescovi) – nel quadro del sacerdozio universale dei fedeli hanno dato vita a un potere sacro, stabilendo una divisione non evangelica tra clero e laici.
di seguito l’articolo di Pikaza pubblicato in tre parti sul suo blog (http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php; 24, 27 e 29 agosto):

per una chiesa declericalizzata
(…). Gesù era un laico, non un sacerdote. Non voleva riformare le antiche istituzioni sacre, né crearne di nuove, bensì potenziare i valori della vita partendo dagli esclusi, in una linea di gratuità, fino alle estreme conseguenze. I suoi seguaci credettero in lui e fondarono comunità per preservarne la memoria, sulla base del messaggio del Regno, del perdono e del pane condiviso, creando così diversi ministeri (…) sorti dalla stessa natura laica e messianica del Vangelo.
Successivamente, per esigenze culturali e pressioni ambientali, i cristiani trasformarono questi ministeri in istituzioni patriarcali di tipo gerarchico/clericale. Ma il tempo di questo dominio clericale sta volgendo al termine e dalla radice del Vangelo dovrà sorgere, nelle stesse comunità, un ministero evangelico in una linea non gerarchica. Non si tratta di sopprimere ministeri, ma di dare loro maggiore forza missionaria ed evangelica, per recuperare il messaggio e il cammino del Regno. (…).
AL PRINCIPIO NON ERA COSÌ
(…). Gesù non assunse titoli sacerdotali né rabbinici, ma operò come un comune essere umano (…).
Era stato per un certo tempo discepolo del Battista (…). Ma, dopo l’assassinio di Giovanni, Gesù ebbe la certezza che Dio lo spingesse a proclamare e instaurare il suo Regno (di perdono e concordia universale), cominciando dagli infermi, dagli emarginati e dagli esclusi di Israele (…).
Animato da questa certezza, lasciò il deserto e cominciò a instaurare il Regno di Dio in Galilea, senza titoli né sigilli sacri che lo accreditassero, semplicemente come un israelita cosciente della propria identità e della propria missione. (…). Convinto che Dio fosse il Padre di tutti, promosse un movimento centrato sulla saggezza popolare, sulla cura e sulla comunione tra gli emarginati, che egli risollevò, accompagnò e animò, come destinatari ed eredi del Regno di Dio (cfr Mt 5,3; 11,5; Lc 6,20; 7,22). (…). Aveva la certezza che solo ai margini (fuori dal sistema dominante) si potesse edificare l’opera di Dio, e non certo in un’ottica di potere. Non utilizzò mezzi di reclutamento e di discriminazione classisti (…) propri dei gruppi di potere. Non addestrò un gruppo di combattenti (zeloti), né fondò una compagine di puri (farisei), né optò per un pugno di prescelti in mezzo a una massa di gente perduta. Non fece ricorso al denaro, né alle armi, né coltivò un vivaio di funzionari super competenti.
Non ebbe bisogno di edifici, né di dipendenti, ma proclamò e instaurò il Regno di Dio, senza mediazioni gerarchiche. Parlò con parabole che tutti potevano capire (…) e realizzò gesti che tutti potevano assumere, aprendo canali personali di solidarietà tra esclusi e bisognosi, come guaritore ed esorcista (…) e, soprattutto, come amico dei poveri. Accolse (perdonò) gli esclusi e condivise la mensa con chi veniva da lui, in cerca di salute, di compagnia o di speranza, prendendosi cura in maniera speciale dei bambini, degli infermi e di coloro che venivano espulsi dalla società. (…).
Minacciati dal suo progetto, lo condannarono i sacerdoti di Gerusalemme, dove era andato a presentare la sua proposta, dopo aver trasmesso il suo messaggio e la sua solidarietà, nelle strade e nei paesi della Galilea, a uomini e donne, sani e malati, bambini e adulti. Non si era recato nelle città (Seforis, Tiberiade, Tiro, Gerasa), rifuggendo probabilmente le strutture urbane dominate da un’organizzazione classista, sotto la dominazione di Roma, e volendo diffondere un messaggio universale a partire dalle zone contadine in cui abitavano gli umili e gli esclusi della società (…), in maniera da includere tutti, al di sopra delle leggi di discriminazione sociale o religiosa della cultura dominante.
I primi destinatari del suo progetto erano i poveri, i pubblicani e le prostitute, gli affamati e gli infermi, chi era espulso dal sistema. A questi dedicò la sua vita, da questi volle far partire il suo movimento (…). Ma anche nella società dominante aveva simpatizzanti e amici, ai quali chiese che si lasciassero “curare” dai poveri, ponendosi al servizio della comunione del Regno.
Si circondò di seguaci e amici, alcuni dei quali lasciarono case e proprietà per accompagnarlo, e con essi si spostava, dando inizio al suo movimento. In questa linea, convocò i Dodici, scelti come rappresentanti e messaggeri del nuovo Israele (le dodici tribù), che inviò a predicare il messaggio, senza autorità amministrativa o sacrale (non erano sacerdoti né scribi), solo con l’autorità della vita. (…).
Morì per il delitto di aver annunciato un Regno universale, che risultava pericoloso per l’Impero e per il Tempio. (…). Morì, ma alcuni dei suoi seguaci, donne e uomini, lo scoprirono vivo (risorto) e ripresero il suo progetto.
Non tracciarono un unico camino, ma vari. Non erano pronti (pensavano che il Regno stesse per arrivare e che tutto si sarebbe risolto), né sapevano come si sarebbe dovuto organizzare il movimento, ma andarono avanti, perché il ricordo di Gesù e l’impulso dello Spirito (…) davano loro forza. (…). Inizialmente non sapevano in che modo, né fissarono un incontro istitutivo per definirne le strutture; ma il carisma e la libertà di Gesù li andò guidando nella creazione di gruppi di amici e seguaci, vincolati al suo ricordo e alla sua presenza (…).
I cristiani non avevano ministeri uguali in tutti i luoghi, ma operavano in modi diversi, in base ai gruppi e alle circostanze. Non ricrearono il sacerdozio sacro, in quanto tutti si sentivano sacerdoti, senza bisogno di un tempio come quello di Gerusalemme. A loro importava più il messaggio che l’organizzazione, più il carisma che la struttura, più la missione che il conto dei convertiti. (…). Solo più tardi, a consolidamento avvenuto, mirarono a un’unificazione dei ministeri.
Esistevano vari gruppi di cristiani, ebrei ed ellenisti, a Gerusalemme, in Galilea e nella diaspora, come fiumi che unendosi andavano a formare la Grande Chiesa, ma senza che nessuno dominasse sugli altri. Per questo, al principio non c’era uniformità, bensì diversi gruppi semi-indipendenti, vari modi di intendere l’unità e i ministeri (…).
Il Nuovo Testamento (completato verso il 150 d.C.) non conosce ministeri ordinati fissi, che sorgeranno più tardi, alla fine del II d.C. (…): «Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1Cor 12,4-6). (…).
La Chiesa è pertanto un corpo centrato sulla comunione di tutti e non una gerarchia (gli uni sopra, gli altri sotto), secondo una linea di reciprocità, partendo da coloro che sono più in basso e ricevono meno onori, che, in base alla tradizione, sono i più importanti (Mc 9,33-37; 10,35-45; 1Cor 12,12-26). (…).
LA NASCITA DEL CLERO
Dopo due sconfitte (67-70 e 132-135 d.C.), gli ebrei accettarono in modo consapevole la fine del tempio (…) piangendo la propria condizione di orfani dinanzi al Muro del Pianto, per organizzarsi come federazione di sinagoghe libere, senza sacerdoti. I cristiani, invece, pur mantenendo il sacerdozio universale di tutti i credenti, “recuperarono” successivamente alcuni simbolismi sacri e gerarchici più propri dell’Antico Testamento e della politica romana che del messaggio di Cristo.
Il tema si impose a partire dal 150, quando diversi gruppi di tipo semi-gnostico (…) cercarono di separare il cristianesimo dalla sua base ebraica, per trasformarlo in una religione intimista (…). A ciò si oppose la Grande Chiesa conservando l’origine ebraica e rafforzando alcuni elementi sacri dell’istituzione sacerdotale di Gerusalemme (…); nonché consolidando la propria indipendenza, con l’introduzione nella Scrittura di testi propri (Nuovo Testamento) e la riorganizzazione della vita e della liturgia a partire dall’Eucarestia o Memoria della Cena di Gesù, intesa in forma sacrificale, in una prospettiva che combinava elementi ebraici ed ellenisti, secondo un processo già in corso a partire del 200 d.C. (…).
Un processo, questo, che evitò il rischio di dissoluzione gnostica del cristianesimo, ma a costo di mettere a tacere importanti elementi del Vangelo, come la sacralità universale ed egualitaria di tutti i credenti. (…). Alla radice, il cristianesimo continuò a essere quello che era (…), ma accettò e sacralizzò di fatto la distinzione dei credenti su due livelli (ordini) all’interno della Chiesa.
Tale divisione, con cui le donne restarono escluse dalla gerarchia, si vincolò inoltre alla forma di celebrazione dei due grandi “sacramenti” cristiani: l’eucarestia (che doveva essere presieduta dal vescovo o da un suo delegato) e la riconciliazione o riammissione dei peccatori ufficiali nella Chiesa (che restò riservata al vescovo). E così:
– sorse il clero, formato da vescovi, presbiteri e diaconi maschi, elevati al di sopra del resto della Chiesa, come rappresentanti di Gesù, con autorità sacra: un ordine sacerdotale, come se la “grazia” di Dio passasse per loro tramite al resto dei fedeli. La Chiesa (…) si trasformò in un’istituzione di potere sacro, al servizio dei poveri, ma al di sopra di essi.
– E, dall’altra parte, restò il popolo, formato da laici: cristiani destinati ad ascoltare la parola e a ricevere i sacramenti offerti loro dal clero (…).
Questa divisione, pur non essendo evangelica, svolse una sua funzione, assicurando stabilità alla Chiesa, come organizzazione unitaria ed efficiente (sottosistema sacrale), in un mondo gerarchico. È questo il paradosso: i cristiani, che avevano rifiutato la gerarchia religiosa dell’Impero, venendone perseguitati, finirono per assumere, nel corso di un processo affascinante (e pericoloso) di rifondazione, molti dei suoi tratti sacri. (…).
FARE RITORNO ALLE ORIGINI PER CREARE QUALCOSA DI NUOVO
Benché al principio le cose non stessero così, questa nuova situazione si consolidò a partire dal IV secolo d.C. (Costantino) e soprattutto dall’XI (Riforma Gregoriana), quando la Chiesa si trasformò in una gerarchia feudale, dipendente dal papa e dai vescovi. Il Vaticano II provò a tornare alle origini, ma non riuscì a farlo in modo coerente, dando spazio nei suoi documenti a due ecclesiologie:
– a livello teorico, predomina l’ecclesiologia di comunione, la Chiesa come Popolo di Dio, comunità di credenti, con ministeri che fioriscono dalla comunità. (…);
– nei fatti, dominano le formulazioni giuridiche e pratiche dell’ecclesiologia gerarchica. (…). I dirigenti detengono il potere sacro, che esercitano al servizio del popolo, ma al di sopra di esso. Un’ecclesiologia rafforzatasi sul piano pratico dopo il Vaticano II, (…) ma che è messa in crisi dai tentativi di rinnovamento portati avanti da papa Francesco.
È una situazione schizofrenica: si parla di comunione (…), ma continua a dominare un’ecclesiologia del sacerdozio gerarchico, con l’avallo del nuovo Diritto Canonico (1983) e del Catechismo (1993) (…). Ciò di cui c’è bisogno non è una nuova facciata, qualche ritocco cosmetico in questioni controverse (celibato, crisi di “vocazioni”, ministeri femminili, esclusione delle donne, pedofilia…), ma un recupero in termini di identità.
Tornare al Vangelo, al sacerdozio dei poveri
Dopo secoli di inerzia clericale (…), dobbiamo rompere la struttura clericale della gerarchia (…). Il modello sacerdotale dei ministeri è entrato in crisi, a causa della coscienza moderna di uguaglianza/fraternità e soprattutto per esigenza evangelica. (…). Vescovi e presbiteri sono ministri di una Chiesa di cui sono al servizio e da cui ricevono (con cui condividono) la Parola e il Sacramento di Gesù, nella consapevolezza che il sacerdozio appartiene all’insieme dei fedeli, in modo speciale ai poveri e agli emarginati (…). L’unità e l’autorità ecclesiale non risiedono in un potere unificato, né in un’organizzazione centrale, bensì nella comunione multiforme dei credenti, che diffondono e condividono la parola e il pane, a partire dagli esclusi.
Non si tratta di ottenere potere
Il Vangelo non vuole conquistare il potere, ma superarlo. Il punto non è che i poveri lo assumano per governare meglio dei ricchi, ma che sconfiggano il potere (…) per creare forme distinte di legami sociali per tutti gli esseri umani. La conversione cristiana è una meta-noia (cambiamento di pensiero: Mc 1,15) e implica il superamento di un potere sociale di comando (cfr. Mc 10,41-45). Le Chiese devono creare altre forme di presenza e comunicazione che non siano in una linea di potere. Non si tratta del fatto che il papa, i vescovi e i presbiteri deleghino funzioni, concedendo alle comunità cristiane maggiore autonomia: non possono, infatti, dare quello che non è loro, bensì operare al di là del potere, (…) in maniera che le Chiese si espandano e si organizzino autonomamente, a partire dalla Vita e dalla Memoria di Gesù, per unirsi (al tempo stesso) in comunione e in dialogo, creando ministeri evangelici. È comprensibile che alcuni, in questa fase di cambiamenti, auspichino un nuovo concilio (…). Vorrebbero creare nuove strutture, risolvendo dall’alto questioni come il celibato, l’ordinazione delle donne, il potere dei vescovi, la celebrazione dell’eucarestia e la confessione. Però:
– forse non è il momento adatto per un concilio di vescovi, dal momento che la maggior parte delle nomine risponde a un principio di sacralità e persino di fondamentalismo: un Vaticano III a cui partecipassero solo loro sarebbe poco rappresentativo della Chiesa e della dinamica del Vangelo. (…).
– Bisogna cominciare dalla vita. Più che un concilio è importante che le Chiese esplorino e ricerchino cammini evangelici, in comunione mutua, senza attendere soluzioni dall’esterno. Per questo sembra necessario prendersi un tempo per la ricerca, per condividere la sofferenza degli emarginati e aprire insieme ad essi un cammino di libertà. Nessuno (dentro o fuori la Chiesa) deve dare ai cristiani l’autorità per pensare e celebrare, organizzarsi e decidere, in quanto loro stessi sono autorità (cfr. Mt 18,15-20), concilio permanente.
– Occorre superare l’endogamia. Un concilio centrato su temi ecclesiastici sarebbe un segno di egoismo, come dice papa Francesco. L’importante sono i poveri, più che le questioni di Chiesa. (…). L’autentico concilio è la vita quotidiana delle Chiese, in cui si creino forme concrete e impegnate di presenza e di servizio ai poveri, in comunione di vita.
Oltre quello che c’è. La grande utopia
(…). Sta trionfando in tutto il mondo un capitalismo anti-divino, opposto a ciò che dovrebbe essere la Chiesa: alcuni hanno addirittura proclamato l’avvento del Regno Finale del Capitale (F. Fukuyama, La fine della storia, 1992). Contro tale affermazione, continuiamo a camminare nella storia, verso la cattolicità cristiana della grazia che si esprime a partire dai poveri. Così, per coerenza storica e spirito evangelico, i ministri delle Chiese (tutti i credenti!) devono tornare al luogo in cui stava Gesù (e i primi cristiani: Maddalena, Pietro, Paolo…), tra gli affamati e gli emarginati dell’antico Impero, per riscoprire e ricreare la cattolicità del Vangelo. (…). Ciò presuppone che il sacerdozio di Gesù torni a far parte della vita delle Chiese, in quanto il battesimo, l’eucarestia e il perdono non sono un diritto di vescovi e presbiteri, ma un elemento essenziale delle comunità (…). Non è la gerarchia a creare l’eucaristia, ma il contrario: è l’eucarestia, celebrata dalla comunità, riunita nel nome di Gesù, a rendere possibile il sorgere di una comunità in cui i credenti abbiano doni e ministeri diversi, al servizio del corpo ecclesiale (cfr. 1Cor 12-14). (…).
Ironia della storia: come delegati di Dio, alcuni sacerdoti di Gerusalemme (…), alleati con il sistema imperiale romano, condannarono Gesù (…), ma molti seguaci di quel Gesù, combattuto dal potere religioso e militare, ristabilirono una gerarchia simile, scendendo a patti con i nuovi soldati del mondo. (…).
Sacerdozio comune, ministeri nuovi
(…). Non c’è niente e nessuno al di sopra dei fedeli, in quanto è il loro stesso amore reciproco, in comunione di Parola e Pane, a presentarsi come verità definitiva. In questo senso, tutti i cristiani possono e devono ascoltare e diffondere il Vangelo, in modi appropriati, con gesti distinti, come vuole 1Cor 12-14 e tutto il Nuovo Testamento.
Per questo, la prima cosa è potenziare il sacerdozio comune (…), in modo tale che nella Chiesa non vi sia posto per consacrati speciali, né sante sedi, né persone o luoghi santi (…). Non esiste per Gesù un mondo di Dio lassù, come sfera superiore di sacralità platonica, in quanto è questo mondo quaggiù (specialmente quello dei poveri e degli emarginati) a essere presenza di Dio.
(…). Tutto nella Chiesa è profano (laico), pur essendo al tempo stesso sacro, prossimo a Dio, espressione del suo mistero. Per questo, la missione cristiana non è creare un tras-mondo di santità, ma coltivare la vita di Dio in Cristo in questo mondo. Per essere quello che è e fare/dire quello di cui Gesù l’ha incaricata, la Chiesa non ha bisogno di una gerarchia sacra nello stile antico, né di strutture di potere (…). Bastano la Parola e l’Amore mutuo di Gesù, in modo che tutti i suoi fedeli ascoltino e dicano, condividano e celebrino la Parola, il Perdono e il Pane.
(…). In questa linea, il sacerdozio è la stessa vita cristiana, ed è solo sulla base di questo sacerdozio comune che si può e si deve parlare di ministeri speciali, al servizio della missione e della comunione cristiana. (…).
Attualmente, l’eucarestia ufficiale dipende da un rituale complesso, presieduto da un ministro ordinato maschio (…), cosicché i battezzati non possono autonomamente proclamare e condividere la Parola e consacrare (benedire) il Pane di Gesù (…). Tale situazione contraddice la parola di Gesù («dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro», Mt 18,20) e lo scopo fondamentale del Vangelo, che è quello di scoprire e celebrare la Vita di Dio nella vita stessa degli esseri umani.
La tradizione dell’ordine gerarchico (in base a cui non esiste eucarestia senza un ministro ordinato dall’alto, celibe e maschio) ha stravolto l’esperienza di Gesù e della Chiesa primitiva, che partiva dalle comunità, le quali nominavano i propri ministri, in comunione (come è logico) con le comunità circostanti. Ma è giunto il momento di ricapovolgere tale situazione, tornando alla radice del Vangelo, in maniera che l’insieme della Chiesa recuperi la sua libertà creativa, il suo sacerdozio di base, superando l’attuale dicotomia tra clero e laici.
La prima cosa è allora il sacerdozio di base. Ogniqualvolta un gruppo di cristiani si riunisce, in buona fede, nel nome di Gesù, ascolta la sua parola e ne fa memoria nel pane e nel vino condivisi, possiamo e dobbiamo affermare che esiste eucarestia (…). Il modello attuale di Chiesa gerarchico/burocratico, con un vertice sacro a garantirne unità e missione, è secondario, successivo, e deve essere superato, così da recuperare la libertà delle prime Chiese che celebravano autonomamente l’eucarestia, in comunione con altre Chiese.
Su questa linea, la Grande Chiesa è comunione di comunità autonome, che apprendono a celebrare da sé, scegliendo a tale scopo i loro ministri. (…).
Il sistema politico-sociale-economico è spietato con chi non gli è utile, escludendolo e negandogli i suoi benefici. Proprio tra questi emarginati la Chiesa deve edificare le sue comunità, scoprendo e celebrando la Vita a partire dall’esistenza minacciata degli esseri umani, al fine di esprimere il senso della creazione di un Dio che entra nella storia, manifestando il suo amore gratuito nell’amore che gli esseri umani provano e condividono.
Questioni aperte
(…). Non si tratta, allora, di sopprimere i ministeri, ma di far sì che abbiano più forza missionaria ed evangelica. Non sarà il vertice ecclesiale a promuovere e guidare in maniera efficiente questa ricreazione dei ministeri (…), per quanto sia auspicabile che esso partecipi, rompendo la macchina burocratica della curia romana e di altre curie episcopali per porsi al servizio del Vangelo.
Il cambiamento è iniziato già (come granello di senape) e andrà avanti per opera di persone e gruppi che assumano il Vangelo con nuovo spirito creativo, creando comunità di servizio mutuo e di contemplazione attiva. (…).
(…). Non si tratta di trasformare alcune istituzioni, sopprimendo le vecchie e creandone di nuove, più moderne e democratiche in senso esteriore, né di sostituire le persone che oggi governano con altre migliori (cosa difficile e inutile, se si conservano le stesse strutture). Si tratta, piuttosto, di superare, partendo dal Vangelo, l’istituzione gerarchico/clericale, non per abbandonare i credenti all’improvvisazione o per condannare la comunità cristiana all’anarchia, ma per sperimentare e promuovere a partire da Gesù spazi umani in termini di affetti, di incoraggiamento, di perdono, di pane.
La risposta è tornare alle origini del messaggio di Gesù, alla sua esperienza del Regno, con lo stesso animo dei primi gruppi ecclesiali sorti per opera dello Spirito, per esplorare nuovi cammini in direzione del Vangelo. Tre sono, a mio giudizio, le questioni aperte.
– Proclamazione della Parola. (…). Non si tratterà di una Parola interpretata solo in forma privata (…), ma di una Parola ascoltata, condivisa e proclamata in nome dell’intera comunità.
– Impegno di conversione. (…). Per promuovere la conversione e affermare/celebrare il perdono devono sorgere ora ministeri che, pur non essendo gerarchico-clericali, siano profondamente efficaci, in quanto senza conversione sociale e perdono non c’è Chiesa.
– Celebrazione del Pane Condiviso, Eucarestia. Non c’è Chiesa senza memoria di Gesù e presenza di Dio nel pane concreto, pane dei poveri reali e di comunione universale, che si celebra, si vive e si canta. (…).