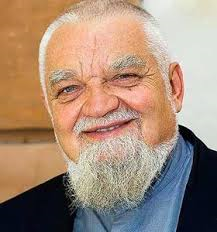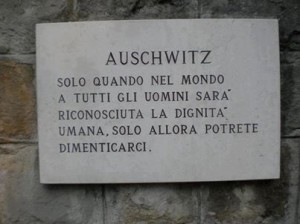I frutti dell’amore
1 novembre: festa di Tutti i santi
Commento al Vangelo di p. E. Bianchi
In questi ultimi decenni sono stati proclamati tanti santi e beati: mai c’è stata nella chiesa una stagione così ricca di canonizzazioni, segno anche di un’estesa “cattolicità” raggiunta dalla testimonianza cristiana. Eppure molti, all’interno e attorno alla chiesa, hanno la sensazione di non conoscere dei santi “vicini”, di non riuscire a discernere “l’amico di Dio” – questa la stupenda definizione patristica del santo – nella persona della porta accanto, nel cristiano quotidiano. Questo forse è dovuto anche al fatto che viviamo in una cultura in cui si privilegia l’apparire, un mondo in cui – come ha detto qualcuno – “anche la santità si misura in pollici”: molti allora cercano non il discepolo del Signore, ma l’ecclesiastico di successo, l’efficace trascinatore di folle, l’opinion leader capace di parole sociologiche, politiche, economiche, etiche, la star mediatica cui si chiede una parola a basso prezzo su qualsiasi evento, facendolo apparire il più eloquente a prescindere dalla consistenza della sua sequela del Signore.
Ma è proprio in questa ambigua ricerca della santità attorno a noi che ci viene in aiuto la festa di tutti i santi, la celebrazione della comunione dei santi del cielo e della terra. Sì, al cuore dell’autunno, dopo tutte le mietiture, i raccolti e le vendemmie nelle nostre campagne, la chiesa ci chiede di contemplare la mietitura di tutti i sacrifici viventi offerti a Dio, la messe di tutte le vite ritornate al Signore, la raccolta presso Dio di tutti i frutti maturi suscitati dall’amore e dalla grazia del Signore in mezzo agli uomini. La festa di tutti i santi è davvero un memoriale dell’autunno glorioso della chiesa, la festa contro la solitudine, contro ogni isolamento che affligge il cuore dell’uomo: se non ci fossero i santi, se non credessimo “alla comunione dei santi” – che non certo a caso fa parte della nostra professione di fede – saremmo chiusi in una solitudine disperata e disperante. In questo giorno dovremmo cantare: “Non siamo soli, siamo una comunione vivente!”; dovremmo rinnovare il canto pasquale perché, se a Pasqua contemplavamo il Cristo vivente per sempre alla destra del Padre, oggi, grazie alle energie della resurrezione, noi contempliamo quelli che sono con Cristo alla destra del Padre: i santi. A Pasqua cantavamo che la vite era vivente, risorta; oggi la chiesa ci invita a cantare che i tralci, mondati e potati dal Padre sulla vite che è Cristo, hanno dato il loro frutto, hanno prodotto una vendemmia abbondante e che questi grappoli, raccolti e spremuti insieme formano un unico vino, quello del Regno.
Noi oggi contempliamo questo mistero: i morti per Cristo, con Cristo e in Cristo sono con lui viventi e, poiché noi siamo membra del corpo di Cristo ed essi membra gloriose del corpo glorioso del Signore, noi siamo in comunione gli uni con gli altri, chiesa pellegrinante con chiesa celeste, insieme formanti l’unico e totale corpo del Signore. Oggi dalle nostre assemblee sale il profumo dell’incenso, segno del legame con la chiesa di lassù, la Gerusalemme celeste che attende il completamento del numero dei suoi figli ed è vivente, gloriosa presso Dio, con Cristo, per sempre.
Ecco il forte richiamo che risuona per noi oggi: riscoprire il santo accanto a noi, sentirci parte di un unico corpo. E’ questa consapevolezza che ha nutrito la fede e il cammino di santità di molti credenti, dai primi secoli ai nostri giorni: uomini e donne nascosti, capaci di vivere quotidianamente la lucida resistenza a sempre nuove idolatrie, nella paziente sottomissione alla volontà del Signore, nel sapiente amore per ogni essere umano, immagine del Dio invisibile. Il santo allora diviene una presenza efficace per il cristiano e per la chiesa: “Noi non siamo soli, ma avvolti da una grande nuvola di testimoni” (Eb 12,1), con loro formiamo il corpo di Cristo, con loro siamo i figli di Dio, con loro saremo una cosa sola con il Figlio. In Cristo si stabilisce tra noi e i santi una tale intimità che supera quella esistente nei nostri rapporti, anche quelli più fraterni, qui sulla terra: essi pregano per noi, intercedono, ci sono vicini come amici che non vengono mai meno. E la loro vicinanza è davvero capace di meraviglie perché la loro volontà è ormai assimilata alla volontà di Dio manifestatasi in Cristo, unico loro e nostro Signore: non sono più loro a vivere, ma Cristo in loro, avendo raggiunto il compimento di ogni vocazione cristiana, l’assunzione del volere stesso di Cristo: “Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, o Padre” (Lc 22,42). Sostenuti da quanti ci hanno preceduto in questo cammino, scopriremo anche i santi che ancora operano sulla terra perché il seme dei santi non è prossimo all’estinzione: caduto a terra si prepara ancora oggi a dare il suo frutto. “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Is 43,19).
Purtroppo oggi questa memoria dei santi, così come quella dei morti il giorno seguente, è svuotata dalla celebrazione, sempre più popolare, di Hallowen: un altro, triste segnale di come nella nostra società si scivoli con facilità e insensibilmente dal reale al virtuale. A un mondo invisibile, autentico e reale, il mondo della comunione dei santi, viene sostituito un mondo invisibile ma immaginario, una fiction fabbricata con le nostre mani per autoconsolazione. No, la comunione dei santi è sperimentabile, vivibile: noi non siamo soli qui sulla terra perché nel Cristo risorto siamo “communicantes in unum”!
Tratto da Dare senso al tempo, pp. 143-146