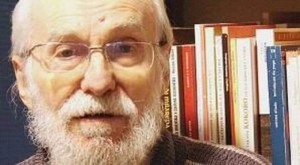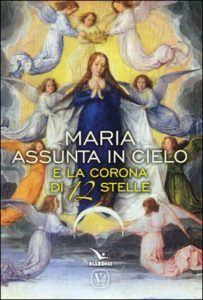di Armido Rizzi
Credo che il modo migliore per ricordare Armido Rizzi sia quello di invitare a leggere i suoi scritti. Di seguito una sua bellissima riflessione sul tema della coscienza.
È più attuale, oggi, un discorso su ciò che la coscienza non è, che non una positiva attestazione e descrizione della sua qualità; è più facile mettersi, nei suoi confronti, nei panni del pubblico ministero che in quelli dell’avvocato difensore.
Ma anche per chi vuol andare controcorrente e riaffermare tutt’intera la dignità della coscienza, non è opportuno chiudere le orecchie alle accuse che le vengono rivolte né gli occhi di fronte alle sue effettive carenze; è anzi la cosa migliore guardarle subito a viso scoperto, senza differire, e tanto meno bandire, il confronto scomodo e pericoloso. Vi sono due letture indebite della coscienza: una per difetto e l’altra per eccesso.
Una lettura per difetto
La lettura per difetto è ormai moneta circolante a ogni livello del discorso: dall’elaborazione più sofisticata alla divulgazione più estesa.
Secondo questa lettura, la coscienza è un fenomeno derivato, il prodotto di condizioni psicologiche e/o sociali che determinano il nascere di questo fenomeno e ne definiscono integralmente la realtà.
Non basta dunque, secondo questa interpretazione, riconoscere la radicazione della coscienza nello psichismo o nel tessuto sociale; bisogna individuare in tale radicazione la spiegazione totale della coscienza stessa, così che essa è – ed è soltanto – effetto e funzione di qualcos’altro: la felicità individuale e l’ordine collettivo, l’identità psicologica e l’organizzazione societaria.
Di conseguenza, la sua istanza viene relativizzata: ciò che proviene da altro e ad altro è funzionale, riceve da quest’altro il suo valore e la sua consistenza.
Ora, poiché la coscienza si presenta come istanza assoluta (lo vedremo) che esige di essere obbedita senza condizioni, una interpretazione che la subordini a un valore superiore equivale a una smentita della coscienza stessa, a una «demistificazione» di ciò che essa più gelosamente considera suo. La successiva riqualificazione della coscienza come strumento necessario per lo sviluppo della persona o per la compattezza del gruppo non va certo disattesa o considerata puro risarcimento tattico; ma non basta a restituirle ciò che le ha tolto: la sua perentorietà intrinseca, la sua forza autonoma e senza riserve.
Una lettura per eccesso
La lettura per eccesso riconosce, evidentemente, alla coscienza la sua qualità e forza immanente, ma ne estende il raggio d’azione a campi che le sono estranei o, addirittura, contrari.
Più che di un’interpretazione teorica si tratta qui di un atteggiamento pratico: appellarsi alla coscienza per esigere da sé e dagli altri, come obbligatorio, il compimento di azioni che sono invece indifferenti quando non addirittura cattive. L’esempio classico di questa indebita dilatazione della coscienza è lo scrupolo; esempi più vicini e più conturbanti sono, tra altri, il rifiuto della trasfusione di sangue, anche in pericolo grave di vita, da parte di membri di confessioni religiose; o, più ancora, l’obbedienza cieca, per esempio da parte dei nazisti, a ordini palesemente ingiusti.
Questo appello alla coscienza per giustificare prestazioni mancate o per dare forza vincolante e ineluttabile a prestazioni eseguite rende comprensibile il movimento contrario già prima presentato di inquadrarla entro una razionalità più generale che ne misura la legittimazione e ne permetta il controllo.
Effettivamente, sembra ben difficile sfuggire all’alternativa seguente: o si sottopone la coscienza a un controllo critico, a un’istanza sociale, e le si nega così il suo carattere di istanza ultima; o le si conserva questo carattere, facendone un principio insindacabile, e la si abbandona allora al rischio dell’arbitrio soggettivo, fino alle più nefaste conseguenze.
L’alternativa ha una portata molto seria; tradisce però una confusione tra due problemi collegati ma distinti:
– qual è l’essenza della coscienza, il suo costitutivo?
– come riconoscerla e discernerla nel suo esercizio pratico (cioè nei suoi contenuti concreti)?
Ognuno di questi due problemi esige una riflessione appropriata, che ne colga la valenza intrinseca e insieme la necessità del rapporto con l’altro.
L’essenza della coscienza: itinerario fenomenologico
L’orizzonte escatologico
Il sorgere dell’imperativo della coscienza fa sì che il soggetto si colga situato in una posizione nuova, finora ignota: l’azione che egli porrà, aldilà della sua specifica qualità intrinseca (onestà negli affari o truffa, fedeltà coniugale o adulterio…), gli appare investita da una intenzionalità più ampia e superiore: essa sarà un «sì» o un «no» a quell’istanza di coscienza, un’adesione o un rifiuto a quell’esigenza. E questa sua dimensione qualificherà il soggetto più profondamente di ogni giudizio di valore: egli ne uscirà buono o cattivo secondo un’accezione che non si determina unicamente dall’oggetto della sua azione ma, più propriamente, dal rapporto alla coscienza interpellatrice.
In altre parole: l’individuo sente che l’appello della coscienza gli apre davanti non una nuova possibilità ma un nuovo spessore delle possibilità già note, un orizzonte che le ricrea a un livello inatteso e impensato, indeducibile da tutto quanto era prima conosciuto.
Questo orizzonte è l’ultimo; non che venga giudicato tale in base a un criterio di misura più comprensivo: da sé s’impone come l’ultima zona cui l’esistenza dell’uomo possa accedere, come misura e criterio senza appello. E non ultimo relativamente a questa o quella sfera d’azione: ultimo per l’esistenza umana come tale. Al punto che soltanto all’apparire di questo orizzonte l’esistenza si scopre nella sua più vera identità e s’accorge di essersi fino allora ignorata. Lo possiamo chiamare «orizzonte escatologico» (da eschaton, parola greca che vuol dire, appunto, ultimo).
Di qui la difficoltà di trovare termini adeguati per esprimere il mondo dell’esperienza morale; e l’inevitabile ricorso al simbolo. L’esigenza della coscienza è una «voce», la sua indicazione una «luce» interiore; la situazione che essa determina nell’esistenza umana è un «bivio» (strada del bene e strada del male); il rifiuto ad essa una «macchia» o un «debito», e chi ha mancato deve «lavare» o «pagare»… L’uso universale (e delicato!) di simboli in questo ambito di realtà non è sintomo della sua appartenenza a un mondo fantastico, ma piuttosto riflesso della sua unicità, della sua incommensurabilità al mondo comune, alle rappresentazioni e valutazioni umane normali.
La libertà
La coscienza annuncia all’uomo la sua libertà mentre gliela conferisce. Alla presenza dell’imperativo interiore, l’individuo avverte di poterglisi concedere e rifiutare; e che l’opzione tra queste due possibilità sarà totalmente sua: egli ne sarà il principio, l’autore, il responsabile. Dove quel «sua» ha una densità che manca all’uso corrente del termine. Se russo nel dormire, quest’atto è mio; se cantando arrivo al do di petto, anche questo è mio; se in un istante di collera urlo contro l’interlocutore, l’atto è ancora mio; come mia è la pagina alata che mi erompe nel momento di grazia. Ovviamente, ogni volta il «mio» subisce una variazione d’intensità, dovuta ai diversi centri attivi che, in me, sono stati all’origine dell’atto: l’organismo, il temperamento, il genio…
Ma una costante li collega: il fatto che questi centri attivi erano «già lì in me», non per mia scelta ma come un dato; e gli atti che ne derivano sono una risultante pressoché inevitabile, scontata. Potrò vergognarmi di essi e pavoneggiarmene (come farei per una deformità o una dote fisica); non me ne sento il responsabile, non li considero «miei» in senso forte e proprio.
È quanto invece avviene nell’esperienza etica.
Invano mi attarderei a cercare in me un qualcosa su cui scaricare la responsabilità dell’opzione per il «sì» o il «no». Essa non compete a qualche parte o sezione o membro dell’io, identificabile a priori: essa scaturisce da una punta dell’io che emerge nell’esercizio dell’opzione stessa. La libertà non è una qualità del soggetto, che gli inerisca sulla linea dell’avere; la libertà è la dimensione che nel soggetto spunta alla presenza dell’appello morale: non come risultante di un passato, non come patrimonio acquisito e custodito, ma come puntuale possibilità di decisione escatologica.
C’è una certa tendenza a identificare libertà e spontaneità.
La spontaneità non è libertà, è determinismo; essa si oppone sì alla coazione, alla necessità e costrizione esteriore, ma non è altro che una suadente coazione interiore, la spinta irresistibile ad agire in un determinato modo. Quando un valore o settore di valori occupa tutto lo spazio interiore dell’uomo, vi esercita un influsso deterministico: l’individuo non ha possibilità di scelta nei confronti di quel valore, perché esso è l’ispirazione delle sue scelte, la radice e la totalizzazione delle sue opzioni. È l’orizzonte della sua coscienza (intendiamo qui coscienza psicologica).
È come quando un uomo ama perdutamente una donna: inutile farlo ragionare su base obiettiva: ogni ragione viene risucchiata entro l’orizzonte della presenza affettiva di lei, che ri-significa ogni elemento e momento della vita dell’innamorato. Costui è – relativamente – libero rispetto a tutto, salvo che rispetto a quella presenza, che interamente lo invade e lo trascina. Ma se un bel giorno nella sua vita s’insinua un’altra donna, questa nuova presenza crea un’alternativa alla prima, la relativizza: da orizzonte, quella diventa oggetto d’amore, in coabitazione con un altro oggetto entro uno slargato orizzonte d’amore. Ora l’uomo è «libero» di fronte a lei: capace di valutarla, di criticarla, di formulare riserve sul suo conto; insomma, capace di scegliere.
La libertà nei confronti di un valore nasce quando il valore da orizzonte diventa oggetto, per lo spuntare di un orizzonte più vasto, che esso non riesce più confiscare.
Ora, l’orizzonte naturale della. vita dell’uomo è il desiderio, cioè la tendenza a espandersi per realizzarsi. Tutto quanto l’uomo vuole e fa è comandato da questo impulso radicale e intrascendibile a «essere di più»; impulso essenzialmente e innocentemente egocentrico (non egoistico!), che ci porta a rincorrere la ricerca di noi stessi in tutto quanto operiamo, in tutto quanto tocchiamo, in tutto quanto amiamo. Il desiderio è il nostro orizzonte connaturato.
Ebbene, l’apparizione dell’appello morale compie il miracolo. Creando l’orizzonte escatologico, l’appello trasforma il desiderio in oggetto; introducendo nella coscienza psicologica la «voce della coscienza», vi fa sorgere un nuovo io, capace di prendere posizione di fronte al desiderio: dissocia l’io dalla solidarietà essenziale con se stesso, lo rende indipendente dall’autoidentità dinamica che lo genera e lo alimenta. In una parola: lo fa libero nel senso rigoroso del termine; fa sì che le sue azioni non siano più (soltanto) il frutto di tutto quello che esso già è da sempre, ma siano davvero «sue», oggetto di una scelta di cui l’io è veramente responsabile.
La trascendenza
Ma la voce della coscienza e il desiderio non sono due oggetti neutrali, di fronte a cui l’uomo possa scegliere a piacimento o a caso.
Se l’imperativo della coscienza si fa valere contro tutto il mondo del desiderio, è perché contiene una forza intrinseca, capace di testimoniarsi in maniera perentoria. Capire che qualcosa «è giusto», «è bene», significa comprendere che vale più dei nostri interessi, anche i più alti, significa vedere o almeno presentire che esso trascende tutto il nostro mondo, si pone di fronte ad esso come un assoluto. Quando il medico ateo, nella Peste di Camus, dice di dover restare sul posto invece che mettersi in salvo, anche se non ne capisce il perché, esprime questa misteriosa dimensione di trascendenza che inabita l’esperienza morale. Non una trascendenza cosmologica (tipo: Dio è al disopra del mondo) ma quella trascendenza esistenziale che comanda, rifonda e ristruttura l’esistenza dell’uomo.
Intendiamoci: non è che tutti i desideri debbano essere soppiantati e cambiati; è la loro qualità di desiderio che cade dal piedistallo del primato esistenziale. Fare qualcosa perché «è giusto» è rinunciare ad essere il criterio ultimo del proprio agire.
Il carattere di imperativo che la coscienza presenta, e il simbolo della voce che la esprime, sono sintomi della sua irriducibilità al volere dell’uomo: la coscienza è nell’uomo ma non dell’uomo; è l’istanza della trascendenza su di lui.
E non solo la coscienza non appartiene all’uomo, ma gli dice che neppure il mondo gli appartiene: che esso si inscrive ultimamente dentro un orizzonte non di proprietà e di dominio arbitrario ma di rispetto e di uso responsabile.
Per questo nelle culture la coscienza ha quasi sempre assunto il volto di Dio: Signore e Padre e Re dell’uomo, e poi suo Giudice inappellabile. E non che questi titoli siano derivati da altri più profondi, come creatore del mondo, causa prima, o altro; viceversa, nell’esperienza religiosa dei popoli Dio è anzitutto signore della vita dell’uomo attraverso la voce della coscienza che gli indica il «che fare», e soltanto a partire di qui si scopre anche la sua relazione – di creatore e ordinatore – con il mondo. L’esperienza della coscienza è il luogo fondamentale in cui morale e religione sorgono e si annodano. Così che la stessa esperienza morale dell’ateo è incontro anonimo con Dio, e la sua rettitudine morale è, senza saperlo, obbedienza a Dio e al suo disegno.
Il discernimento della coscienza
La fenomenologia appena tracciata non è un discorso imbastito a priori, ma il tentativo di tradurre in linguaggio concettuale quella ricchezza di significato che è già presente nel fatto morale. La coscienza è un fatto, anche se un fatto molto particolare, anzi unico; è un’esperienza, anche se un’esperienza singolarissima. La nostra descrizione ha avuto un occhio alla faccia individuale di quest’esperienza – la mia, dove nessuno mi può sostituire e che a nessuno posso delegare e un altro alla sua faccia universale – la testimonianza dei popoli lungo la storia.
Ora, questi due poli, che costituiscono la fonte di conoscenza del fatto morale e di riflessione su di esso, sono anche gli elementi della tensione che le attraversa e le inabita. L’esperienza morale è un fatto universale, ma le sue espressioni sono così variamente e profondamente differenziate da rasentare la contraddizione.
Non si tratta soltanto di accentuazioni diverse, ma di diverse strutturazioni attorno a questo o quel valore che fa da perno e da principio ordinatore; si tratta addirittura di trovare comandato da una parte ciò che in un’altra è proibito, di vedere qui esaltato ciò che là è biasimato. Daremo allora ragione al relativismo morale, che considera ogni cultura e subcultura un sistema concluso e incomparabile, per cui non ci sono valori e istanze etiche universali? Ma alla base del relativismo sta quella lettura del fatto morale che abbiamo chiamata indebita per difetto, perché lo risolve interamente nella sua funzione individuale e sociale, negando il valore assoluto della coscienza.
Chi vuol riaffermare questo valore, accogliendo la testimonianza che la coscienza dà di sé nell’esperienza viva della persona e nelle sedimentazioni della cultura, deve trovare una linea di soluzione che comprenda e rispetti la diversità senza sacrificare l’unità, deve cercare in che modo l’istanza del «giusto», del «bene» (e di Dio) si traduca in esigenza di contenuti etici coerenti, di comportamenti non contraddittori, di strade di ricerca convergenti.
Due sono le domande che, a questo proposito, si impongono: una riguarda il contenuto della morale, l’altra il metodo.
Esiste un contenuto centrale attorno a cui tutti i codici morali si organizzano, ricevendone sostanza e qualità etica?
Esiste un modo per determinare tale contenuto, nella sua valenza generale e nelle sue articolazioni e applicazioni specifiche?
Il contenuto
Malgrado la varietà di norme e di condotte morali che la storia umana presenta, non è impossibile ravvisare la presenza di un valore che su tutti emerge per continuità e per eccellenza: l’uomo. Non un’affermazione astratta dell’uomo, un’idea di umanesimo e una dichiarazione formale dei diritti umani, ma la priorità vissuta dei bisogni dell’uomo rispetto a tutto ciò che ne circonda l’esistenza.
Anche lì dove la natura appare come il principio divino della vita, come il tutto originario di cui la comunità umana è una parte, come oggetto di venerazione e di culto, si tradisce un rapporto privilegiato tra natura e uomo: il rispetto che questi le deve e le offre non è che l’altra faccia del sostentamento e della protezione che essa gli dona. Il fatto che in alcune culture vi siano animali sacri non toglie che in tutte l’uomo metta gli animali al proprio servizio – come selvaggina di cui nutrirsi o come strumenti per il lavoro – e riconosce in questo uso un fattore fondamentale dell’ordine del mondo.
Questa considerazione sincronica, fatta a livello etnologico, si integra con una considerazione diacronica, riferentesi all’evoluzione storica. Lì dove le collettività si organizzano su scala ampia, passando dalla dimensione tribale a quella nazionale, il capo re o imperatore si sente divinamente investito della responsabilità del benessere di tutta la popolazione: così avviene, per esempio, nell’antico Egitto e in Mesopotamia; così avviene, più vicino a noi nel tempo e più lontano nello spazio, nel Perù degli Incas.
Per quanto riguarda la tradizione biblica, sappiamo che essa è tutta centrata sull’alleanza Dio-Israele, dove il comandamento religioso capitale dell’amore a Dio si concretizza nel comandamento etico dell’amore al prossimo. E il suo sviluppo cristiano non fa che ribadire e accentuare la centralità etica dell’uomo, identificandolo con colui che è a un tempo Figlio dell’uomo e Figlio di Dio, e facendone metro e criterio di ogni azione e di ogni giudizio morale.
È questa centralità biblica dell’uomo che diventa fermento della civiltà europea e, tradotta in termini secolarizzati, costituisce il perno solido e sempre più ricco – almeno sul piano teorico – della coscienza etica dell’Occidente.
I principi di giustizia, libertà, pace, sono conquiste assolute della coscienza; al punto che anche i popoli del Terzo Mondo se ne appropriano in ordine alla propria promozione e alla lotta contro l’Occidente stesso, la cui prassi smentisce sovente i principi proclamati.
C’è dunque nella storia una testimonianza sempre più chiara che la coscienza che parla nell’uomo parla anche dell’uomo; che il suo dettato principale è il rispetto e la promozione dell’umano, e che tutto il resto – cose e principi, profano e sacro, costumi e istituzioni va finalizzato a questo valore, se non vuole trasformarsi in idolo.
Il metodo
Le rapide indicazioni date sul contenuto dell’etica contengono anche un fondamentale suggerimento metodologico.
Non abbiamo dedotto la centralità etica dell’uomo da principi supremi, dal concetto puro di coscienza o di bene o di Dio; abbiamo invece interrogato la coscienza morale così come di fatto si è manifestata nella storia. Non perché i fatti valgano più dei principi e delle idee, e ad essi ci si debba servilmente od opportunisticamente piegare, ma perché principi e idee morali sorgono soltanto entro il crogiolo della fattualità storica.
Anche chi crede di cercarli e trovarli altrove, senza accorgersene paga il prezzo di appartenenza alla storia degli uomini così com’è di fatto.
Chi si appella all’universalità della «ragione» o della «natura umana», in realtà carica di validità universale la propria prospettiva razionale e la propria concezione della natura umana. E chi si rifà a un’autorità morale infallibile, in realtà si affida all’autorevolezza di alcune persone, quando addirittura non cerca una delega e uno scarico di responsabilità.
Ragione e autorità sono sì criteri di cui servirsi per orientare la propria coscienza, per cercar luce sul «che fare» lungo la strada accidentata dell’esistenza. Ma nessuna di esse è criterio autosufficiente; ognuna va calata e situata in un alveo più ampio: il dialogo tra le coscienze. Non esiste un metodo morale in assoluto; esiste il luogo della ricerca morale, che è l’incontro tra le coscienze, il loro confronto: dal dibattito alla sintonia, dalla divaricazione alla convergenza.
Il soggetto dell’esperienza morale è l’individuo, ma in quanto inserito nella comunità sociale; e questo rapporto con la comunità, che parte come dipendenza, con un movimento unidirezionale, è chiamato a svilupparsi come dialogo, in un movimento di creativa interazione. Allora il soggetto plenario dell’esperienza morale è la comunità dialogante delle coscienze, dove ognuna ascolta e parla, è discepola e maestra a un tempo. Come ebbi già a scrivere, la verità etica «è affidata al soggetto collettivo della comunità umana; depositario di questa verità è l’intera umanità in quanto soggetto etico, in quanto custode dell’esperienza spirituale, della memoria storica di ciò che il passato ha vissuto di lotta tra bene e male, tra oppressione e liberazione».
La trascendenza della coscienza morale non è sinonimo di disincarnazione ma di lotta per non lasciarsi ridurre alle sue false incarnazioni; non è una stella che brilla in un cielo immobile per indicare, da quella infinita distanza, la strada da seguire, ma è la strada stessa che si illumina passo dopo passo perché inabitata da un seme di luce che le è stato deposto dentro.