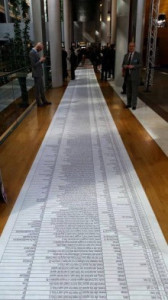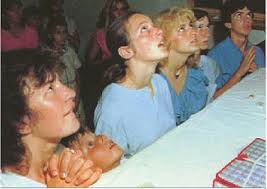Stranieri e viaggiatori sulla terra

di Christine Pedotti e Bernard
“temoignagechretien.fr” del 9 giugno 2015 (traduzione: www.finesettimana.org)
I “migranti”: questa parola è entrata nella nostra vita quotidiana. Non passa giorno che non si venga a sapere che diverse migliaia di loro sono stati salvati nel Mediterraneo (4000 in un fine settimana) o che un accampamento è stato smantellato a Parigi (400 persone precarie nel nord di Parigi) o ancora che l’Unione Europea vuole imporre delle quote che il governo francese rifiuta. Fanno parte del paesaggio dell’informazione, come il meteo e i risultati delle partite di calcio. Sono diventati parole, e le immagini si assomigliano tutte, uomini emaciati dalla pelle scura, donne avvolte in tessuti colorati…
E le parole parlano: sono “migranti”, participio presente, diversi dagli emigrati, participio passato. I secondi sono arrivati e bisogna “viverci insieme”, mentre i primi stanno ancora errando. “Stranieri e viaggiatori sulla terra”. Si fa fatica a sapere da dove vengono e non sanno dove stanno andando… vanno altrove, non hanno un luogo. Tutte le parole sono pesanti del loro peso di disgrazia e di miseria. Non hanno un luogo, non hanno niente. Non una pietra dove posare il capo, uno spiazzo dove piantare una tenda, né borse né valigie… Sì, la parola è entrata nelle nostre vite, ma non gli uomini e le donne che designa. Dopo i grandi drammi del Mediterraneo, passata l’emozione, sono ridiventati intrusi, indesiderabili.
Sì, la loro situazione è ingiusta e miserabile, “ma” non li si vuole. Il “ma” è pesante con tutto il suo peso di egoismo. “Non si può accogliere tutta la miseria del mondo”, è l’espressione di Michel Rocard, incessantemente ripetuta. Forse, tutta la miseria no, ma almeno la nostra parte, quella che dobbiamo al mondo, all’umanità, alla dignità, alla fraternità, e oso dire, all’onore di essere francesi.
Perché è una questione di giustizia, di fraternità, di onore…
Questi uomini e queste donne hanno quanto noi il diritto di vivere, di abitare questa terra. Non sono, sulla terra, più stranieri di noi. Eppure, secondo i sondaggi, solo il 7% delle persone interrogate pensa che si debba accoglierli. Il 7%! Possiamo dire che è ben poco, ma è già molto. Noi ne facciamo parte, con tutte le nostre forze, e sappiamo che ne fate parte anche voi, amici lettori e amiche lettrici. Un 7% di persone che pensano che questi uomini e queste donne meritano un “e”, non un “ma”. Sono esseri umani e vogliamo accoglierli. Per questo, bisognerà regolamentare, controllare, a volte rifiutare, siamo realisti. Ma lo faremo per accogliere e non per respingere. La nascita di “Témoignage chrétien” è stata segnata da un grande testo: “Francia, attenta a non perdere la tua anima”. Sulla questione dei migranti, ancora una volta, è la nostra anima ad essere in pericolo.
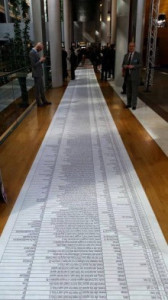
Verità e legalità
di Toni Mira (Avvenire)
Il nuovo polverone sollevato da alcuni governatori di Regioni del Nord a guida o trazione leghista, giunto all’intollerabile arma della pressione ricattatoria sui Comuni che intendono rispettare le regole – quelle dello Stato italiano e quelle dell’etica dell’accoglienza – richiede soprattutto chiarezza su questi due punti. Verità sui numeri, sugli accordi presi, perfino verità (e onestà) sulle parole, sul “di che cosa si parla”. Verità su che cosa significa, di fronte ai profughi, agire «nel nome della legge». Partiamo proprio da qui. Partiamo da chi sta arrivando sulle nostre coste. I cosiddetti “invasori”. Si tratta di richiedenti asilo, di persone che fuggono da guerre, violenze, persecuzioni. Sono loro che ora chiedono di essere accolti. Ce lo chiedono i loro occhi, ce lo impongono le norme europee e italiane, in primo luogo la Costituzione, all’articolo 10: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge».
Un diritto, dunque, che tutti devono rispettare, a partire da chi ha più responsabilità. Che, oltretutto, non può confondere le acque. Non è corretto, infatti, dire che una Regione non può accogliere questi richiedenti asilo perché già ospita tanti immigrati. Perché in questo caso si tratta di migranti per altri motivi, in gran parte economici. Comodo e cinico, troppo comodo e troppo cinico, utilizzare migranti contro profughi. Ai numeri precisi forniti dal Viminale, che denunciano la grande disparità di accoglienza dei richiedenti asilo tra Sud e Nord, non si può replicare con numeri che riguardano un altro fenomeno. Verità, dunque, rispetto dei diritti umani e del diritto italiano. E anche degli accordi presi. In primo luogo quello firmato da Governo e Regioni il 10 luglio 2014, che prevede la ripartizione dei richiedenti asilo in proporzione alla popolazione italiana residente e ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. Un accordo, non una decisione unilaterale del Governo. Ma che ora – questa volta, sì, in modo unilaterale – tre Regioni del Nord vorrebbero violare. Anzi lo stanno già violando visto che proprio Lombardia e Veneto sono lontane dai numeri previsti. E, lo ripetiamo, non si possono giustificare tirando in ballo le “presenze” di immigrati che lavorano come operai in aziende basate nel loro territorio. Per di più, quando un anno fa misero la firma su quell’intesa, conoscevano già quei numeri.
Avrebbero potuto non firmare. E sarebbe stato negativo. Ma lo è ancor più, oggi, premere sui Comuni perché non rispettino patti e regole. La legalità non è solo quella che fa più comodo. È giusto chiedere a chi giunge sulla nostre coste di rispettare le nostre regole, ed è giusto colpire, anche duramente, chi non le rispetta. Ma chi non perde occasione per riempirsi la bocca con la parola “legalità” a ogni violazione commessa da un migrante, non è poi credibile se è, lui, il primo a violare le leggi. E cercare di indurre i Comuni alla non-accoglienza è una palese illegalità, quasi un’istigazione a delinquere. Oltretutto sotto ricatto economico. Vero e assurdo ricatto, visto che le Regioni taglierebbero fondi per i residenti-contribuenti e non certo per i centri di accoglienza di profughi e richiedenti asilo che, come è noto, sono finanziati dallo Stato e, in piccolissima parte, dai Comuni stessi.
C’è, insomma, una legalità della quale pretendere il rispetto da chi arriva nel nostro Paese, da chi chiede accoglienza, e che riguarda tanto quanto chi questa accoglienza la deve civilmente dare. E non è un buon motivo per smettere di fare la cosa giusta il fatto che qualcuno sull’accoglienza ha fatto sporchi affari, come sta mettendo in luce l’inchiesta “mafia Capitale”. Continuare a raccontare agli italiani, in modo interessato, che l’accoglienza dei profughi è solo un business è una grande menzogna. C’è tanta Italia che, invece, sta aprendo braccia e cuore con efficienza e rispetto delle regole. Associazioni, mondo del volontariato, sana cooperazione, imprenditori generosi, tanti Comuni (al Sud come al Nord), uomini delle istituzioni (a partire dalle Prefetture così poco amate dagli esponenti leghisti). Cercare di impedire, con le minacce e la propaganda, che le braccia e il cuore dell’accoglienza si aprano non significa tenere gli occhi aperti, vuol dire fare un “regalo” ad affaristi. È favorire la cultura dell’illegalità. Che è sempre «cultura dello scarto» di esseri umani.

il muro del nord
di Guido Viale
in “il manifesto” del 9 giugno 2015
Il capitolo «secessione», che le Regioni leghiste (la “Padania” senza più il Piemonte, ma con in più la Liguria) non erano riuscite ad aprire e legittimare in campo fiscale, viene oggi riproposto sulla questione delle «quote» di profughi e migranti da trasferire al Nord dai porti di sbarco; nonostante che a guidare la rivolta sia proprio Maroni, l’ex-ministro che quelle quote le aveva introdotte. Ma questa volta la fronda leghista avrà un impatto maggiore, perché è in perfetta sintonia con le posizioni che i paesi dell’Unione Europea stanno adottando nell’affrontare lo stesso problema: «Teneteveli».
Cioè: anche se, contro gli intenti originari, la missione Triton è costretta a salvarli, i profughi restino là dove sbarcano. E con loro se la vedano i paesi e le regioni a cui li lasciano in carico. Il default greco non è dunque più l’unica minaccia per la coesione dell’Unione Europea.
Una governance che si comporta così verso i suoi membri non è più la legittima guida dell’Ue, come non sarebbe più uno Stato unitario quello che accettasse una divisione simile tra le sue Regioni.
Le destre italiane ed europee lo sanno, anche se ancora possono — e torna loro comodo — nascondere a se stesse e agli altri le conseguenze di questa linea di condotta: che è destinare allo sterminio milioni di esseri umani. Cioè, proprio la riproposizione di ciò che la Comunità, poi Unione Europea, ha come sua ragion d’essere originaria: che le tragedie prodotte da due guerre mondiali e dai campi di sterminio «non abbiano a ripetersi mai più». Invece sono di nuovo davanti a noi, e tra noi. Non lo si può ignorare. Le deboli forze che in Italia e in Europa si battono per un mondo diverso ne devono prendere atto; anche se questa è in assoluto la più difficile delle battaglie che finora non siamo stati capaci di combattere, e soprattutto di vincere.
Che cosa significa infatti quel «teneteveli», rivolto non solo a Italia e Grecia, Sicilia e Puglia, ma anche a Libano, Giordania, Turchia, Egitto, che di profughi ne «ospitano» già non decine di migliaia, ma milioni? O rivolto a Libia, Tunisia, Sudan, Mali, Niger, ecc.? Paesi, questi, dove non si riesce neppure a fare una conta sommaria degli sbandati (displaced persons) e dove è ormai impossibile distinguere tra profughi di guerra, di persecuzioni politiche, religiose o etniche, di crisi ambientali o di fame e miseria (i cosiddetti migranti economici); anche se l’esito di queste tante concause è quasi sempre una guerra alimentata dal commercio di armi a beneficio di nazioni che le producono.
L’Italia affronta il problema affidandolo a malavita, mafia e malgoverno, gli strumenti tradizionali di gestione di tutte le emergenze vere o inventate: Expò, Mose, rifiuti, terremoti, alluvioni, elezioni, sanità, lavoro nero. Con i profughi, gli affari di mafia e malgoverno si associano a sfruttamento, umiliazione e degrado di coloro che vengono affidati alle loro «cure». Ma anche a crescenti motivi di timore, malcontento, rivolta aperta; a invocazione di poteri forti e soluzioni definitive (o «finali»?); a professioni di razzismo ostentate delle popolazioni locali.
Ma in che modo pensiamo che vengano gestiti in Medio Oriente i campi profughi di milioni di esseri umani senza alcuna prospettiva di ritorno alle loro terre per molti anni? E in Libia, in Sudan, o in tutti gli altri paesi verso cui li vorremmo risospingere? E che cosa ci aspettiamo che facciano i Buzzi o gli Alfano di quei paesi? Il loro lavoro sarà «farli sparire», dopo averli torturati, rapinati e violati in tutti i modi: unica alternativa alla mancata possibilità traghettarli in Europa.
Ma lo Stato italiano, lasciato solo a vedersela con flussi crescenti e incontrollabili, diventerà anch’esso destinatario dei respingimenti: ridotto a trasformare la polizia, come già sta facendo, in «scafisti di Stato», per cercare di far passare la frontiera, in violazione della convenzione di Dublino, al maggior numero possibile di migranti; o a «esternalizzarne» la gestione a organizzazioni alla Buzzi (ma in campo c’è già anche di peggio); o ad abbandonarli per strada, inscenando fughe di massa dai luoghi di detenzione, e creando così situazioni di degrado e di effettivo pericolo con cui alimentare rivolte sempre più diffuse di comunità locali.
Che l’Italia possa rimanere «agganciata» all’Europa in una situazione del genere è difficile. Ma che l’Europa possa continuare a occuparsi di sforamenti dei deficit dello «0 virgola», senza darsi uno straccio di politica per affrontare, in una prospettiva di pacificazione, la belligeranza endemica ai suoi confini, o le derive autoritarie, nazionalistiche e razziste al suo interno, è altrettanto surreale.
D’ora in poi tutti i progetti per cambiare la società, o la distribuzione del reddito, o per difendere lavoro, territorio, scuola, sanità, cultura, diritti, dovranno confrontarsi con il problema dei profughi e dei migranti: per cercare una via di uscita pacifica e negoziata alla crisi geopolitica del Mediterraneo; e per trovare un posto e un ruolo alle centinaia di migliaia che cercano salvezza in Europa.
Una via di uscita sostenibile, accettabile per tutti, che riduca anziché esacerbare le molte ragioni di contrasto tra locali e migranti; che permetta di vivere l’arrivo di tanti profughi non come una minaccia e un peso insostenibili, bensì – lo hanno dimostrato vicende locali esemplari, come quella di Lampedusa — come un’opportunità di nuove forme di convivenza, di crescita culturale, di apertura politica, di un approccio di respiro euro-mediterraneo ai problemi quotidiani: un approccio, cioè, che riguardi al tempo stesso il nostro continente e i paesi dell’Africa, del Maghreb e del Medio Oriente.
Con un piano che deve, sì, essere europeo, ma che va messo a punto qui, cominciando a dimostrarne la fattibilità per piccoli episodi: a partire da una vigilanza e una contestazione diffuse e di massa su tutti gli affidi in materia di accoglienza e gestione dei profughi.
Innanzitutto i cittadini italiani non devono essere messi nella condizione di temere che a loro siano riservate meno risorse e meno opportunità di quelle destinate a profughi e migranti: dunque, reddito garantito e piani generali per creare lavoro e dare occupazioni e soluzioni abitative decenti a tutti (e fine, quindi, dei patti di stabilità).
Poi, autogestione: è criminale costringere i profughi «accolti» a un ozio forzato di anni e affidare a imprese cosiddette sociali la gestione di ogni aspetto della loro vita quotidiana. Assistiti e controllati, profughi e migranti possono gestire da soli risorse ed edifici riservati alla loro permanenza.
Poi devono essere distribuiti sul territorio, con misure per facilitare contatti e scambi con i locali: accesso a scuole, sanità, attività ricreative, mediazione culturale. Infine devono potersi organizzare anche sul piano politico, valorizzando i contatti tra comunità nazionali già insediate in Europa, e con chi è restato nei paesi da cui sono fuggiti.
La costruzione di una identità regionale – di una comunità euro-mediterranea, da fondare sulle macerie dell’Unione attuale, che ha dimenticato le ragioni che l’hanno fatta nascere — ha bisogno di queste cittadine e cittadini, che qui possono mettere a punto un progetto, un embrione di governo in esilio, e una road map per il riscatto politico e sociale dei loro paesi di origine.
È una strada lunga e tortuosa (come lo è stata quella che ha portato alla fondazione dell’Unione Europea), ma ineludibile per non venir sopraffatti da una guerra permanente ai confini dell’Unione e dal trionfo del razzismo al suo interno.
P.S. Questo è un tema ineludibile per la coalizione sociale, un progetto che poteva nascere un anno fa con L’Altra Europa con Tsipras, ma che è stato disatteso a favore di un ennesimo assemblaggio di inutili partitini; ma che per fortuna è stato ripreso dalla Fiom e da tutti coloro che vi si stanno impegnando.