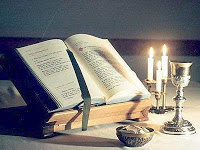MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2020
LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA

1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino».[1] In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari.
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana.
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo.
Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viaggio in Giappone, che «il nostro mondo vive la dicotomia perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di domani».[2]
Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Sfiducia e paura aumentano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai condurre a una relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può che creare una sicurezza illusoria.
Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri.[3] Come, allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della paura? Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente?
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità
Gli Hibakusha , i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli 
che oggi mantengono viva la fiamma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. La loro testimonianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza umana diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione: «Non possiamo permettere che le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è garanzia e stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno».[4]
Come loro molti, in ogni parte del mondo, offrono alle future generazioni il servizio imprescindibile della memoria, che va custodita non solo per non commettere di nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli schemi illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell’esperienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di pace.
Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: molte volte nel buio delle guerre e dei conflitti, il ricordo anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, può rimettere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle comunità.
Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici e contradditori. Occorre, innanzitutto, fare appello alla coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in effetti, si attinge nel profondo del cuore umano e la volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi processi che riconcilino e uniscano persone e comunità.
Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La pace è «un edificio da costruirsi continuamente»,[5] un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello.
Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza comune, più forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la democrazia può essere un paradigma significativo di questo processo, se è basata sulla giustizia e sull’impegno a salvaguardare i diritti di ciascuno, specie se debole o emarginato, nella continua ricerca della verità.[6] Si tratta di una costruzione sociale e di un’elaborazione in divenire, in cui ciascuno porta responsabilmente il proprio contributo, a tutti i livelli della collettività locale, nazionale e mondiale.
Come sottolineava San Paolo VI, «la duplice aspirazione all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a promuovere un tipo di società democratica […]. Ciò sottintende l’importanza dell’educazione alla vita associata, dove, oltre l’informazione sui diritti di ciascuno, sia messo in luce il loro necessario correlativo: il riconoscimento dei doveri nei confronti degli altri. Il significato e la pratica del dovere sono condizionati dal dominio di sé, come pure l’accettazione delle responsabilità e dei limiti posti all’esercizio della libertà dell’individuo o del gruppo».[7]
Al contrario, la frattura tra i membri di una società, l’aumento delle disuguaglianze sociali e il rifiuto di usare gli strumenti per uno sviluppo umano integrale mettono in pericolo il perseguimento del bene comune. Invece il lavoro paziente basato sulla forza della parola e della verità può risvegliare nelle persone la capacità di compassione e di solidarietà creativa.
Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente memoria di Cristo, che ha donato la sua vita per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5,6-11). La Chiesa partecipa pienamente alla ricerca di un ordine giusto, continuando a servire il bene comune e a nutrire la speranza della pace, attraverso la trasmissione dei valori cristiani, l’insegnamento morale e le opere sociali e di educazione.
3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”» ( Mt 18,21-22). Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace.
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello politico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di costruire un più giusto sistema economico. Come scriveva Benedetto XVI, dieci anni fa, nella Lettera Enciclica Caritas in veritate : «La vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e comunione» (n. 39).
4. La pace, cammino di conversione ecologica
«Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possiamo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto custodire».[8]
Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno di una conversione ecologica.
Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze.
Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione del mondo che ci è stato donato da Dio affinché ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le risorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 2,15) anche per le generazioni future, con la partecipazione responsabile e operosa di ognuno. Inoltre, abbiamo bisogno di un cambiamento nelle convinzioni e nello sguardo, che ci apra maggiormente all’incontro con l’altro e all’accoglienza del dono del creato, che riflette la bellezza e la sapienza del suo Artefice.
Da qui scaturiscono, in particolare, motivazioni profonde e un nuovo modo di abitare la casa comune, di essere presenti gli uni agli altri con le proprie diversità, di celebrare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, di preoccuparci di condizioni e modelli di società che favoriscano la fioritura e la permanenza della vita nel futuro, di sviluppare il bene comune dell’intera famiglia umana.
La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di «lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo».[9]
5. Si ottiene tanto quanto si spera [10] 
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera.
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile.
La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare oltre i nostri timori umani, riconoscendoci figli bisognosi, davanti a Colui che ci ama e ci attende, come il Padre del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-24). La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della minaccia. Rende ogni incontro una possibilità e un dono dell’amore generoso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità universale, come figli dell’unico Padre celeste.
Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» ( Col 1,20); e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il prossimo sia verso il creato.
La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in sé.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2019
Francesco
[1] Benedetto XVI, Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), 1.
[2] Discorso sulle armi nucleari , Nagasaki, Parco “Atomic Bomb Hypocenter”, 24 novembre 2019.
[3] Cfr Omelia a Lampedusa , 8 luglio 2013.
[4] Discorso sulla Pace , Hiroshima, Memoriale della Pace, 24 novembre 2019.
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes , 78.
[6] Cfr Benedetto XVI, Discorso ai dirigenti delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani , 27 gennaio 2006.
[7] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 24.
[8] Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 200.
[9] Ibid. , 217.
[10] Cfr S. Giovanni della Croce, Notte Oscura , II, 21, 8.messaggio