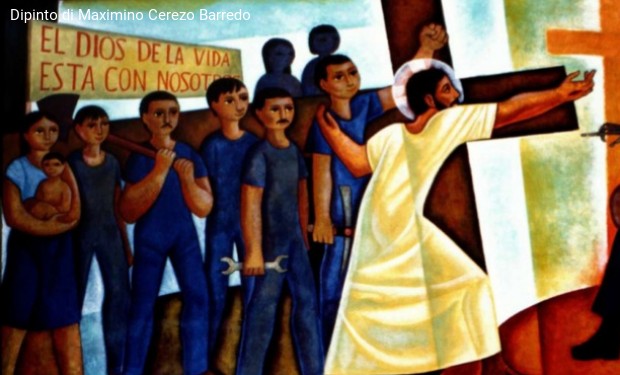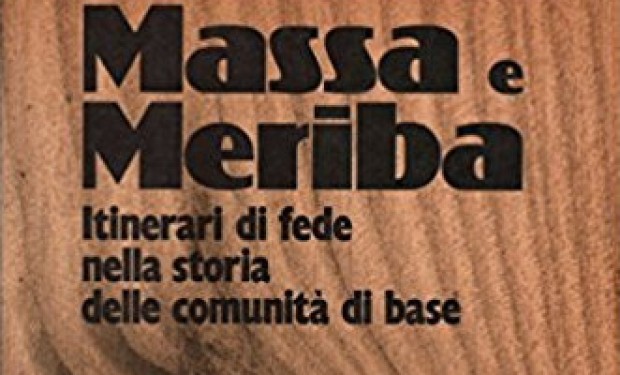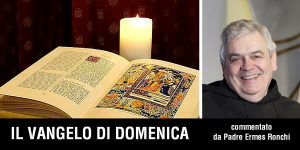dal nazionalcattolicesimo al postcristianesimo
le CdB in Spagna e la TdL
Introduzione
La Teologia della Liberazione è la conseguenza più onesta del Vaticano II, nata in parte nelle catacombe romane ed emarginata dalla curia romana fin dal primo momento. Tutto il potere e tutto il peso della Basilica di San Pietro sarebbero ricaduti a piombo negli anni successivi su questo sottosuolo evangelico. (…). L’espressione più rilevante di questo rinnovamento è stata la formazione di un grande movimento dalla duplice militanza, cristiana e politica, sotto forma di piccole comunità. Alle frontiere della stessa Chiesa, molti catechisti, religiosi/e e sacerdoti si sono avvicinati ai poveri, agli indigeni, agli abitanti delle baraccopoli e ai contadini che con fatica si guadagnavano il pane e che per le loro proteste perdevano facilmente la vita. Il martirologio latinoamericano mostra la radicalità e la santità che hanno caratterizzato la sequela di un Gesù di Nazaret sempre nuovo, povero e sovversivo, profeta al servizio del popolo.
In Spagna l’esempio latinoamericano si diffuse rapidamente soprattutto tra i cristiani a cui il Concilio aveva dato speranza. Erano i settori che si andavano distaccando dall’ortodossia e dal concubinato politico con il regime franchista: una piccola borghesia sinceramente religiosa, lavoratori dell’industria dalla religiosità ancora profondamente rurale, professionisti liberali, studenti contestatari e i resti della sinistra che aveva perso la guerra ma che non per questo aveva rinunciato alla sua cultura cristiana.
Si originò allora una dinamica di avvicinamento alla “classe operaia”, di proletarizzazione e di prossimità nelle periferie. Il misticismo rivoluzionario si fece spazio ispirandosi all’Esodo e ai Profeti. (…).
Influenza della Teologia della Liberazione in Spagna
Il libro Marx e la Bibbia di José Porfirio Miranda non è il più importante della TdL, ma è di certo uno dei più rilevanti per le comunità. Significativamente, poneva la giustizia interumana come principio etico comune al marxismo e al cristianesimo. «Fede significa credere che questo mondo ha un rimedio». L’analisi marxista delle alienazioni e l’interpretazione materialista della storia iniziarono a costituire la mediazione di cui la teologia aveva bisogno per uscire dalle eteree e screditate interpretazioni metafisiche. Si scopriva così un «amore più universale e pertanto più divino» di quello legato alle classi potenti il cui Dio era seduto alla «mensa del padrone». La sociologia marxista e la rivoluzione dei cristiani si collocavano così nell’occhio del ciclone ecclesiastico e politico.
Con questo avvicinamento strutturale ai poveri sorge anche un nuovo paradigma, una sincera chiave di interpretazione della realtà, al tempo stesso molto semplice e molto potente: quello in base a cui non è il pensiero quello che determina la maniera di essere o di vivere, ma è l’esistenza reale, la condizione sociale, a determinare il modo di pensare e pertanto di agire. (…).
Tale paradigma (…) impregnò l’esperienza cristiana in modo tale che, malgrado la profonda trasformazione delle società, persiste ancora oggi, sebbene con nuovi modi di espressione: con minore radicalità, forse, ma con maggiore estensione. (…).
E diciamo anche che questa teologia è venuta per riconciliare la Chiesa con la sinistra, poiché fino agli anni Sessanta l’esclusiva del cattolicesimo l’aveva la destra. È venuta per fare da ponte tra il cristianesimo sincero di alcune famiglie e gli “eroi rossi” sconfitti in guerra. E ciò nonostante l’episcopato e la gerarchia in generale, malgrado papa Francesco, facciano ancora resistenza. Ed è venuta anche per costruire l’istmo di un umanesimo liberatore universalista. Un movimento che assume e supera le religioni e le ideologie, il teismo e l’ateismo, e che unisce “greci, ebrei e gentili” in una convocazione plurale e indefinita interpretata dalle comunità sotto le metafore del Regno e del Padre. Vale a dire, animata dal cielo stellato della fraternità universale e mossa dalla memoria della migliore “buona volontà” dentro di noi (Kant).
Traiettoria delle Comunità di base in Spagna
a) La rottura con il nazionalcattolicesimo, anni ’60-’70
Il nazionalcattolicesimo è nato dalla simbiosi tra il regime franchista vincitore della guerra civile e la Chiesa spagnola schierata in difesa dei valori più tradizionali del cattolicesimo e della legittimità di tale guerra, definita come una crociata. (…). Una dittatura cattolica. Una “triplice alleanza”: tra l’esercito golpista, il potere economico beneficiato dalla guerra e la Chiesa anticomunista e tridentina. (…)
Da questo cattolicesimo borghese, centrato sul culto, sulla salvezza individuale, sul moralismo, soprattutto sul terreno della sessualità, e sull’”altro mondo” – da conquistare attraverso la reiterazione magica dei sacramenti –, si è passati a un cristianesimo della solidarietà tra fratelli, impegnati a conquistare la propria dignità e a ricercare insieme una liberazione dalle proprie condizioni di vita. Un passaggio sperimentato congiuntamente nel seno di una comunità.
Per questo quasi si può dire che fu un miracolo uscire da quella situazione di oscurità. Ma il miracolo ci fu, a partire dagli anni ’60, grazie a diverse e decisive circostanze (…), a cominciare dalla scoperta della povertà estrema nei quartieri periferici in virtù delle missioni catechetiche. (…).
In questo divorzio con il regime assume un ruolo di rilievo José María de Llanos, il mons. Romero spagnolo, come potremmo chiamarlo. E con lui José María González Ruiz, parroco di periferia e canonico della cattedrale di Malaga, il teologo spagnolo forse più influente al Vaticano II (…) e José María Díez Alegría, fratello di due illustri generali dell’esercito vittorioso (…), che passò dalla direzione degli esercizi spirituali di Franco alla periferia più povera di Madrid, il Pozo del Tío Raimundo, dove sposò la causa dei lavoratori e delle loro lotte ed entrò nel sindacato Comisiones Obreras, e successivamente nel Partito Comunista. Fu uno scandalo per il regime e una follia per la fede, di grande impatto sul nascente cristianesimo popolare delle comunità. Un percorso simile a quello di un altro gesuita, “Paco el Cura”, Francisco García Salve, figlio di una guardia civile assassinata dagli anarchici (…), che diventò membro del Comitato Centrale del Partito Comunista e della direzione di Comisiones Obreras, e, come tale, condannato nel famoso «processo 1001» del 1973 (quello con cui il Tribunale di Ordine Pubblico condannò al carcere dieci dirigenti del sindacato clandestino Comisiones Obreras per delitto di associazione illecita, ndr).
In Europa è imminente il “Maggio del ’68” e negli Stati Uniti esplode la contestazione della guerra in Vietnam. A Cuba trionfa Fidel e in Spagna i seminari entrano in ebollizione. (…). La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) e la JOC (Juventud Obrera Cristiana) si avvicinano alle cattive compagnie della sovversione marxista. I “preti operai” abbracciano con grande sacrificio il lavoro manuale salariato. Gruppi di religiosi e religiose (…) vanno a vivere in appartamenti condividendo la vita quotidiana, il mercato e la strada con le altre persone. Si cedono i locali parrocchiali alla lotta operaia, allora clandestina, e i loro ciclostili stampano più volantini che fogli parrocchiali.
La “Parola di Dio”, la buona semente, non viene più lasciata con devota parsimonia sui banchi della chiesa, ma è lanciata con rabbia sulle strade, all’alba. Ed è in questo contesto che irrompe la Teologia della Liberazione. E che si forgiano le Comunità di Base e altri gruppi simili.
Tanto in America Latina quanto in Spagna furono momenti di mistica messianica. Gesù era un rivoluzionario come il Che, come Fidel, come, allora, Daniel Ortega. (…). E se c’erano resistenze nei riguardi del marxismo, si prendeva come esempio la non violenza di Gandhi o di Martin Luther King. Gli Stati Uniti erano il Leviatano capitalista. (…). Credere era impegnarsi, partecipare alle lotte operaie e di quartiere e celebrare la memoria sovversiva di Gesù di Nazaret. (…).
Nelle facoltà di teologia, oltre al marxismo, si insegnava la psicoanalisi e l’evoluzionismo di Teilhard de Chardin. Si leggeva Camus, Sartre, Simone de Beauvoir. Con John Arthur Thomas Robinson e il suo libro Honest to God, ci avvicinammo a Bonhoeffer e a Tillich. Nelle comunità e nei loro gruppi di formazione si divulgavano questi scritti e si leggevano direttamente i teologi più pastorali: Hélder Câmara, Roger Garaudy, Giulio Girardi, García Nieto e Comín, che danno avvio in Spagna al movimento dei “Cristiani per il socialismo”. Proliferano i quaderni di formazione come la Teologia Popolare di José María Castillo, le riviste della HOAC, Noticias obreras, Exodo e Utopía, quest’ultima delle nostre comunità. Julio Lois, Juan José Tamayo, Pedro Casaldáliga, Ivone Gebara, González Faus e i quaderni di “Cristianismo y Justicia”, per fare alcuni esempi, avrebbero portato avanti successivamente questa pedagogia della liberazione. Le poesie di Ernesto Cardenal o le canzioni di Víctor Jara, Violeta Parra, Carlos Mejía Godoy e poi Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, tra altri, ci trasmettevano, molte volte, più teologia di molti scritti accademici.
b) La alternativa cristiana. Le CdB, anni ’70 e ’80
Le Comunità di Base vivono il loro apogeo in questi due decenni. (…). Il libro La alternativa cristiana di José María Castillo (…) rappresenta assai bene ciò a cui si mirava in quel periodo. Un’alternativa alla Chiesa tradizionale. Una rinascita del cristianesimo a partire dal popolo, ma senza abbondonare quella Chiesa. Ci ponevamo in un’appartenenza critica. Volevamo essere “l’altra voce della Chiesa” e compensare l’eccessiva loquacità di destra della gerarchia, che quasi sempre metteva in cattiva luce il vangelo. (…).
L’assassinio di mons. Romero nel 1980 fu uno dei momenti più importanti, per ciò che significava come esempio di conversione al vangelo dei poveri a partire da un’alta sfera dell’Istituzione. La sua morte diede vita ai Comitati Oscar Romero, che portarono la Teologia della Liberazione in tutto il mondo. Qualcosa di simile avviene con l’assassinio dei gesuiti e delle due donne che li aiutavano in El Salvador. (…). Alla fine degli anni ’80 inizia un lavoro meno vistoso e più efficace sul terreno istituzionale. (…). Nelle comunità si va diffondendo a poco a poco un clima di disincanto e di desolazione. Soprattutto nella misura in cui Giovanni Paolo II va stravolgendo lo spirito del Vaticano II e attaccando e umiliando la Teologia della Liberazione nella persona di Ernesto Cardenal, durante la sua visita in Nicaragua. La Spagna entra in un’epoca di prosperità economica che va ampliando le classi medie, con le quali si impone un profilo più conformista. (…).
c) La cooperazione internazionalista, dal ’90 al 2005 Il cristianesimo della liberazione si dispiega in nuovi movimenti sociali e nella pre-politica mondialista. Gli sguardi si rivolgono al Sud. (…).
La caduta del muro di Berlino e con essa il discredito dei Paesi del socialismo reale pone fine alla rivoluzione intesa in modo classico e apre la porta al pensiero unico e alla globalizzazione. Fukuyama pubblica La fine della storia per confermare il trionfo del capitalismo. Ma parallelamente sorgono anche i movimenti antiglobalizzazione, i forum sociali e l’altermondialismo: il Vertice di Rio nel 1992, le proteste di Seattle nel 1999 e il primo Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001 (…).
A poco a poco si va imponendo anche una nuova cultura, la postmodernità. La liberazione compete con il gusto per la vita e i costumi si liberano dalla religione. (…). L’individualismo, la solitudine e l’anonimato si espandono per le città sempre più cosmopolite. Si consolidano i tratti che successivamente Bauman riassumerà nel concetto di “società liquida”.
Le comunità affrontano questi momenti di difficoltà con molteplici iniziative. Revisione delle proprie basi identitarie, gruppi di formazione e di preghiera, giornate statali di riflessione. Ogni incontro statale diventa motivo di speranza esprimendo una volontà di rilancio, benché domini la nostalgia del profetismo di un tempo. (…). Negli ultimi anni del XX secolo alcune visioni teologiche acquistano una speciale importanza. Cresce l’interesse per la ricerca di nuovi simboli, considerando il logoramento dei sacramenti classici. La disaffezione dalla Chiesa diventa sempre più forte e la funzione del sacerdote non viene più riconosciuta. (…). La celebrazione dell’eucarestia si rinnova completamente. Diventa qualcosa che appartiene a tutta la comunità: la riflessione, la preghiera e un pasto comune in memoria dell’ultima cena di Gesù. Non si tratta di pasque ebraiche né cristiane, né tantomeno di sacrifici redentori e le donne iniziano a presiedere la celebrazione. A poco a poco si perde il carattere sacro e si valorizza maggiormente la dimensione comune derivante dalla condivisione dell’azione sociale e dell’opzione per i poveri. Non ci sono consacrazioni né liturgie. Si tratta di nuovi simboli vincolati alla gratuità e all’amore disinteressato, soprattutto di carattere civico. E le comunità passano a concentrarsi sull’aiuto ai migranti e sull’accoglienza ai rifugiati.
Con le nuove tecnologie dell’informazione, le reti sociali e i cellulari, l’attivismo sociale cresce nel mondo virtuale e si proietta sulla realtà. Le nuove tecnologie, le neuroscienze e la robotica annunciano un mondo ancora più contraddittorio rispetto ai vecchi racconti biblici ed emancipatori. La TdL, che aveva eclissato i problemi metafisici ed esistenzialisti, torna ad affrontare le questioni radicali della finitezza e del limite, ora passati per il setaccio della vita reale e collettiva: un altro mondo è possibile? Quanto dureranno le conquiste popolari? (…). Cosa o chi garantisce che il mondo trovi un rimedio? L’oppressione e l’ingiustizia sono viste nell’ottica del tradizionale problema del male, e il paradiso comunista o comunitario entra nell’incertezza del mistero e dell’enigma. Il pluralismo religioso pone sul tappeto la questione della relatività delle risposte religiose.
La fede che cerca di comprendere si sente sola e insicura. I cristiani, non più tanto della base, sono ora compagni di viaggio di agnostici e anateisti.
d) Post-religione e umanesimo universalista. Dal 2005 a oggi
Il cristianesimo si è sempre rinnovato. E se tante volte è entrato in crisi, generalmente a causa del potere, che lo si chiami ricchezza, autoritarismo o egocentrismo, altrettanto spesso ha assistito al ritorno dei profeti. Ma ora la crisi e la mutazione che l’accompagna appaiono più profonde, avendo a che fare con aspetti essenziali del credo cristiano, compreso di di ciò che si credeva fosse il messaggio originario del Vangelo. Le coordinate o paradigmi che reggono il mondo sono cambiati profondamente. La globalizzazione della povertà si manifesta attraverso un’enorme forbice di disuguaglianza tra l’1% rappresentato dal potere finanziario e il 99% degli impoveriti. L’intero pianeta si trova in estremo pericolo. E d’altra parte l’intelligenza artificiale, l’ingegneria genetica, i bigdata e via dicendo sembra vogliano condurci al bordo del “transumanesimo”, dell’affermazione di un’intelligenza artificiale.
In questo panorama molti si spingono ad affermare che ci troviamo in un nuovo tempo assiale. In una fase convulsa di metamorfosi che, nel caso del cristianesimo, si traduce in una decostruzione del grande racconto della Salvezza e in un imminente volo della farfalla verso la convergenza dell’umanità. Le comunità non respirano più al ritmo dei grandi avvenimenti salvifici enunciati nella prima teologia paolina.
La Bibbia è per noi una grande metafora: non ha la ragione, ma ha anima di liberazione. La creazione, il peccato, l’incarnazione, la redenzione o la resurrezione e la vita eterna non sono sequenze di una grande epopea storica. Sono simboli delle costanti esistenziali della condizione umana e dell’invito alla fraternità.
Le opere di Lenaers, Spong, Knitter, Hick e altri, che le comunità hanno potuto conoscere grazie a Servicios Koinonia, alla biblioteca Relat (Revista Latinoamericana de Teología) e ai successivi incontri con José María Vigil nelle sue visite in Spagna rappresentano l’ultimo passo dell’influenza della TdL nelle comunità. Tali letture ci hanno provocato in un primo momento uno sconcerto profondo e doloroso, ma ci hanno permesso l’accesso a un nuovo paradigma post-religionale e sovra-religionale che genera in noi sollievo e fa nascere un nuovo spirito di liberazione. È la grande onda della massimizzazione dell’amore civico che si esprime in tutta la sua purezza quando abbraccia i più sfavoriti.
Appendice
La speleologia della speranza
“…E arrivarono tempi oscuri
in cui tutte le nostre conquiste furono distrutte
da orde di ciechi mercenari
al servizio del potere del denaro.
Una volta ancora la speranza
fu costretta a cercare rifugio
nella grotta più profonda
per evitare che l’avidità la demolisse
cancellandone la memoria;
e fu necessario mantenere il silenzio,
lontano dalle cose, in modo che il silenzio ci restituisse
la coscienza semplice dell’amore
e il senso compiuto della parola”.
(Frammento di una poesia trovato nelle rovine di Babilonia, presso la porta di Ishtar).
Doveva essere questo il titolo di questo articolo: “La speleologia della speranza”, ma mi sembrava troppo magniloqente. Non lo è però qui, come epigrafe di un’appendice. Uso questo termine, “speleologia”, del tutto intenzionalmente, perché il compito che presuppone è quello della ricerca e della creatività. Perché la “teologia” si indebolisce nella misura in cui crescono l’antropologia e la sociologia delle molteplici trascendenze umane. Come tali mirano all’assoluto, senza arrivare a toccarlo o a macchiarlo. E ci dobbiamo abituare a restare nella caverna cercando di uscirne. Siamo incomprensione e limitazione, carne di relatività che dice Dio, Libertà. Siamo umanità scissa a causa dell’ingiustizia in attesa di un’integrazione fraterna.
Uso questo termine anche perché la speranza non può che essere attrattiva. Come possiamo entusiasmarci per qualcosa che ci oltrepassa se viene annunciato a partire da una sofferenza obbligata e dall’impotenza di una “missione impossibile”?
Cerchiamo allora attraverso le crepe della complessa ingiustizia di questo tardo capitalismo, finanziario e distruttore, soluzioni economiche e di pace; guardiano ai filoni della contingenza per scoprire aperture di libertà duratura. La speleologia è un magnifico lavoro di scoperta che richiede una luce potente sul proprio casco, intensa suspense e lavoro pericoloso.
La fede che nasce tra i poveri si chiama speranza. Il potente vive nella sicurezza dei cieli luminosi, conosce Dio, sa chi è e lo chiama per nome, perché sta con lui. Il povero ne avverte l’assenza, va a tentoni e lo attende e lo ama senza una sufficiente ragione. La Prassi della Liberazione ha aperto nella caverna umana filoni di fede profonda e di compassione attiva, ogni giorno più vasti.
* Basílica de Nuestra Señora del Pilar a Saragozza in una foto [ritagliata] di LeyLeyLey, tratta da Pixabay

l’America Latina dinanzi alla ricezione della TdL in Europa
Qualche parola ulteriore dall’America Latina, per (…) esprimere con fiducia alcune convinzioni latinoamericane che affiorano nel nostro cuore dopo questo “dialogo con l’Europa” in cui consiste di fatto questo numero di Voices dedicato alla ricezione della Teologia della Liberazione in Europa.
Di fronte a una ricezione così varia e multiforme (…), nascono in noi queste parole fraterno-sororali, da TdL a TdL, rivolte a tanti fratelli e sorelle e a tante comunità che pensano, pregano e praticano questa teologia uguale e al tempo stesso diversa, che ci unisce nella lotta per la stessa Causa, l’Utopia di Gesù.
1. TdL, una teologia veramente latinoamericana
Teologie ve ne sono molte in America Latina, ma la TdL è quella che più propriamente può essere definita davvero latinoamericana, cioè nata e cresciuta qui e identificata pienamente con valori tipicamente latinoamericani. Altre teologie possono magari vantare più adepti e un maggiore appoggio istituzionale, ma sono teologie nate in un altro luogo, teologie importate e a volte imposte.
Per quanti di noi l’accompagnano dalla sua nascita, riveste un grande significato per questo continente: è il primo corpus sistematico di teologia elaborato al di fuori dell’Europa. E non è il risultato di una mera applicazione del Concilio Vaticano II al continente latinoamericano: l’applicazione effettivamente realizzata dalla II Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano di Medellín è risultata molto creativa e ha rappresenta to un salto qualitativo verso un nuovo paradigma (storico, critico, liberatore, a partire dall’opzione per i poveri…) realmente nuovo, nella storia non solo del continente, ma della Chiesa intera. Ha aperto prospettive nuove che non erano presenti nel testo conciliare che sembrava dovesse “semplicemente” applicare.
Nei primi anni ’80 si discusse ampiamente della differenza specifica (se ci fosse e quale fosse) tra la TdL e la cosiddetta teologia progressista europea, che, senza dubbio, aveva contribuito notevolmente all’apparizione della TdL. Sappiamo bene che, in una sana teologia, non è possibile una novità assoluta. E sappiamo bene anche che la TdL non ha un “padre”, né riconosce alle sue origini alcun maestro che abbia creato intorno a sé questa “scuola teologica”, bensì è andata sorgendo collettivamente, un po’ ovunque in America Latina, a partire dall’esperienza spirituale e dalla prassi di un popolo “oppresso e credente” come quello latinoamericano. Un’esperienza che è stata un “atto primo” di cui la TdL che è sorta in America Latina sarebbe un atto secondo.
Ma questo atto secondo non avrebbe potuto aver luogo se non fosse stato per il Concilio Vaticano II che si intendeva applicare (e che di certo ha avuto molto poco di latinoamericano), e per i primi sviluppi della teologia europea postconciliare, i quali non erano sconosciuti ai teologi e alle teologhe dell’America Latina che accompagnarono il proceso.
Di certo, il risultato non è stato una copia, bensì ha presentato novità sostanziali, fondamentalmente a causa della differenza tra il contesto socioeconomico e socioculturale latinoamericano e quello europeo, per il diverso “luogo sociale” all’interno della società mondiale a cui guardava ciascuna delle due teologie. Di fatto Rockefeller reagì con furia contro Medellín e contro la TdL, non contro altre teologie. Nell’ottica dell’America Latina, ci sembra di vedere che questo popolo simultaneamente “oppresso e credente” – nella consapevolezza della dialettica oppressione/liberazione e dell’opzione per i poveri – sia la differenza specifica alla base del marchio di fabbrica della TdL, del salto qualitativo che questa ha potuto compiere, senza disconoscere né sottovalutare per questo l’aiuto inestimabile che ha significato la teologia progressista europea.
In ogni caso, la TdL latinoamericana può essere considerata a ragione come un contributo di questa Chiesa cristiana continentale all’intera Chiesa universale, trovandosi in effetti presente oggi in tutti i continenti.
Non si è trattato di un’esclusiva cattolica, dal momento che lo stesso processo è stato vissuto nello stesso periodo dalle Chiese protestanti, nella Conferenza di Uppsala, nel “Movimento Chiesa e Società” del Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra… Le innumerevoli realizzazioni accademiche e pastorali “ecumeniche”, tra cattolici e protestanti, in materia di TdL non sono mai cessate fin dai primi momenti della sua apparizione. Anzi, senza che nessuno abbia voluto “esportarla”, la incontriamo anche in altre religioni, come l’islam, l’ebraismo, l’induismo, il buddhismo…
Pur essendo la teologia latinoamericana per antonomasia, è chiaro anche che non è solamente latinoamericana, bensì presenta anche altre radici – tra cui quelle europee –, e soprattutto molti rami, carichi di frutto, che si sono innestati nei luoghi più diversi, in tutti i continenti.
2. TdL: senza trionfalismo
Per dire la verità, neppure negli anni ’70 e ’80 la TdL è arrivata a occupare egemonicamente il continente latinoamericano. Ha, sì, assunto un chiaro protagonismo, grazie alla pubblicità dei mezzi di comunicazione che ne hanno fatto una novità giornalistica, ma neanche allora è stata una teologia maggioritaria tra il popolo di Dio latinoamericano. E ancor meno lo è stata istituzionalmente. Però, questo sì, ha portato, quasi da sola, la palma del martirio: era dai primi tempi della Chiesa che non assistevamo a una «così grande nube di testimoni», il martirologio latinoamericano, la prova di credibilità massima della spiritualità della liberazione (l’atto primo della TdL).
Negli anni ’70 e ’80 si pensava che la CLAR (Conferenza Latinoamericana dei Religiosi e delle Religiose) fosse totalmente egemonizzata dalla TdL; in realtà, analisi più dettagliate hanno rivelato come solo un quarto dei religiosi/e aderisse – profondamente, questo sì – alla TdL: la grande maggioranza si limitava semplicemente a seguire le persone che erano convinte oppure si opponeva loro. E lo stesso potremmo dire del grosso delle diocesi della Chiesa cattolica e delle denominazioni e congregazioni della Chiesa protestante. La realtà della TdL è stata spesso significativa, e in sé molto valida, ma non ha mai raggiunto una presenza di massa e ancor meno totalizzante. I nemici politici e gli avversari ecclesiastici istituzionali non sono mancati e questo ha reso particolarmente duri alcuni decenni dell’inverno ecclesiale che abbiamo attraversato. Tutto ciò spazza via ogni trionfalismo nel parlare della TdL: lo stesso atteggiamento con cui ascoltiamo i resoconti e le cronache della presenza e della ricezione della TdL in Europa. È il cammino del Vangelo: sempre privo di trionfalismo.
3. TdL: con umiltà
La TdL è stata frequentemente celebrata come un ritorno al cristianesimo del Vangelo, alla Chiesa primitiva, quella dei poveri, slegata da ogni alleanza con l’Impero. Ma se tali riconoscimenti sono veri, devono anche essere accolti con umiltà, perché non si possono chiudere gli occhi di fronte alla sua impotenza rispetto alla realtà di peccato del nostro continente.
L’America Latina, il continente famoso per la TdL, è altrettanto tristemente famoso per essere il continente economicamente più diseguale del mondo. Il Brasile, il Paese che è giunto ad avere – si diceva – più di 80mila Comunità Ecclesiali di Base – è il Paese che registra la maggiore concentrazione di reddito, e in cui l’1% della popolazione possiede il 28% della ricchezza del Paese, secondo i dati del 2015, anche dopo il livellamento in termini di equità che ha significato il governo di Lula, con più di 40 milioni di poveri che hanno fatto ingresso nella classe media. La TdL latinoamericana deve parlare con umiltà, perché i postulati teorici su cui si basa sono assai lungi da una traduzione effettiva in risultati socio-economici giusti e in efficaci e concrete strutture politiche. E ciò malgrado questa contraddizione tra religione cristiana e ingiustizia sociale non appartenga solo al continente latinoamericano, ma a tutto il complesso socio-culturale occidentale, essendo purtroppo l’Occidente la culla e il supporto del capitalismo mondiale, noto in tutto il mondo come massimo responsabile della disuguaglianza, dello sfruttamento dei popoli e del colonialismo. La TdL, tanto in America Latina quanto in Europa o in qualunque altra parte del mondo, deve essere umile perché non può vantare il merito di aver realizzato storicamente molte trasformazioni socio-economico- politiche, benché possa, al tempo stesso, essere umilmente orgogliosa di stare dalla parte giusta della necessaria trasformazione del mondo, dallo stesso lato in cui si schierò Gesù di Nazaret, che pure lui fallì.
Specialmente dinanzi all’Europa, la TdL non può essere arrogante né pretendere di dare lezioni a priori, poiché di fatto l’Europa, pur essendo una delle regioni che producono più diseguaglianza a livello mondiale, e pur trovandosi attualmente in un processo di inequità crescente, è ancora la regione del mondo a cui le statistiche attribuiscono la minore disuguaglianza sociale. Malgrado tale indice non sia l’unico importante in una realtà così complessa come quella della politica socioeconomica, vi sono analisti che indicano l’Europa come esempio da seguire per altri continenti nella lotta alla disuguaglianza nel mondo, per quanto riguarda l’introduzione di un regime di tassazione progressiva e l’aumento delle imposte sull’eredità, oltre a un maggior rigore nel controllo dell’evasione fiscale. L’equità sociale, come elemento del Regno di Dio predicato da Gesù, utopia della TdL, pare non essersi ancora rivelata possibile in modo stabile, duraturo e integrale in nessun regime politico ispirato dalla TdL o sulla linea della TdL. Non abbiamo alcuna realtà politica di cui inorgoglirci.
È all’interno di questo atteggiamento di umiltà che va accolta la presenza della TdL in Europa (…), come una presenza in ogni caso assai positiva, che si sforza di rinnovare tanto la Chiesa quanto, soprattutto, la Società, come è compito della TdL, che è sempre stata una teologia “in uscita”, verso l’altro mondo possibile, verso l’Utopia di Gesù.
4. La TdL non è l’“ultima” parola
Nei primi decenni della sua apparizione in America Latina è sembrato ad alcuni che la TdL e la spiritualità della liberazione fossero “l’ultima” parola e continuassero a esserlo quasi per sempre… Il mondo ha registrato una svolta socio-economico-ideologica importante nel 1989, e a partire da allora è sopraggiunto un forte calo dell’ammirazione che la TdL riceveva all’estero. La prima critica che allora le venne mossa è che non evolveva, che ripeteva – magari approfondendoli – i temi fondamentali, senza presentare novità.
Vi fu una prima reazione della TdL a questa presa di distanza da parte di quelli che fino ad allora erano stati i suoi ammiratori, quella rappresentata dalla sorpresa della diversificazione dei suoi soggetti, i “nuovi soggetti emergenti”, come si disse: le donne con la loro teologia femminista, gli indigeni con la loro teologia india, gli afroamericani con la loro teologia nera… Fu una sorta di sdoppiamento, una diversificazione, non una divisione ma un arricchimento in termini di profondità, cosicché, per quanto si possa parlare oggi di teologie della liberazione, al plurale, ha anche senso mantenere il singolare, per la forte e sostanziale unità che unisce tutte loro.
Anche così, tale sdoppiamento non era una novità rispetto alla TdL, ma solo un approfondimento. Presto tornò a ripetersi la critica contro di essa: non evolve, è rimasta nel mondo degli anni ’80-’90, non accoglie né dà risposta alle nuove e profonde questioni epistemologiche, ai “nuovi paradigmi” che stanno apparendo da alcuni decenni, sebbene alcuni vengano da molto lontano, dai secoli passati. Per fare solo un esempio: la TdL classica, fin dalla sua origine, essendo una “derivazione” di un’applicazione del Concilio Vaticano II, non poteva non essere inclusivista e cristocentrica. In quegli anni, dopo il superamento recente del millenario esclusivismo tipico del cristianesimo, non esisteva un’altra prospettiva a cui richiamarsi: il paradigma pluralista neppure si intravedeva all’orizzonte. Tuttavia, verso la fine degli anni ‘80 apparve la teologia del pluralismo religioso, e con essa il paradigma pluralista, che presto iniziò a occupare spazi nella teologia. In non pochi settori ecclesiali, la TdL classica fu presa dallo sconcerto, senza sapere cosa fare; molti confusero la fedeltà alla TdL con la chiusura al nuovo, e con il timore a mescolarsi, a confrontarsi e a riconvertirsi. Ma vi furono anche autori e autrici legati alla TdL che accettarono la sfida di confrontarsi con questo nuovo paradigma: nella raccolta Per i molti cammini di Dio (tiempoaxial.org/Por-LosMuchosCaminos), della EATWOT (cinque volumi in senso progressivo, con oltre 70 autori/autrici) si presenta una Tdl impegnata a confrontarsi con il pluralismo, non più necessariamente inclusivista.
E insieme al paradigma pluralista sono presenti oggi sullo scenario vari altri “nuovi paradigmi”, i quali im pongono sempre più chiaramente la loro presenza, suscitando la resistenza di quanti preferiscono non affrontare cambiamenti drastici (i cambiamenti di paradigma sono, per definizione, i più radicali), e restare fedeli alla TdL “di sempre”, quella “originale”, quella degli anni ’80, come se fosse l’“ultima parola”. Insieme a quello pluralista, esistono il paradigma femminista, quello post-teista, quello non dualista, quello ecocentrico, il nuovo paradigma archeologico biblico, il nuovo paradigma epistemologico…
Le pagine di questa rivista testimoniano che, sebbene sia l’America Latina il luogo in cui è più noto e più assunto come proprio questo confronto della TdL con i nuovi paradigmi, anche in Europa vi sono Paesi entrati – a partire dalle Comunità di Base più che dai cattolici accademici – in questo processo di sviluppo di una TdL che non costituisce più “l’ultima parola”, bensì che dialoga con le nuove sfide teoriche generate dal rinominato nuovo “tempo assiale” (tiempoaxial.org) per cui stiamo transitando. Forse è questa l’ora di intraprendere una collaborazione tra Europa e America Latina in relazione a questo nuovo “sviluppo della TdL” a metà del XXI secolo.
5. L’America Latina dinanzi al kairos europeo
È già da alcuni anni che in America Latina alcuni di noi stanno dicendo che, dopo vari decenni in cui l’Europa ha guardato alla TdL e alle Comunità di base come un kairos, un segno dei tempi che ha illuminato e sostenuto tante lotte europee, il vento sta ora soffiando in un’altra direzione.
Questo è (anche) il momento che l’America Latina guardi attentamente all’Europa, perché il processo di secolarizzazione che lì si è registrato è anch’esso un kairos in cui lo Spirito parla al nostro continente. Senza rendercene conto, dopo l’ammirazione che la TdL ha suscitato in questi decenni, ci resta inconsciamente l’idea che non vi siano nuovi segni dei tempi al di fuori dell’America Latina (perché la TdL continuerebbe a essere l’ultima parola…), ma non è così.
L’attuale laicizzazione dell’Europa è di tale portata da far già considerare la “post-religionalità” come un nuovo paradigma in grado di iniziare a coprire l’intero territorio continentale: la religione rimarrebbe confinata solo nelle fasce più anziane, chiamate a scomparire. La “trasmissione della fede” è praticamente scomparsa dall’ambiente culturale dei giovani in Europa. Che ne sarà del cristianesimo europeo fra 30 anni?
Per noi, in America Latina, questa domanda è molto seria, perché, sebbene non pochi lo dubitino, siamo in molti a ritenere che, in quanto anche noi appartenenti all’Occidente, il fenomeno della laicizzazione non solo arriverà anche qui, ma sta già avvenendo, e più rapidamente di quanto possa sembrare. Le statistiche, in quasi tutti i Paesi, confermano questo dato con una nettezza impietosa.
In questa trama di ciò che potremo chiamare come l’apparizione della post-religionalità, vorremmo trovare in Europa un orientamento affinché quello che da lì si sta avvicinando a noi possa avvenire qui in un altro modo. È in questo senso che pensiamo che oggi sia l’America Latina a dover guardare all’Europa, per scrutare il nuovo cammino che potremmo far derivare dalla sua evoluzione religiosa attuale.
Così, la relazione tra la TdL latinoamericana e l’Europa, lungi dall’essere univoca, è invece una relazione bidirezionale, reciproca, fraterno-sororale.
* Cappella Maggiore del Seminario dell’Arcidiocesi di Medellin (Colombia) in una foto di John Nicolas del 2011, tratta da Wikimedia Commons