teologia senza paraocchi
di Elodie Maurot
in “La Croix” del 21 settembre 2017
Nel suo libro “Urgences pastorales”(Bayard), Christoph Theobald propone una riflessione serena e costruttiva sul cristianesimo nel XXI secolo, che prende atto della novità radicale dei tempi.
Imprescindibile. Tale dovrebbe diventare nelle prossime settimane, mesi e perfino anni, la riflessione teologica fatta dal gesuita francese Christoph Theobald in Urgences Pastorales. Imprescindibile per tutti coloro che cercano di vivere e proporre il Vangelo oggi, in Europa, indipendentemente da quelli che possono essere i loro atteggiamenti, le loro etichette o perfino i loro sentimenti: identitari o progressisti, volontaristici, pessimisti e magari anche depressi… Ormai si potrà contare su questa impressionante “scommessa” teologica, che rilancia e nuovamente vivifica la riflessione sul futuro del cristianesimo. Con grande libertà spirituale, l’autore cerca di discernere quale potrebbe essere il suo nuovo volto.
L’opera si presenta come un’ampia sintesi, organizzata in tre parti: una diagnosi sociologica e culturale che affronta con determinazione la “crisi di credibilità” che il cristianesimo sta attraversando nelle nostre società; una riflessione teologica che torna alla sorgente cristiana e rivisita i temi centrali della fede e della missione alla sequela di Cristo e dei suoi apostoli; la proposta infine di una “pedagogia della riforma” che comporta la “conversione necessaria” della Chiesa.
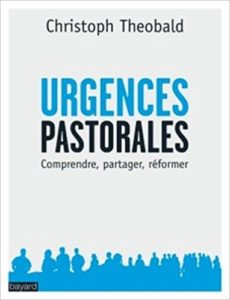
Sulla crisi delle Chiese in Europa, molto è stato detto in questi ultimi anni. Al loro interno, restano vive le differenze sul modo di porsi in una società secolarizzata. “Se, alla superficie della carta climatica del cattolicesimo francese ed europeo sembrano dominare la preoccupazione depressiva degli uni e la combattività identitaria degli altri, ci si può chiedere in che modo potrebbero muoversi le linee”, riconosce Christoph Theobald. La situazione esige tuttavia di rimescolare le carte, perché i tempi sono gravidi di sfide. Da un lato, una Chiesa che fatica a rendere credibile la sua visione globale dell’esistenza in una società divenuta plurale e frammentata. Una Chiesa di inquadramento e di territorio, erede della civiltà parrocchiale, che si sfianca nel tentare di mantenere l’offerta pastorale attuale malgrado la riduzione delle proprie forze. Una Chiesa infine composta di cristiani che in fondo non sanno più molto bene come atteggiarsi nei confronti di coloro che non credono più o che credono in modo diverso. Dall’altro lato, sottolinea Christoph Theobald, la nostra società post-moderna è caratterizzata da una crisi di fiducia e da una crisi del vivere-insieme, dal fascino per le tecnoscienze e le bioscienze, dai timori per i cambiamenti climatici e dal dominio di un sistema economico fondato sulla speculazione. In fondo, “è il rapporto con la morte che rappresenta oggi il problema maggiore delle nostre società”, fa notare. La paura della morte alimenta un fascino per il suo superamento attraverso le tecniche, cosa che potrebbe segnare la fine dell’umanesimo europeo… Poiché la Chiesa e la società sembrano allontanarsi sempre di più per effetto di una invisibile tettonica delle placche, Christoph Theobald ha scavato in profondità per trovare il punto in cui cristiani e non cristiani possono incontrarsi. Lo identifica in una “fede elementare, connessa con la bontà di fondo della vita”, il cui sviluppo è necessario alla prosecuzione dell’esistenza di ciascuno, ma la cui nascita non è mai garantita di fronte alle prove. Attorno a questo punto focale, il teologo ricostruisce la missione della Chiesa, tema che aveva proprio bisogno di essere rispolverato e che da tempo non era affrontato con altrettanta forza. Per i cristiani, la missione consiste nel porsi, “con gratuità” e “senza spirito di conquista”, a servizio della vita degli altri, mettendo a disposizione di “chiunque” le risorse di fiducia e di speranza del Vangelo. Invita ad esempio i cristiani a considerare l’ospitalità e il servizio della fraternità una “mistica non sacrale”. Christoph Theobald ne è convinto, la situazione attuale è un tempo fecondo, in cui “la messe è abbondante”. Ma per percepirlo e per rispondervi, la Chiesa deve compiere una mutazione, tornare al cuore di un’esperienza cristiana segnata dal “tutto è grazia”, poi rivedere sia le sue priorità sia il suo funzionamento. In questo libro denso, che procede in maniera serrata, l’autore unisce qualità che raramente si trovano insieme: erudizione e pedagogia, fedeltà e senso critico, prudenza e audacia. Entra in problemi molto conflittuali (la differenza cristiana, la missione, la Chiesa, i sacramenti, i ministeri, il posto della dottrina…), ma con un tatto spirituale e una preoccupazione evangelica che potrebbero coinvolgere lettori di sensibilità opposte.
Una fede non incombente «Qual è quel fuoco interiore che sembra tanto mancare a noi europei? Si tratta di un tipo di “zelo”? (…) Senza dubbio, ma come evitare allora la confusione tra la fede e lo “zelotismo” religioso? Non sarebbe meglio far riferimento all’amicizia con Gesù Cristo che ci fa condividere la “conoscenza” di ciò che ha sentito lui dal Padre suo (cfr. Gv 15,15)? Ma come non trasformare questa conoscenza in un sapere incombente? Alcuni difenderebbero volentieri il nostro diritto ad essere “fieri”. (…) Sì, possiamo esserlo, ma come far emergere questa “fierezza” dentro le nostre realtà umane (…)? In breve, come evitare che lo status diasporico della Chiesa degeneri in elitismo ed essere certi che resti radicalmente aperto alla moltitudine delle situazioni umane più fragili (…)?». (p. 184)
L’intimità divina «Il bellissimo termine “intimità” (intima) rende molto concreto ciò che, in una prospettiva teologica, è svuotato dal lessico più astratto dell’ “auto-rivelazione” o dell’ “auto-comunicazione” di Dio: Gesù non ci mette soltanto di fronte a Dio come hanno fatto i profeti, quelli della Bibbia e del Corano, ecc., ci fa accedere alla Sua intimità, alla Sua interiorità abissale, poiché vi è già lui. Ecco la “differenza” cristiana! (…) È di una profondità abissale, questa intimità divina; infatti, accedendovi, noi intravediamo progressivamente il posto unico che ogni essere umano ha in essa e quale rispetto infinito lì ci è comunicato dallo Spirito di Dio per ognuno di noi». (p. 156-157)
(Ri)suscitare la fiducia «Che cosa permette di (ri)suscitare questa fiducia o questa speranza, se è proprio questa a costituire l’estremo “baluardo” dell’umano? E chi ha questa “capacità”? (…) È anche questo il “luogo” in cui una pastorale missionaria può intervenire. Non è sufficiente voler convincere dall’esterno altri, i nostri gruppi, “fidarsi”. Solo l’interesse gratuito della Chiesa per gli esseri umani nella loro singolarità inalienabile (…) può riuscire – forse – a risuscitarla». (p. 289)


