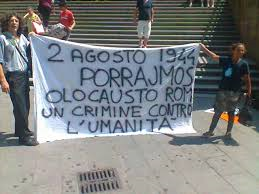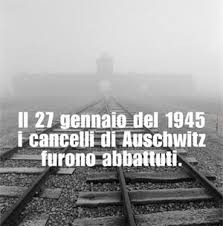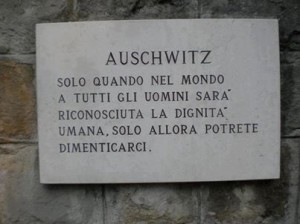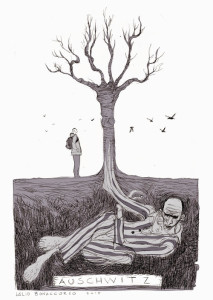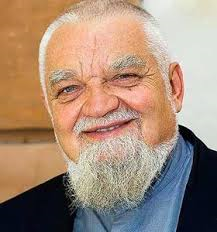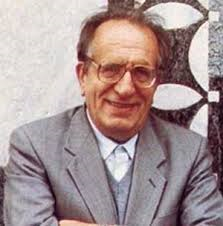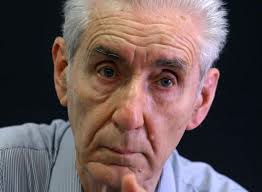Svelare le mistificazioni e le menzogne
(Abbiamo l’occasione di) affrontare questi problemi, per svelare tutte le mistificazioni, le menzogne, concretizzate e dissimulate all’interno di certi principi suggestivi. Parlando da cristiano a gente che in gran parte si ritiene tale, ci tengo a dire che il momento che stiamo vivendo è proprio il momento in cui dobbiamo abbattere (noi ne siamo i primi responsabili) quella che chiamerei l’ideologia cattolica, come ideologia di copertura del mondo borghese, il quale mondo borghese trova vantaggio nel coprire i suoi obiettivi di conservazione sociale con dei valori cosiddetti cristiani che hanno ancora una grandissima forza di suggestione nelle coscienze. La difesa della famiglia cristiana è un aspetto dell’ideologia cattolica che, molto di più di quanto potremmo pensare, nasconde la volontà di conservare un certo tipo di società e un certo tipo di sistema di rapporti di proprietà. Alzare quindi questo velo è in un sol momento recuperare la possibilità di un rapporto più vivace, più liberatorio col Vangelo e smascherare le reali intenzioni della classe dominante. (…)
Non esiste un modello cristiano di famiglia
Che cosa si nasconde, però, dietro questo cosiddetto modello cristiano della famiglia? È lecito attribuire al messaggio cristiano un modello di famiglia quale quello che abbiamo ereditato dal passato e che ancora sopravvive? Ecco, la risposta è subito no. Si tratta appunto di una menzogna, non di quelle architettate da chi sa quale mal intenzionato, ma di quelle menzogne che nascono per una specie di escrescenza storica progressiva, sulla spinta di altre ragioni che non sono di tipo ideale, ma pratico.
Non esiste la “famiglia cristiana”, essa è appunto un falso valore. Io vorrei mostrarvi come liberandoci da questa falsificazione, ricercando anche le ragioni per cui essa è nata e si è fatta valere e riferendoci con coscienza liberata alle esigenze evangeliche, noi ci mettiamo in movimento tra le forze che mirano a far crescere la nostra società e liberarla anche da altre schiavitù. Che cosa intendiamo quando si parla di modello cristiano della famiglia? Noi possiamo riferirci o al particolare ordinamento giuridico della famiglia, quello che è stato elaborato lungo i secoli dalla Chiesa cattolica, oppure ad un particolare concetto etico, morale della famiglia, che, anche indipendentemente dall’ordinamento giuridico-canonico, si è fatto valere da parte della società italiana. Per cui si dice che la famiglia tipica italiana è una famiglia di formazione cristiana.
Ora, spieghiamoci su questo punto. Intanto sta di fatto che quando noi parliamo della famiglia secondo l’ordinamento canonico, quello che per adesso rimane in prima gestione della Sacra Rota e dei Tribunali diocesani, noi non dobbiamo affatto ritenere che si tratti della traduzione giuridica di un ideale evangelico. Si tratta invece di una creazione storica, precisamente databile, di cui è responsabile la Chiesa cattolica.
I primi cattolici non avevano un ordinamento giuridico proprio della famiglia. Essi vivevano la vita di famiglia, ed anche diremmo istitutivi, secondo il costume del tempo. Non c’era, per dir così, il matrimonio in chiesa; non c’era una anagrafe o un tribunale ecclesiastico per i matrimoni, non c’era il prete, al matrimonio. I cattolici si sposavano come tutti gli altri. Non sentivano alcun bisogno di dare al loro matrimonio un ordinamento giuridico particolare all’interno del generale ordinamento giuridico della società in cui vivevano, specialmente in quella romana.
Ad esempio, là dove erano le famiglie a stabilire il matrimonio dei figli, i primi cristiani facevano come gli altri: il padre di famiglia destinava alla figlia un dato marito, d’accordo con la famiglia del promesso sposo, senza che i due interessati potessero aggiungere nulla, perché questo era il costume. Inutile quindi andare a cercare nei primi cristiani un modello di “famiglia cristiana”. Così, per quanto riguarda il modello etico della famiglia, non esiste un concetto etico specificamente cristiano, nei primi secoli. C’è una visione, se vogliamo, di fede, teologale, cioè legata al riferimento a Cristo. Non esiste però un ideale di famiglia con particolari contenuti morali. La prassi familiare si modellava sul costume morale del tempo. Anche se è chiaro che il cristianesimo impose un rigore morale, un rifiuto di certe forme di depravazione, una condanna di certe degenerazioni; però non disse cose diverse da quelle che poteva dire l’etica degli stoici o dei pitagorici. Quindi il cristianesimo non si presenta con una sua etica familiare formulata nei primi tempi.
Come nasce il modello cristiano della famiglia
Solo quando la Chiesa, dopo Costantino, e precisamente con Giustiniano, acquista una responsabilità di tipo sociale, per cui tutti i momenti della vita sociale vengono gestiti dal clero, incomincia a formarsi un ordinamento matrimoniale cristiano che, come vedremo, si è poi accresciuto, si è arricchito, si è accreditato in ogni modo fino a trovare il suo sigillo nel Concilio di Trento e a diventare anche un modello di ispirazione per molti ordinamenti giuridici civili. Il codice napoleonico fu in gran parte tributario di questa tradizione giuridica della Chiesa medioevale. Tuttavia ci domandiamo se il matrimonio cosiddetto cristiano ha veramente obbedito alle esigenze evangeliche o non piuttosto alle esigenze della società del tempo. La risposta è chiara: la cosiddetta famiglia cristiana, con tutti i connotati giuridici ritrovabili nel codice canonico, con tutti i connotati etici ritrovabili nel costume esemplare, è un prodotto storico e, come tale, relativo. Per cui io non riesco a capire, proprio dal punto di vista diremo dell’individuazione culturale, che significhi difendere in una società pluralistica un modello cristiano di famiglia, perché non so quale sia questo modello, perché non si dà un modello proprio del cristiano. La famiglia cristiana, se noi la conserviamo come prodotto storico ereditario, nasconde invece in sé particolari pregiudizi, particolari difformazioni, particolari rapporti sociali legati allo sfruttamento che sono tutti da rifiutare.
Caratteristiche superate della famiglia cristiana
Quali sono queste caratteristiche storiche da considerare superate? Innanzitutto è chiaro che l’unità della fami-glia cristiana usufruiva di un dato economico, era l’unità patrimoniale. Il padre di famiglia era l’unico responsabile del patrimonio familiare, era lui l’unica figura economica della famiglia. E quindi l’unità della famiglia, anziché essere il prodotto della scelta cosciente dei coniugi, era un portato fatale dell’indivisibile unità patrimoniale. (…)
A reggere l’indissolubilità della famiglia, oltre a questa ragione economica, esisteva un ambiente cosiddetto monoculturale, cioè a cultura unica, per cui tutti gli elementi culturali dell’ambiente spingevano a ricercare la propria identità nella famiglia di appartenenza. Una donna non aveva un suo mondo culturale. I figli non avevano un mondo culturale autonomo. Non c’era-no spazi diversi per l’esperienza di vita. La famiglia rappresentava il luogo normale e continuativo dell’esperienza culturale. L’unità quindi si manteneva perché mancavano forze centrifughe, aperture di orizzonti diversi per i componenti della famiglia. Pensate, ad esempio, al legame quasi fatale fra il lavoro del padre e del figlio. In terzo luogo c’era la subordinazione della donna all’autorità maritale, che era una norma assoluta. L’attività pastorale della Chiesa ha in questo una specifica responsabilità, perché il modello che si forniva alla donna era un modello di subordinazione al marito. La “donna cristiana” è quella che dice sempre di sì al marito, che non ha in nessun campo iniziativa propria, le cui virtù sono tutte una garanzia alla tirannide maschile e i cui compensi mistificanti sono l’essere l’angelo del focolare.
Perfino san Paolo porta riflessi della condizione sociale della donna dei suoi tempi, quando dice che la donna deve essere sottoposta al marito, o deve coprirsi il capo quando entra in assemblea perché il capo della donna è l’uomo. San Paolo non rivela niente che abbia rapporto con la liberazione portata da Gesù Cristo. Assume norme di comportamento proprie della società ebraica. Ma noi dobbiamo sapere che la fedeltà alla parola di Dio non è fedeltà ai modelli sociologici del comportamento, legati ad una certa fase dello sviluppo storico. La parola di Dio non assolutizza, non rende normativi quei modi di comportamento, ci esorta anzi a liberarcene.
E alla fine c’era il pessimismo sessuale, che svuotava la famiglia di ogni significato positivo di comunione spontanea a tutti i livelli e relegava la vita sessuale a una funzione di servizio in rapporto all’azione. Il matrimonio è per i figli. In realtà, pensate che nel passato, anche in quel passato che certi nostalgici rimpiangono, il consenso libero della donna al matrimonio era una circostanza neanche presa in considerazione. La donna aveva così radicalmente accettato il modello impostole dalla società e dalla Chiesa che aveva perfino vergogna a dire che desiderava prender marito; magari lo desiderava con tutta se stessa, ma tale desiderio rimaneva inibito. Doveva esser lei, la donna cercata. Doveva essere senza iniziative e con un’etica del comportamento femminile che voi conoscete bene. La stessa definizione della donna era di tipo biologico. La donna si definiva in rapporto alla sua biologia: era vergine o madre. Non persona, come l’uomo, capace di decidere della propria vita indipendentemente dalla condizione biologica; ma legata strettamente a questa, con delle sfere di mortificazione terribili, come la donna che non ha sposato, la zitella, considerata una donna fallita.
Oggi ci troviamo nella situazione in cui lo sviluppo della società ha messo in crisi le componenti di struttura che sorreggevano un certo tipo di famiglia cosiddetta cristiana. Abbiamo una crisi della famiglia che per molti è la crisi della famiglia cristiana, ma che invece è la crisi della famiglia tradizionale e niente altro. Allora, un credente, quali doveri ha in questo momento? Non di stringersi, di far quadrato attorno a un model-lo di famiglia che non ha più nessuna ragione storica di continuare, ma rifarsi all’esigenza evangelica, interrogarsi di fronte ai Vangelo.
Ora, secondo me, il Vangelo, non ci dà nessun esempio di famiglia precisa. Anche la sacra famiglia è un invenzione posteriore, borghese, perché la famiglia di Nazareth, non è un modello di famiglia, per il semplice fatto che, almeno nelle convinzioni di fede, Maria e Giuseppe non erano autenticamente marito e moglie. Quindi, presentare come modello di famiglia un modello in cui proprio l’aspetto principale non era integro, significa fare una mistificazione.
Indicazioni evangeliche
Occorre domandarsi piuttosto in che senso il Vangelo si apre a questa esperienza particolare della vita che è l’amore nella famiglia, nella linea della liberazione, cioè nella crescita secondo il disegno di Dio. A me pare che ci siano dei punti fermi, questa volta autenticamente fermi, a cui fare riferimento in questo tentativo di recupero del significato evangelico che può avere la vita nell’amore, la vita familiare. Innanzi tutto, è sicuramente un’affermazione di fondo del Vangelo che dinanzi a Cristo non c’è nessuna differenza fra l’uomo e la donna, dinanzi a Cristo non c’è né maschio né femmina. (…)
In secondo luogo, secondo il Vangelo, la fedeltà non è il risultato di una legge esterna che costringe, ma è un’espressione dell’amore. Un’altra esigenza interna allo spirito evangelico è il rifiuto della strumentalizzazione, del rendere l’altro uno strumento di se. Espressioni bibliche quali “la persona umana è fatta a immagine di Dio”, “amate i vostri mariti come la Chiesa ama Cristo”, “amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa”, per un credente sono un invito decisivo a rifiutare di fare dell’altra persona uno strumento di sé, si tratti dei rapporti fra coniugi, si tratti di rapporti familiari.
Questo rispetto della persona significa garanzia del rapporto veramente comunitario, perché tra rapporto comunitario e rapporto di società stabilito dalla legge c’è una differenza di qualità: il rapporto comunitario in tanto è, in tanto vive, in quanto trova la sua sorgente nel libero consenso e nel rispetto spontaneo della coscienza verso l’altro; i rapporti societari invece sono quelli che si stabiliscono per forza di legge.
La famiglia, istituzione legata alle condizioni storiche
Siamo all’ultimo punto: non dobbiamo cadere in un così ingenuo evangelismo da credere che la famiglia non interessi la società, che debba essere riferita soltanto all’esperienza spirituale. Ogni espressione dell’uomo, ma la famiglia in particolar modo, in quanto si innesta nei rapporti sociali genera-li, ha bisogno di istituzionalizzarsi. La istituzionalizzazione è un momento di serietà umana, il momento in cui si traduce in norma esterna la responsabilità di fronte alla società intera.
Però, non è con questo momento istituzionale che si definisce la famiglia. Il momento istituzionale è quello in cui l’esperienza della famiglia assume rapporti e responsabilità con l’insieme della realtà sociale. E la società, come tale, ha bisogno di tutelare la famiglia, di farsene garante in qualche modo, di proteggerne e favorirne lo sviluppo. Ma questo momento, lo ripeto, è del tutto legato alle condizioni storiche e varia a seconda del mutare delle condizioni storiche; perciò oggi c’è bisogno di una nuova istituzionalizzazione della famiglia.
La famiglia è una creazione continua. Nella Bibbia c’è la poligamia, poi si è acquisito il concetto della famiglia monogamica, che forse è un concetto irrinunciabile. Però non si deve dire che è la natura che l’ha voluto, perché questo significa attribuire alla natura astratta delle conquiste storiche che sono invece relative anch’esse. Forse la famiglia dovrà cambiare ancora forma, dovrà cambiare struttura. Il concetto del diritto naturale è un concetto dell’immobilismo borghese, con cui si sono voluti rendere eterni e immutabili alcuni rapporti che erano funzionali alla società borghese. E qual è il criterio con cui la famiglia deve cambiare struttura? È quel di più di libertà che l’uomo deve avere. Quando diciamo libertà non parliamo della libertà soggettivistica identica al libero arbitrio, ma di una libertà in cui veramente l’esistenza dell’uno sia garanzia e condizione della libertà di tutti gli altri.
Questa crescita della famiglia presuppone un nuovo diritto familiare in cui dovrà essere anche previsto il caso nel quale la fedeltà reciproca di indissolubilità non è più possibile. Cioè la clausola del divorzio come verifica di un fallimento dell’esperienza e come legittima dei due, che hanno portato a termine un esperienza fallita, di crearsi una esistenza coniugale. Questo la legge lo può fare; a rigore, lo deve fare. Però il diritto di famiglia non è questo. Ecco perché dovremo, una volta superata la battaglia sul referendum, considerarci continuamente mobilitati per favorire in Italia una modificazione profonda del diritto di famiglia, perché esistono già ormai le condizioni di coscienza generali e perché certe norme giuridiche della tradizione siano abolite e superate.
E naturalmente, quando si fa questa battaglia per un nuovo tipo di famiglia, si deve fare anche una battaglia per un nuovo tipo di società, perché se i rapporti economici rimangono quelli che sono poco vale il modificare i rapporti giuridici. Al più avremmo un aggiornamento neo-capitalistico della famiglia. In ogni caso, una battaglia per la famiglia che si apre con il referendum, non si chiude con il referendum. Però dobbiamo dirci che noi, in quanto cristiani, non abbiamo niente, nessun modello nostro da difendere. Noi dobbiamo ricercare con gli altri un modello giuridico ed etico di famiglia, perché non abbiamo privilegi di nessuna sorta come credenti. Come credenti ci compete l’onere e il privilegio, se volete, di essere fedeli alle ispirazioni evangeliche fonda-mentali; ma queste ispirazioni non sono da tradurre come modello etico-giuridico, poiché sono una spinta continuamente trasformante della realtà storica, disponibili a sempre nuove forme di ordinamento familiare.
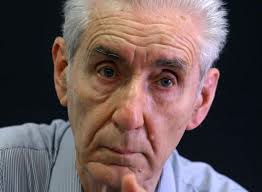
“La discussione sulle unioni civili avrebbe bisogno di limpidezza e di rispetto reciproco, invece d’essere posseduta da convenienze politiche, forzature ideologiche, intolleranze religiose”