“la buona politica è al servizio della pace”
il manifesto antisovranista di papa Francesco
messaggio sulla buona politica “al servizio della pace“

corruzione e xenofobia “vergogne della politica”
contro chi addossa ai migranti l’origine di tutti i mali
Maria Antonietta Calabrò
Un messaggio breve, quattro cartelle. Ma molto dense. In 7 punti. Con un titolo che dice già tutto: “La buona politica è al servizio della pace”.
Il tradizionale discorso del Papa per la Giornata del 1 gennaio – ricorrenza istituita da Paolo VI e celebrata per la prima volta nel 1968 – cala nel concreto della vita dei popoli e delle nazioni, perché parla di politica, di politici e di scelte politiche. Con un occhio anche alle prossime scadenze elettorali, che per gli europei saranno quelle del prossimo maggio, con il rinnovo dell’Europarlamento di Strasburgo. Quasi un “Manifesto antisovranista”, un documento “antidivisivo”, che fa appello alla speranza del bene comune e all’immagine della “casa” e che nel libretto preparato dalla Libreria Editrice Vaticana è illustrato dalla figura della Giustizia, con in mano una spada e una bilancia.
Il messaggio costituirà certamente uno strumento di riflessione anche per i laici cattolici italiani, chiamati di recente dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, a uscire dall’irrilevanza pubblica in cui sono precipitati. “Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica – si legge nel Messaggio di Francesco – costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza”.
Ma della politica Francesco esamina, nel punto 4, anche i “vizi”: dalla corruzione alla xenofobia. “Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale, sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della ragion di Stato, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio”.
Al punto 5 Bergoglio aggiunge: “In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”. E ancora, il Papa stigmatizza chi addossa ai più vulnerabili, ai migranti l’origine di tutti i mali.
Qualcuno griderà all’ingerenza politica di Francesco. Ma il Papa è molto attento a richiamare il magistero dei suoi predecessori: Giovanni XXIII, Paolo VI e Benedetto XVI (a cui è dedicato l’intero capitolo 3), insieme alle parole del cardinale vietnamita Nguyen Van Thuan che trascorse ben 13 anni in prigione nel suo Paese, di cui 9 in isolamento, e fu definito da Giovanni Paolo II testimone eroico della sua fede, di cui Francesco enuncia nel suo Messaggio le otto “Beatitudini del politico”.
Nessuno insomma potrà etichettare il documento per la giornata della Pace come “comunista”, o divisivo.
“Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo” spiega il Papa.” Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa!. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi” (Lc 10,5-6). Ed è questo l’augurio di Francesco all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. “E questa offerta – continua – è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù – continua – è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine”.
La sfida della buona politica
La pace, secondo Francesco, è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.
“Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti” (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo VI: “Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità”.
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità.
Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava – continua il Messaggio – che “ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla Terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana”. È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro
Il Messaggio continua con uno sguardo rivolto ai giovani, al futuro. “Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle capacità di ogni persona. “Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo”.
Per Papa Francesco, ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. “La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali”.
No alla guerra e alla strategia della paura
A cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, “mentre ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate. Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità”.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
LII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2019
La buona politica è al servizio della pace
1. “Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana.[1] La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.
2. La sfida della buona politica
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy;[2] è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità».[3]
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità.
3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana».[4] È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.[5]
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.
4. I vizi della politica
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio.
5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo».[6]
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono complesse. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.
6. No alla guerra e alla strategia della paura
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate.
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità.
7. Un grande progetto di pace
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli».[7]
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
– la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
– la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
– la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire.
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55).
Dal Vaticano, 8 dicembre 2018
Francesco
[1] Cfr Lc 2,14: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».
[2] Cfr Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986.
[3] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 46.
[4] Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7.
[5] Cfr Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di Padova: “30giorni”, n. 5 del 2002.
[6] Benedetto XVI, Discorso alle Autorità del Benin, Cotonou, 19 novembre 2011.
[7] Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), 24.





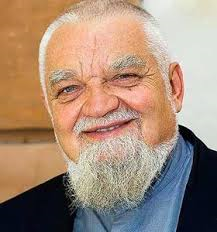
 È significativo allora che Francesco esordisca facendo riferimento a due fenomeni mondiali quali le migrazioni e il martirio di molti cristiani. Due tragedie sulle quali Francesco non perde occasione per ritornare, cercando per ciò che riguarda i migranti, di destare le coscienze di tutti gli uomini e le donne di buona volontà – in primis di quanti hanno responsabilità pubbliche – per una gestione umana, prima ancora che umanitaria, di una piaga che da tempo non può più essere considerata “emergenza”. L’afflizione del martirio nelle parole del papa non è mai motivo per appelli a resistenze violente o a leggi del contrappasso e della reciprocità nell’infliggere il male, ma sempre occasione per gridare con voce ferma e a nome dei senza voce il caro prezzo che si paga per «vivere liberamente la fede cristiana» e per «non negare Cristo». A questo punto papa Francesco ritorna su due delle piaghe più laceranti che affliggono oggi la chiesa: gli abusi sui minori e l’infedeltà nel ministero. Verso coloro che si sono macchiati di gravi abusi «sessuali, di potere e di coscienza; tre abusi distinti che però convergono e si sovrappongono», papa Francesco arriva a usare parole di una durezza finora riservata solo ai colpevoli di crimini di mafia: «Convertitevi, consegnatevi alla giustizia umana e preparatevi alla giustizia divina!». Poco importa che in altre istituzioni si compiano di questi abusi in quantità ben maggiore: secondo la logica del Vangelo applicata da papa Francesco, le statistiche non offrono nessuna attenuante né giustificazione, perché lo scandalo patito anche da «uno solo di questi piccoli» porta in sé tutto il male del mondo. L’afflizione dell’infedeltà, poi, è inferta al corpo della chiesa da chi tradisce in profondità la propria vocazione giungendo con parole e opere a «pugnalare i fratelli e seminare zizzania, divisione e sconcerto». Anche qui però le tenebre della «corruzione spirituale» non giungono mai a sopraffare la luce di Cristo, «la luce del Natale che parte dalla mangiatoia di Betlemme, percorre la storia e arriva fino alla parusia ». Sì, parole dure e forti, scomode, laceranti come spade a doppio taglio ma parole di speranza perché dal mistero del Natale, del «Dio che si fa povero e piccolo per i poveri e per i piccoli» si sprigiona lo Spirito che anima tanti piccoli, oscuri testimoni della speranza e che trasforma «i peccati in occasione di perdono, le cadute in occasioni di rinnovamento, il male in occasione di purificazione e vittoria».
È significativo allora che Francesco esordisca facendo riferimento a due fenomeni mondiali quali le migrazioni e il martirio di molti cristiani. Due tragedie sulle quali Francesco non perde occasione per ritornare, cercando per ciò che riguarda i migranti, di destare le coscienze di tutti gli uomini e le donne di buona volontà – in primis di quanti hanno responsabilità pubbliche – per una gestione umana, prima ancora che umanitaria, di una piaga che da tempo non può più essere considerata “emergenza”. L’afflizione del martirio nelle parole del papa non è mai motivo per appelli a resistenze violente o a leggi del contrappasso e della reciprocità nell’infliggere il male, ma sempre occasione per gridare con voce ferma e a nome dei senza voce il caro prezzo che si paga per «vivere liberamente la fede cristiana» e per «non negare Cristo». A questo punto papa Francesco ritorna su due delle piaghe più laceranti che affliggono oggi la chiesa: gli abusi sui minori e l’infedeltà nel ministero. Verso coloro che si sono macchiati di gravi abusi «sessuali, di potere e di coscienza; tre abusi distinti che però convergono e si sovrappongono», papa Francesco arriva a usare parole di una durezza finora riservata solo ai colpevoli di crimini di mafia: «Convertitevi, consegnatevi alla giustizia umana e preparatevi alla giustizia divina!». Poco importa che in altre istituzioni si compiano di questi abusi in quantità ben maggiore: secondo la logica del Vangelo applicata da papa Francesco, le statistiche non offrono nessuna attenuante né giustificazione, perché lo scandalo patito anche da «uno solo di questi piccoli» porta in sé tutto il male del mondo. L’afflizione dell’infedeltà, poi, è inferta al corpo della chiesa da chi tradisce in profondità la propria vocazione giungendo con parole e opere a «pugnalare i fratelli e seminare zizzania, divisione e sconcerto». Anche qui però le tenebre della «corruzione spirituale» non giungono mai a sopraffare la luce di Cristo, «la luce del Natale che parte dalla mangiatoia di Betlemme, percorre la storia e arriva fino alla parusia ». Sì, parole dure e forti, scomode, laceranti come spade a doppio taglio ma parole di speranza perché dal mistero del Natale, del «Dio che si fa povero e piccolo per i poveri e per i piccoli» si sprigiona lo Spirito che anima tanti piccoli, oscuri testimoni della speranza e che trasforma «i peccati in occasione di perdono, le cadute in occasioni di rinnovamento, il male in occasione di purificazione e vittoria».








