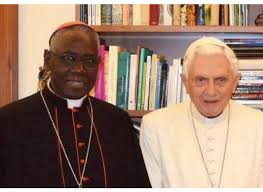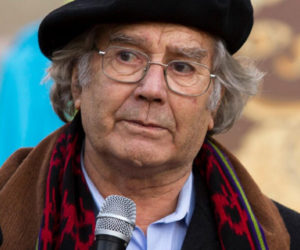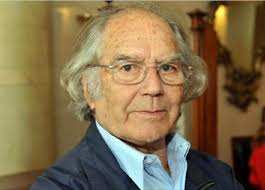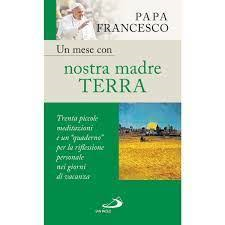il calvario dei detenuti
è la Via Crucis secondo Bergoglio
di Luca Kocci
«il carcere continua a seppellire uomini vivi»
ma
«tutti, anche da condannati, siamo figli della stessa umanità»

Sono due frasi lette ieri sera, durante la Via Crucis del venerdì santo presieduta da papa Francesco a San Pietro. Si parla di persone detenute e di carcere, perché quest’anno le meditazioni per le quattordici stazioni della Via Crucis – rito cattolico che ripercorre gli ultimi momenti della vita di Gesù raccontata dai Vangeli, dalla condanna a morte alla sepoltura dopo la crocefissione – sono state affidate a detenuti e loro famigliari, volontari e personale della Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova, in cui sono recluse circa seicento persone: cinque detenuti, la figlia di un ergastolano, la madre di un carcerato, un’educatrice, una catechista e un frate volontari in carcere, un magistrato di sorveglianza, un agente di polizia penitenziaria, i genitori di una ragazza uccisa e anche un prete accusato di pedofilia e poi assolto.
Quello del carcere e delle condizioni di vita dei detenuti, del resto, è un tema più volte affrontato da Francesco durante il pontificato: dalla messa del giovedì santo con la lavanda dei piedi a dodici giovani detenuti nel carcere minorile romano di Casal del Marmo il 28 marzo 2013, due settimane dopo l’elezione al soglio pontificio; a diversi interventi pubblici, l’ultimo durante la messa mattutina a Santa Marta, pochi giorni fa, nel quale ha denunciato «il problema del sovraffollamento nelle carceri», soprattutto in questi tempi di pandemia, con il rischio «che finisca in una calamità grave».
LO SCENARIO della Via Crucis di ieri sera è quello già visto la scorsa settimana, durante la preghiera solitaria del papa: non la tradizione scenografia del Colosseo piena di fedeli stipati dietro le transenne di via dei Fori imperiali; ma piazza San Pietro illuminata dalle fiaccole e vuota, tranne le dieci persone (cinque del “Due Palazzi” e cinque della Direzione sanità e igiene del Vaticano) che si avvicendano a portare la croce; e il pontefice che presiede il rito, il cui punto forte è costituito proprio dalle meditazioni dei detenuti e dalle preghiere che le accompagnano. A cominciare dalla prima, in cui – ed è già accaduto altre volte – è implicitamente ribadito il no all’ergastolo, giudicato una pena di morte differita. La meditazione è di un ergastolano, in carcere da 29 anni, che ha scontato anche diversi anni al 41-bis per reati di mafia, insieme al padre, morto in carcere. «Tante volte, nei tribunali e nei giornali, rimbomba quel “Crocifiggilo, crocifiggilo!”» gridato dalla folla a Pilato, ma «io somiglio più a Barabba che a Cristo», scrive il detenuto. «In quella non-vita ho sempre cercato qualcosa che fosse vita». Segue una preghiera: per «coloro che sono condannati a morte e per quanti ancora vogliono sostituirsi al tuo supremo giudizio».
TOCCA AD UN ALTRO detenuto, alla quinta stazione: «Sono entrato in carcere» e «da allora sono diventato un randagio per la città: ho perso il mio nome, mi chiamano con quello del reato di cui la giustizia mi accusa, non sono più io il padrone della mia vita. Sto invecchiando in carcere: sogno di tornare un giorno a fidarmi dell’uomo». «Vedo entrare in carcere l’uomo privato di tutto», risuona la meditazione per la decima stazione di un’educatrice del “Due Palazzi. «Viene spogliato di ogni dignità a causa delle colpe commesse, di ogni rispetto nei confronti di sé e degli altri. Ogni giorno mi accorgo che la sua autonomia viene meno dietro le sbarre: ha bisogno di me anche per scrivere una lettera. Sono queste le creature sospese che mi vengono affidate».
«PASSANDO DA UNA CELLA all’altra vedo la morte che vi abita dentro. Il carcere continua a
seppellire uomini vivi: sono storie che non vuole più nessuno», scrive un frate volontario in carcere. E nella meditazione di un magistrato di sorveglianza risuona un’autocritica, personale ma soprattutto del sistema: «Una vera giustizia è possibile solo attraverso la misericordia che non inchioda per sempre l’uomo in croce». Altri dubbi su quel «fine pena mai» pronunciato in tante aule giudiziarie.
Prosegue la meditazione del magistrato: «È necessario imparare a riconoscere la persona nascosta dietro la colpa commessa. Così facendo, a volte si riesce a intravedere un orizzonte che può infondere speranza alle persone condannate e, una volta espiata la pena, riconsegnarle alla società, invitando gli uomini a riaccoglierli dopo averli un tempo, magari, respinti. Perché tutti, anche da condannati, siamo figli della stessa umanità».
Oggi giornata di «silenzio liturgico» in Vaticano e nella Chiesa. Domani messa di Pasqua e benedizione Urbi et Orbi in una piazza San Pietro che resterà vuota.
VIA CRUCIS
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE
FRANCESCO
VENERDÌ SANTO
10 APRILE 2020
PIAZZA SAN PIETRO

MEDITAZIONI E PREGHIERE
proposte dalla cappellania
della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova
redatte da
I
una persona detenuta condannata all’ergastolo
II
due genitori ai quali hanno ammazzato una figlia
III
una persona detenuta
IV
la mamma di una persona detenuta
V
una persona detenuta
VI
una catechista della parrocchia
VII
una persona detenuta
VIII
la figlia di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo
IX
una persona detenuta
X
un’educatrice del carcere
XI
un sacerdote accusato e poi assolto
XII
un magistrato di sorveglianza
XIII
un frate volontario
XIV
un agente di Polizia Penitenziaria
Introduzione
Le meditazioni della Via Crucis quest’anno sono proposte dalla cappellania della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova. Raccogliendo l’invito di Papa Francesco, quattordici persone hanno meditato sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo rendendola attuale nelle loro esistenze. Tra loro figurano cinque persone detenute, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo, un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona detenuta, una catechista, un frate volontario, un agente di Polizia Penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente dalla giustizia dopo otto anni di processo ordinario.
Accompagnare Cristo sulla Via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle carceri, è l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la Vita e la Morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male. Contemplare il Calvario da dietro le sbarre è credere che un’intera vita si possa giocare in pochi istanti, com’è accaduto al buon ladrone. Basterà riempire quegli attimi di verità: il pentimento per la colpa commessa, la convinzione che la morte non è per sempre, la certezza che Cristo è l’innocente ingiustamente deriso. Tutto è possibile a chi crede, perché anche nel buio delle carceri risuona l’annuncio pieno di speranza: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). Se qualcuno gli stringerà la mano, l’uomo che è stato capace del crimine più orrendo potrà essere il protagonista della risurrezione più inattesa. Certi che anche quando il male e la sofferenza vengono narrati si può lasciare spazio alla redenzione, riconoscendo in mezzo al male il dinamismo del bene e dargli spazio (cfr Messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 2020).
È così che la Via Crucis diventa una Via Lucis.
I testi, raccolti dal cappellano don Marco Pozza e dalla volontaria Tatiana Mario, sono stati scritti in prima persona, ma si è scelto di non mettere il nome: chi ha partecipato a questa meditazione ha voluto prestare la sua voce a tutti coloro che, nel mondo, condividono la stessa condizione. Stasera, nel silenzio delle prigioni, la voce di uno desidera diventare la voce di tutti.
Preghiamo.
O Dio, Padre onnipotente,
che in Gesù Cristo tuo Figlio
hai assunto le piaghe e i patimenti dell’umanità,
oggi ho il coraggio di supplicarti, come il ladrone pentito: “Ricordati di me!”
Sto qui, solo davanti a Te, nel buio di questo carcere,
povero, nudo, affamato e disprezzato,
e ti chiedo di versare sulle mie ferite
l’olio del perdono e della consolazione
e il vino d’una fraternità che rinsalda il cuore.
Curami con la tua grazia e insegnami a sperare nella disperazione.
Mio Signore e mio Dio, io credo, aiutami nella mia incredulità.
Continua, Padre misericordioso, a confidare in me,
a darmi una sempre nuova opportunità,
ad abbracciarmi nel tuo infinito amore.
Con il tuo aiuto e il dono dello Spirito Santo,
anch’io sarò capace di riconoscerti
e di servirti nei miei fratelli. Amen.
I stazione
Gesù è condannato a morte
Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere (Lc 23,20-25).
Tante volte, nei tribunali e nei giornali, rimbomba quel grido: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». È un grido che ho sentito anche su di me: sono stato condannato, assieme a mio padre, alla pena dell’ergastolo. La mia crocifissione è iniziata quando ero bambino: se ci penso mi rivedo rannicchiato sul pulmino che mi portava a scuola, emarginato per la mia balbuzie, senza nessuna relazione. Ho iniziato a lavorare quando ero piccolo, senza poter studiare: l’ignoranza ha avuto la meglio sulla mia ingenuità. Il bullismo, poi, ha rubato sprazzi d’infanzia a quel bambino nato nella Calabria degli anni Settanta. Somiglio più a Barabba che a Cristo, eppure la condanna più feroce rimane quella della mia coscienza: di notte apro gli occhi e cerco disperatamente una luce che illumini la mia storia.
Quando, rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo, scoppio nel pianto: dopo ventinove anni di galera non ho ancora perduto la capacità di piangere, di vergognarmi della mia storia passata, del male compiuto. Mi sento Barabba, Pietro e Giuda in un’unica persona. Il passato è qualcosa di cui provo ribrezzo, pur sapendo che è la mia storia. Ho vissuto anni sottoposto al regime restrittivo del 41-bis e mio padre è morto ristretto nella stessa condizione. Tante volte, di notte, l’ho sentito piangere in cella. Lo faceva di nascosto ma io me ne accorgevo. Eravamo entrambi nel buio profondo. In quella non-vita, però, ho sempre cercato un qualcosa che fosse vita: è strano a dirsi, ma il carcere è stato la mia salvezza. Se per qualcuno sono ancora Barabba, non mi arrabbio: avverto, nel cuore, che quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi in carcere per educarmi alla vita.
Signore Gesù, nonostante le forti grida che ci distolgono, ti scorgiamo tra la folla di quanti urlano che devi essere crocifisso; e forse tra loro ci siamo anche noi, inconsapevoli del male di cui possiamo essere capaci. Dalle nostre celle vogliamo pregare il Padre tuo per coloro che come Te sono condannati a morte e per quanti ancora vogliono sostituirsi al tuo supremo giudizio.
Preghiamo.
O Dio, amante della vita, che nella riconciliazione ci doni sempre una nuova opportunità per gustare la tua infinita misericordia, ti supplichiamo di infondere in noi il dono della sapienza per considerare ogni uomo e ogni donna come tempio del tuo Spirito e rispettarli nella loro inviolabile dignità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
II stazione
Gesù è caricato della croce
I soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo (Mc 15,16-20).
In quell’estate orribile, la nostra vita di genitori è morta assieme a quella delle nostre due figlie. Una è stata ammazzata con l’amica del cuore dalla violenza cieca di un uomo senza pietà; l’altra, sopravvissuta per miracolo, è stata privata per sempre del suo sorriso. La nostra è stata una vita di sacrifici, fondata sul lavoro e sulla famiglia. Abbiamo insegnato ai nostri figli il rispetto per l’altro e il valore del servizio verso chi è più povero. Spesso ci chiediamo: “Perché proprio a noi questo male che ci ha travolto?”. Non troviamo pace. Neppure la giustizia, in cui abbiamo sempre creduto, è stata in grado di lenire le ferite più profonde: la nostra condanna alla sofferenza resterà fino alla fine.
Il tempo non ha alleviato il peso della croce che ci hanno messo sulle spalle: non riusciamo a dimenticare chi oggi non c’è più. Siamo anziani, sempre più indifesi, e siamo vittime del peggiore dolore che esista: sopravvivere alla morte di una figlia.
È difficile da dirsi, ma nel momento in cui la disperazione sembra prendere il sopravvento, il Signore, in modi diversi, ci viene incontro, donandoci la grazia di amarci come sposi, sorreggendoci l’uno all’altro pur con fatica. Lui ci invita a tenere aperta la porta della nostra casa al più debole, al disperato, accogliendo chi bussa anche solo per un piatto di minestra. Avere fatto della carità il nostro comandamento è per noi una forma di salvezza: non ci vogliamo arrendere al male. L’amore di Dio, infatti, è capace di rigenerare la vita perché, prima di noi, il suo Figlio Gesù ha sperimentato il dolore umano per poterne sentire la giusta compassione.
Signore Gesù, ci fa tanto male vederti percosso, deriso e spogliato, vittima innocente di una crudeltà disumana. In questa notte di dolore, ci rivolgiamo supplichevoli al Padre tuo per affidargli tutti coloro che hanno subito violenze e iniquità.
Preghiamo.
O Dio, nostra giustizia e redenzione, che ci hai donato il tuo unico Figlio glorificandolo sul trono della Croce, infondi nei nostri cuori la tua speranza per riconoscerti presente nei momenti bui della nostra vita. Consolaci in ogni afflizione e sostienici nelle prove, in attesa del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
III stazione
Gesù cade per la prima volta
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti (Is 53,4-6).
È stata la prima volta che sono caduto, ma quella caduta è stata per me la morte: ho tolto la vita ad una persona. È bastato un giorno per passare da una vita irreprensibile a compiere un gesto nel quale è racchiusa la violazione di tutti i comandamenti. Mi sento la versione moderna del ladrone che a Cristo implora: «Ricordati di me!». Più che pentito, lo immagino come uno che è consapevole di essere sulla strada errata. Della mia infanzia ricordo l’ambiente freddo e ostile nel quale sono cresciuto: bastava scovare una fragilità nell’altro per tradurla in una forma di divertimento. Cercavo amici sinceri, volevo essere accettato per com’ero, senza riuscirci. Soffrivo per la felicità degli altri, sentivo i bastoni tra le ruote, mi chiedevano solo sacrifici e regole da rispettare: mi sono sentito un estraneo per tutti e ho cercato, ad ogni costo, una mia rivalsa.
Non mi ero accorto che il male, lentamente, cresceva dentro me. Finché, una sera, è scoccata la mia ora delle tenebre: in un attimo, come una valanga, mi si sono scatenate contro le memorie di tutte le ingiustizie subite in vita. La rabbia ha assassinato la gentilezza, ho commesso un male immensamente più grande di tutti quelli che avevo ricevuto. In carcere, poi, l’ingiuria degli altri è diventata disprezzo verso me stesso: bastava poco per farla finita, ero al limite. Avevo condotto anche la mia famiglia nel burrone: per causa mia, hanno perso il loro cognome, l’onorabilità, sono divenuti soltanto la famiglia dell’assassino. Non cerco scusanti né sconti, espierò la mia pena fino all’ultimo giorno perché in carcere ho trovato gente che mi ha ridato la fiducia perduta.
Non pensare che al mondo esistesse la bontà è stata la mia prima caduta. La seconda, l’omicidio, è stata quasi una conseguenza: ero già morto dentro.
Signore Gesù, anche tu sei finito in terra. La prima volta è forse la più dura perché tutto è nuovo: il colpo è forte e lo smarrimento prevale. Affidiamo al Padre tuo coloro che si chiudono nelle proprie ragioni e non riescono a riconoscere le colpe commesse.
Preghiamo.
O Dio, che hai sollevato l’uomo dalla sua caduta, ti supplichiamo: vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci occhi per contemplare i segni del tuo amore disseminati nel nostro quotidiano. Per Cristo nostro Signore. Amen.
IV stazione
Gesù incontra la Madre
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé (Gv 19,25-27).
Nemmeno per un istante ho provato la tentazione di abbandonare mio figlio di fronte alla sua condanna. Il giorno dell’arresto tutta la nostra vita è cambiata: l’intera famiglia è entrata in prigione con lui. Ancora oggi il giudizio della gente non si placa, è una lama affilata: le dita puntate contro tutti noi appesantiscono la sofferenza che già portiamo nel cuore.
Le ferite crescono con il passare dei giorni, togliendoci persino il respiro.
Avverto la vicinanza della Madonna: mi aiuta a non farmi schiacciare dalla disperazione, a sopportare le cattiverie. Ho affidato a lei mio figlio: solamente a Maria posso confidare le mie paure, visto che lei stessa le ha provate mentre saliva il Calvario. In cuor suo sapeva che il Figlio non avrebbe avuto scampo al male dell’uomo, ma non l’ha abbandonato. Stava lì, a condividerne il dolore, facendogli compagnia con la sua presenza. Immagino che Gesù, sollevando lo sguardo, incrociasse i suoi occhi pieni d’amore e non si sentisse mai solo.
Così voglio fare anch’io.
Mi sono addossata le colpe di mio figlio, ho chiesto perdono anche per le mie responsabilità. Imploro su di me la misericordia che solo una madre riesce a provare, perché mio figlio possa tornare a vivere dopo aver espiato la sua pena. Prego di continuo per lui perché, giorno dopo giorno, possa diventare un uomo diverso, capace di amare nuovamente se stesso e gli altri.
Signore Gesù, l’incontro con tua Madre, lungo il cammino della croce, è forse il più commovente e doloroso. Tra il suo sguardo e il tuo poniamo quello di tutti i familiari e gli amici che si sentono straziati e impotenti per le sorti dei propri cari.
Preghiamo.
O Maria, madre di Dio e della Chiesa, fedele discepola del Figlio tuo, ci rivolgiamo a te, per affidare al tuo sguardo premuroso e alla custodia del tuo cuore materno, il grido dell’umanità che geme e soffre nell’attesa del giorno in cui sarà asciugata ogni lacrima dai nostri volti. Amen.
V stazione
Gesù viene aiutato dal Cireneo
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù (Lc 23,26).
Con il mio mestiere ho aiutato generazioni di bambini a camminare diritti con la schiena. Un giorno, poi, mi sono trovato a terra. È stato come se mi avessero rotto la schiena: il mio lavoro è diventato l’appiglio per una condanna infamante. Sono entrato in carcere: il carcere è entrato a casa mia. Da allora sono diventato un randagio per la città: ho perso il mio nome, mi chiamano con quello del reato di cui la giustizia mi accusa, non sono più io il padrone della mia vita. Quando ci penso, mi ritorna alla mente quel bambino con le scarpe rotte, i piedi bagnati, i vestiti usati: ero io, un tempo, quel bambino. Poi, un giorno, l’arresto: tre uomini in divisa, un rigido protocollo, il carcere che mi inghiotte vivo nel suo cemento.
La croce che mi hanno caricato sulle spalle è pesante. Con il passare del tempo ho imparato a conviverci, a guardarla in faccia, a chiamarla per nome: passiamo notti intere a farci compagnia a vicenda. Dentro le carceri Simone di Cirene lo conoscono tutti: è il secondo nome dei volontari, di chi sale questo calvario per aiutare a portare una croce; è gente che rifiuta la legge del branco mettendosi in ascolto della coscienza. Simone di Cirene, poi, è il mio compagno di cella: l’ho conosciuto nella prima notte trascorsa in carcere. Era un uomo che aveva vissuto per anni su una panchina, senza affetti né redditi. La sua unica ricchezza era una confezione di brioches. Lui, goloso di dolci, ha insistito perché la portassi a mia moglie la prima volta che è venuta a trovarmi: lei è scoppiata a piangere per quel gesto tanto inaspettato quanto premuroso.
Sto invecchiando in carcere: sogno di tornare un giorno a fidarmi dell’uomo.
Di diventare un cireneo della gioia per qualcuno.
Signore Gesù, dal momento della tua nascita fino all’incontro con uno sconosciuto che ti ha portato la croce, hai voluto aver bisogno del nostro aiuto. Anche noi, come il Cireneo, vogliamo farci prossimi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e collaborare con la misericordia del Padre ad alleviare il giogo del male che li opprime.
Preghiamo.
O Dio, difensore dei poveri e conforto degli afflitti, ristoraci con la tua presenza e aiutaci a portare ogni giorno il dolce giogo del tuo comandamento d’amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
VI stazione
Veronica asciuga il volto di Gesù
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza (Sal 27, 8-9).
Come catechista asciugo tante lacrime, lasciandole scorrere: non si possono arginare le piene di cuori straziati. Tante volte incontro uomini disperati che, nel buio della prigione, cercano un perché al male che sembra loro infinito. Queste lacrime hanno il sapore della sconfitta e della solitudine, del rimorso e della mancata comprensione. Spesso immagino Gesù in carcere al posto mio: come asciugherebbe quelle lacrime? Come placherebbe l’angoscia di questi uomini che non trovano una via d’uscita a ciò che sono diventati cedendo al male?
Trovare una risposta è un esercizio arduo, spesso incomprensibile per le nostre piccole e limitate logiche umane. La strada suggeritami da Cristo è contemplare quei volti sfigurati dalla sofferenza, senza provarne paura. Mi è chiesto di restare lì, accanto, rispettando i loro silenzi, ascoltando il dolore, cercando di guardare oltre il pregiudizio. Esattamente come Cristo guarda con occhi pieni d’amore le nostre fragilità e i nostri limiti. Ad ognuno, anche alle persone recluse, viene offerta ogni giorno la possibilità di diventare persone nuove grazie a quello sguardo che non giudica, ma infonde vita e speranza.
E in tal modo le lacrime cadute possono diventare il germoglio di una bellezza che era difficile anche solo immaginare.
Signore Gesù, la Veronica ha avuto compassione di Te: ha incontrato un uomo sofferente e ha scoperto il volto di Dio. Nella preghiera affidiamo al Padre tuo gli uomini e le donne dei nostri tempi che continuano ad asciugare le lacrime di tanti nostri fratelli.
Preghiamo.
O Dio, vera luce e sorgente della luce, che nella debolezza riveli l’onnipotenza e l’estremismo dell’amore, imprimi nei nostri cuori il tuo volto, affinché sappiamo riconoscerti nei patimenti dell’umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
VII stazione
Gesù cade per la seconda volta
Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte (Lc 23,34).
Quando passavo davanti a un carcere, mi voltavo dall’altra parte: “Tanto io non finirò mai là dentro”, dicevo tra me. Le volte che lo guardavo, respiravo malinconia e buio: mi sembrava di passare accanto a un cimitero di morti viventi. Un giorno, poi, sono finito io dietro le sbarre, assieme a mio fratello. Come se non bastasse, ho condotto lì dentro anche mio padre e mia madre. Da paese straniero qual era, il carcere è diventato la nostra casa: in una cella stavamo noi uomini, in un’altra nostra madre. Li guardavo, provavo vergogna di me: non me la sento più di chiamarmi uomo. Stanno invecchiando in prigione per colpa mia.
Sono caduto a terra due volte. La prima quando il male mi ha affascinato e io ho ceduto: spacciare droga, ai miei occhi, valeva più del lavoro di mio padre che si spaccava la schiena dieci ore al giorno. La seconda è stata quando, dopo aver rovinato la famiglia, ho cominciato a chiedermi: “Chi sono io perché Cristo muoia per me?”. Il grido di Gesù – «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» – lo leggo negli occhi di mia madre: si è accollata la vergogna di tutti gli uomini di casa per salvare la famiglia. E ha il volto di mio padre che, di nascosto, si disperava in cella. Solo oggi riesco ad ammetterlo: in quegli anni non sapevo quello che facevo. Adesso che lo so, con l’aiuto di Dio, sto cercando di ricostruire la mia vita. Lo devo ai miei genitori: anni fa hanno messo all’asta le nostre cose più care perché non volevano che facessi vita di strada. Lo devo soprattutto a me: l’idea che il male continui a comandare la mia vita è insopportabile. È diventata questa la mia via crucis.
Signore Gesù, sei a terra un’altra volta: appesantito dal mio attaccamento al male, dalla mia paura di non riuscire a essere una persona migliore. Con fede ci rivolgiamo al Padre tuo e lo preghiamo per tutti coloro che non hanno ancora saputo sfuggire al potere di Satana, a tutto il fascino delle sue opere e alle sue mille forme di seduzione.
Preghiamo.
O Dio, che non ci lasci nelle tenebre e nell’ombra della morte, sostieni la nostra debolezza, liberaci dalle catene del male e proteggici con lo scudo della tua potenza, perché possiamo cantare in eterno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
VIII stazione
Gesù incontra le donne di Gerusalemme
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: «Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato». Allora cominceranno a dire ai monti: «Cadete su di noi!», e alle colline: «Copriteci!» (Lc 23,27-30).
Quante volte, come figlia di una persona detenuta, mi sono sentita rivolgere una domanda: “Lei è affezionata al papà: pensa mai al dolore che suo padre ha causato alle vittime?”. In tutti questi anni non mi sono mai sottratta alla risposta: “Certo, mi è impossibile non pensarci”, dico. Poi faccio anch’io loro una domanda: “Avete mai pensato che di tutte le vittime delle azioni di mio padre io sono stata la prima? Da ventotto anni sto scontando la pena di crescere senza padre”. Per tutti questi anni ho vissuto di rabbia, inquietudine, malinconia: la sua mancanza è sempre più pesante da sopportare. Ho attraversato l’Italia da Sud a Nord per stargli accanto: conosco le città non per i loro monumenti ma per le carceri che ho visitato. Mi sembra di essere come Telemaco quando va alla ricerca di suo padre Ulisse: il mio è un Giro d’Italia di carceri e di affetti.
Anni fa ho perduto l’amore perché sono la figlia di un uomo detenuto, mia madre è caduta vittima della depressione, la famiglia è crollata. Sono rimasta io, con il mio piccolo stipendio, a reggere il peso di questa storia a brandelli. La vita mi ha costretto a diventare donna senza lasciarmi il tempo d’essere bambina. A casa nostra è tutta una via crucis: papà è uno di quelli condannati all’ergastolo. Il giorno che mi sono sposata, sognavo di averlo accanto a me: anche allora mi ha pensata da centinaia di chilometri di distanza. “È la vita!”, mi ripeto per farmi coraggio. È vero: ci sono genitori che, per amore, imparano ad aspettare che i figli maturino. A me, per amore, capita di aspettare il ritorno di papà.
Per quelli come noi la speranza è un obbligo.
Signore Gesù, il rimprovero alle donne di Gerusalemme lo sentiamo come un monito per ciascuno di noi. Ci invita alla conversione, passando da una religione sentimentalista a una fede radicata nella tua Parola. Preghiamo per quanti sono costretti a sopportare il peso della vergogna, la sofferenza dell’abbandono, il vuoto di una presenza. E per ciascuno di noi, affinché non si permetta che le colpe dei padri ricadano sui figli.
Preghiamo.
O Dio, Padre di ogni bontà, che non abbandoni i tuoi figli nelle prove della vita, donaci la grazia di poter riposare nel tuo amore e di godere sempre della consolazione della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
IX stazione
Gesù cade per la terza volta
È bene per l’uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone. Ponga nella polvere la bocca, forse c’è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore non respinge per sempre. Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo il suo grande amore (Lam 3,27-32).
Cadere a terra non è mai piacevole: cadere più e più volte, poi, oltre che non essere bello diventa anche una sorta di condanna, quasi che non si sia più capaci di restare in piedi. Come uomo sono caduto troppe volte: altrettante volte mi sono rialzato. In carcere ripenso spesso a quante volte un bambino cade a terra prima di imparare a camminare: mi sto convincendo che quelle siano le prove generali per quando si cadrà una volta diventati grandi. Da piccolo ho vissuto il carcere dentro casa: vivevo nell’angoscia della punizione, alternavo la tristezza degli adulti alla spensieratezza dei bambini. Di quegli anni ricordo suor Gabriella, l’unica immagine di festa: fu l’unica ad intravedere il meglio dentro il mio peggio. Come Pietro ho cercato e trovato mille scuse ai miei errori: il fatto strano è che un frammento di bene è sempre rimasto acceso dentro me.
In carcere sono diventato nonno: mi sono perso la gravidanza di mia figlia. Un giorno, alla mia nipotina, non racconterò il male che ho commesso ma solamente il bene che ho trovato. Le parlerò di chi, quando ero a terra, mi ha portato la misericordia di Dio. In carcere la vera disperazione è sentire che nulla della tua vita ha più un senso: è l’apice della sofferenza, ti senti il più solo di tutti i solitari al mondo. È vero che sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti ricomporre. Non è facile: è l’unica cosa, però, che qui dentro abbia ancora un significato.
Signore Gesù, per la terza volta cadi a terra e, quando tutti pensano che è la fine, ancora una volta ti rialzi. Con fiducia ci rimettiamo nelle mani del Padre tuo e gli affidiamo quanti si sentono imprigionati negli abissi dei propri errori, perché abbiano la forza di rialzarsi e il coraggio di lasciarsi aiutare.
Preghiamo.
O Dio, fortezza di chi spera in Te, che concedi a chi segue i tuoi insegnamenti di vivere nella pace, sostieni i nostri passi timorosi, rialzaci dalle cadute delle nostre infedeltà, versa sulle nostre ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
X stazione
Gesù è spogliato delle sue vesti
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte (Gv 19, 23-24).
Come educatrice penitenziaria vedo entrare in carcere l’uomo privato di tutto: viene spogliato di ogni dignità a causa delle colpe commesse, di ogni rispetto nei confronti di sé e degli altri. Ogni giorno mi accorgo che la sua autonomia viene meno dietro le sbarre: ha bisogno di me anche per scrivere una lettera. Sono queste le creature sospese che mi vengono affidate: degli uomini inermi, esasperati nella loro fragilità, spesso privi del necessario per comprendere il male commesso. A tratti, però, assomigliano a dei bambini appena partoriti che possono ancora essere plasmati. Percepisco che la loro vita può ricominciare in un’altra direzione, voltando definitivamente le spalle al male.
Le mie forze, però, si affievoliscono giorno dopo giorno. Essere un imbuto di rabbia, di dolore e di cattiverie covate finisce con il logorare anche l’uomo e la donna più preparati. Ho scelto questo lavoro dopo che mia madre è stata ammazzata in un incidente frontale da un ragazzo in preda agli stupefacenti: a quel male ho deciso di rispondere da subito con il bene. Ma pur amando questo lavoro, talora fatico a trovare la forza per portarlo avanti.
In questo servizio così delicato, abbiamo bisogno di non sentirci abbandonati, per poter sostenere le tante esistenze che ci sono affidate e che rischiano ogni giorno di naufragare.
Signore Gesù, nel contemplarti spogliato delle tue vesti proviamo imbarazzo e vergogna. A partire dal primo uomo, infatti, di fronte alla verità nuda abbiamo iniziato a scappare. Ci nascondiamo dietro maschere di perbenismo e tessiamo abiti di menzogna, spesso, con i logori brandelli dei poveri, usati dalla nostra avida sete di denaro e di potere. Che il Padre tuo abbia pietà di noi e con pazienza ci aiuti ad essere più semplici, più trasparenti, più veri: capaci di abbandonare definitivamente le armi dell’ipocrisia.
Preghiamo.
O Dio, che ci rendi liberi con la tua verità, spogliaci dell’uomo vecchio che fa resistenza in noi e rivestici della tua luce per essere nel mondo il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.
XI stazione
Gesù è inchiodato alla croce
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,33-43).
Cristo inchiodato alla croce. Quante volte, da prete, ho meditato su questa pagina di Vangelo. Quando poi, un giorno, mi hanno messo in croce, ho sentito tutto il peso di quel legno: l’accusa era fatta di parole dure come chiodi, la salita si è fatta ripida, il patimento si è inciso nella pelle. Il momento più buio è stato vedere il mio nome appeso fuori dall’aula del tribunale: in quell’attimo ho capito di essere un uomo costretto a dimostrare la sua innocenza, senza essere un colpevole. Sono rimasto appeso in croce per dieci anni: è stata la mia via crucis popolata di faldoni, sospetti, accuse, ingiurie. Ogni volta, nei tribunali, cercavo il Crocifisso appeso: lo fissavo mentre la legge investigava sulla mia storia.
La vergogna, per un istante, mi ha condotto al pensiero che sarebbe stato meglio farla finita. Poi, però, ho deciso di rimanere il prete che sono sempre stato. Non ho mai pensato di accorciare la croce, nemmeno quando la legge me lo concedeva. Ho scelto di sottopormi al giudizio ordinario: lo dovevo a me, ai ragazzi che ho educato negli anni del Seminario, alle loro famiglie. Mentre salivo il mio calvario, li ho trovati tutti lungo la strada: son diventati i miei cirenei, hanno sopportato con me il peso della croce, mi hanno asciugato tante lacrime. Assieme a me tanti di loro hanno pregato per il ragazzo che mi ha accusato: non smetteremo mai di farlo. Il giorno in cui sono stato assolto con formula piena, ho scoperto di essere più felice di dieci anni fa: ho toccato con mano l’azione di Dio nella mia vita. Appeso in croce, il mio sacerdozio si è illuminato.
Signore Gesù, il tuo amarci fino alla fine ti ha portato sulla Croce. Stai morendo, ma non ti stanchi di perdonarci e di darci vita. Affidiamo al Padre tuo gli innocenti della storia che hanno sofferto un’ingiusta condanna. Risuoni nei loro cuori l’eco della tua parola: «Oggi sarai con me in Paradiso».
Preghiamo.
O Dio, fonte di misericordia e di perdono, che ti riveli nelle sofferenze dell’umanità, illuminaci con la grazia che sgorga dalle piaghe del Crocifisso e donaci di perseverare nella fede durante la notte oscura della prova. Per Cristo nostro Signore. Amen.
XII stazione
Gesù muore in croce
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò (Lc 23, 44-46).
Come magistrato di sorveglianza, non posso inchiodare un uomo, qualsiasi uomo, alla sua condanna: vorrebbe dire condannarlo una seconda volta. È necessario che l’uomo espii il male che ha commesso: non farlo significherebbe banalizzare i suoi reati, giustificare le azioni intollerabili da lui compiute che hanno arrecato ad altri sofferenza fisica e morale.
Una vera giustizia, però, è possibile solo attraverso la misericordia che non inchioda per sempre l’uomo in croce: si offre come guida nell’aiutarlo a rialzarsi, insegnandogli a cogliere quel bene che, nonostante il male compiuto, non si spegne mai completamente nel suo cuore. Solo ritrovando la sua umanità, la persona condannata potrà riconoscerla nell’altro, nella vittima a cui ha provocato dolore. Per quanto il suo percorso di rinascita possa essere tortuoso e il rischio di ricadere nel male resti sempre in agguato, non esistono altre strade per cercare di ricostruire una storia personale e collettiva.
La rigidità del giudizio mette a dura prova la speranza nell’uomo: aiutarlo a riflettere e a chiedersi le motivazioni delle sue azioni potrebbe diventare l’occasione per guardarsi da un’altra prospettiva. Per fare questo, però, è necessario imparare a riconoscere la persona nascosta dietro la colpa commessa. Così facendo, a volte si riesce ad intravedere un orizzonte che può infondere speranza alle persone condannate e, una volta espiata la pena, riconsegnarle alla società, invitando gli uomini a riaccoglierli dopo averli un tempo, magari, respinti.
Perché tutti, anche da condannati, siamo figli della stessa umanità.
Signore Gesù, muori per una sentenza corrotta, pronunciata da giudici iniqui e terrorizzati dalla prorompente forza della Verità. Affidiamo al Padre tuo i magistrati, i giudici e gli avvocati, perché si mantengano retti nell’esercizio del loro servizio a favore dello Stato e dei suoi cittadini, soprattutto di quelli che soffrono per una situazione di povertà.
Preghiamo.
O Dio, re di giustizia e di pace, che hai accolto nel grido del Figlio tuo quello dell’intera umanità, insegnaci a non identificare la persona con il male commesso e aiutaci a scorgere in ciascuno la fiamma viva del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
XIII stazione
Gesù è deposto dalla croce
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto (Lc 23, 50-53).
Le persone detenute sono, da sempre, i miei maestri. Da sessant’anni entro nelle carceri come frate volontario e ho sempre benedetto il giorno in cui, per la prima volta, ho incontrato questo mondo nascosto. In quegli sguardi ho compreso con chiarezza che avrei potuto esserci io al posto loro, qualora la mia vita avesse preso una direzione diversa. Noi cristiani cadiamo spesso nella lusinga di sentirci migliori degli altri, come se essere nella condizione di poterci occupare dei poveri ci permettesse una superiorità tale da ergerci a giudici degli altri, condannandoli tutte le volte che vogliamo, senza nessun appello.
Cristo, nella sua vita, ha scelto e voluto stare con gli ultimi: ha percorso le periferie dimenticate del mondo in mezzo a ladri, lebbrosi, prostitute, imbroglioni. Ha voluto condividere miseria, solitudine, turbamento. Ho sempre pensato fosse questo il vero senso di quelle sue parole: «Ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,36).
Passando da una cella all’altra vedo la morte che vi abita dentro. Il carcere continua a seppellire uomini vivi: sono storie che non vuole più nessuno. A me Cristo ogni volta ripete: “Continua, non fermarti. Prendili in braccio ancora”. Non posso non ascoltarlo: anche dentro al peggiore degli uomini c’è sempre Lui, per quanto infangato sia il suo ricordo. Devo solo porre un argine alla mia frenesia, fermarmi in silenzio davanti a quei volti devastati dal male e ascoltarli con misericordia. È l’unica maniera che conosco per accogliere l’uomo, spostando dal mio sguardo l’errore che ha commesso. Solamente così potrà fidarsi e ritrovare la forza di arrendersi al Bene, immaginandosi diverso da come ora si vede.
Signore Gesù, il tuo corpo deformato da tanto male, adesso, è avvolto in un lenzuolo e consegnato alla nuda terra: ecco la nuova creazione. Affidiamo al Padre tuo la Chiesa, che nasce dal tuo fianco squarciato, perché non si arrenda mai davanti all’insuccesso e all’apparenza, ma continui a uscire per portare a tutti il lieto annuncio della salvezza.
Preghiamo.
O Dio, principio e fine di tutte le cose, che nella Pasqua di Cristo hai redento l’umanità intera, donaci la sapienza della Croce per poterci abbandonare alla tua volontà, accettandola con animo lieto e riconoscente. Per Cristo nostro Signore. Amen.
XIV stazione
Gesù è sepolto
Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto (Lc 23,54-56).
Nella mia missione di agente di Polizia Penitenziaria, ogni giorno tocco con mano la sofferenza di chi vive recluso. Non è facile confrontarsi con chi è stato vinto dal male e ha inferto ferite enormi ad altri uomini, complicando le loro esistenze. Eppure, in carcere, l’indifferenza crea ulteriori danni nella storia di chi ha fallito e sta pagando il proprio conto alla giustizia. Un collega, che mi è stato maestro, ripeteva spesso: “Il carcere ti trasforma: un uomo buono può diventare un uomo sadico. Un malvagio potrebbe diventare migliore”. Il risultato dipende anche da me e stringere i denti è essenziale per raggiungere l’obiettivo del nostro lavoro: dare un’altra possibilità a chi ha favorito il male. Per tentare questo, non posso limitarmi ad aprire e chiudere una cella, senza farlo con un pizzico di umanità.
Rispettando i tempi di ciascuno, le relazioni umane possono rifiorire piano piano anche dentro questo mondo pesante. Si traducono in gesti, attenzioni e parole capaci di fare la differenza, anche se pronunciate a bassa voce. Non mi vergogno di esercitare il diaconato permanente vestendo la divisa della quale vado orgoglioso. Conosco la sofferenza e la disperazione: le ho provate da bambino su di me. Il mio piccolo desidero è essere un punto di riferimento per chi incontro tra le sbarre. Ce la metto tutta per difendere la speranza di gente rassegnata a se stessa, spaventata al pensiero di quando un giorno uscirà e rischierà di essere rifiutata ancora una volta dalla società.
In carcere ricordo loro che, con Dio, nessun peccato avrà mai l’ultima parola.
Signore Gesù, ancora una volta sei consegnato alle mani dell’uomo, questa volta però, ad accoglierti sono le mani amorevoli di Giuseppe d’Arimatea e di alcune pie donne venute dalla Galilea, che sanno che il tuo corpo è prezioso. Queste mani rappresentano le mani di tutti coloro che non si stancano mai di servirti e che rendono visibile quell’amore di cui l’uomo è capace. è proprio questo amore che ci fa sperare nella possibilità di un mondo migliore: basta soltanto che l’uomo sia disposto a lasciarsi raggiungere dalla grazia che viene da Te. Nella preghiera, affidiamo al Padre tuo, in modo particolare, tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria e quanti collaborano a diverso titolo nelle carceri.
Preghiamo.
O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, ricolma dei tuoi beni coloro che si dedicano alla tua lode e al servizio di chi soffre, negli innumerevoli luoghi di dolore dell’umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen.