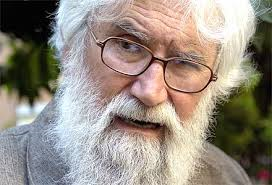non si escluda nessuno nel nome di Gesù

La disputa sulla riammissione ai sacramenti dei divorziati risposati non accenna a sgonfiarsi. Solo di qualche settimana fa è la notizia, per esempio, che la maggior parte dei vescovi tedeschi appoggia la soluzione aperturista prospettata dal card. Walter Kasper nel Concistoro del febbraio 2014 (v. Adista Notizie n. 1/15), ed è prevedibile che all’avvicinarsi del Sinodo di ottobre, incaricato di individuare adeguate linee operative pastorali sul tema della famiglia, il fuoco incrociato si faccia sempre più intenso.
Così è avvenuto in prossimità del Sinodo straordinario dello scorso autunno, quando in tanti, tra cardinali, vescovi e teologi, hanno pensato di mettere nero su bianco le loro aspettative e i loro timori. Tra le iniziative di questo tipo spiccava, sul fronte conservatore capitanato dal prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, card. Gerhard Ludwig Müller, il volume Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica (edito in Italia da Cantagalli) che raccoglie le risposte di cinque cardinali e quattro esperti alla “proposta Kasper” di armonizzare fedeltà e misericordia nella pratica pastorale con i divorziati risposati. I nomi dei cinque pezzi da novanta non riservavano particolari sorprese, avendo tutti già preso posizione sulla questione nei mesi antecedenti alla pubblicazione: oltre a Müller, a firmare i saggi che compongono il volume sono Walter Brandmüller, presidente emerito del Pontificio Comitato di Scienze Storiche; Raymond Leo Burke, allora prefetto della Segnatura Apostolica; Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, e Velasio De Paolis, presidente emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (v. Adista Notizie n. 32/14). Nel testo i cinque cardinali – come si evince anche dal titolo – fanno largo uso dell’argomento scritturistico per confutare la “proposta Kasper”, ma se è innegabile che Gesù abbia parlato dell’indissolubilità del matrimonio, molto invece c’è da dire circa l’interpretazione di quelle parole.
Ed è precisamente su questo aspetto che pone l’accento il teologo Xavier Alegre in un intervento pubblicato sull’ultimo Quaderno del centro studi Cristianisme i Justícia (dicembre 2014), interamente dedicato al tema della riammissione ai sacramenti dei divorziati risposati, e che, pur non costituendo una risposta al volume di Cantagalli, si inserisce a pieno titolo nel dibattito in corso (oltre a quello di Alegre, il volumetto contiene gli interventi di José Ignacio González Faus, Jesús Martínez Gordo e Andrés Torres Queiruga).
Partendo dall’assunto che i testi non possono mai essere presi alla lettera e che si deve sempre tener conto del contesto nel quale sono stati scritti, Alegre sottolinea che «Gesù nei Vangeli non assume mai un atteggiamento legalista»: «Se qualcosa lo caratterizza, e caratterizza il Dio che vuole rivelare con le sue parole e azioni, questo è la misericordia». Per questo, secondo Alegre, le parole di Gesù sull’indissolubilità del matrimonio vanno lette alla luce della subalternità della moglie nel rapporto coniugale del tempo: insomma, per denunciare il diritto matrimoniale dell’epoca che consentiva solo al marito di prendere l’iniziativa di divorziare, Gesù «si rifà alla volontà originaria di Dio nella creazione che difendeva, come ideale, l’amore indissolubile tra marito e moglie». Ma affermando un’ideale valido tanto per l’uomo quanto per la donna, prosegue Alegre, Gesù non proclama una legge, bensì un progetto ideale di vita. «Gesù – prosegue il teologo – accoglie incondizionatamente, confidando che l’esperienza della sua accoglienza amorosa aiuterà ad avvicinarsi al Padre». Di fatto, è la sua conclusione, «non partecipiamo all’eucarestia perché siamo buoni, ma affinché lo si possa essere grazie all’unione intima con Gesù».
di seguito, in una traduzione dallo spagnolo da parte di Adista – da cui è preso questo prezioso contributo -, l’intervento di Alegre tratto da Cristianisme i Justícia, il cui volumetto è disponibile integralmente, in spagnolo e catalano, sul sito http://www.cristianismeijusticia.net/es/quaderns. (ingrid colanicchia)
La posizione di Gesù sul matrimonio
di Xavier Alegre
È degno di attenzione il fatto che, secondo i Vangeli, Gesù parlò poco del matrimonio e della sessualità, mentre la denuncia dei pericoli della ricchezza fu un aspetto fondamentale della sua predicazione, soprattutto nel Vangelo di Luca. Sorprende, quindi, che nel Magistero della Chiesa la proporzione sia inversa e soprattutto fa specie il contrasto nel modo in cui il Magistero affronta la morale sociale e la morale sessuale.
In materia di morale sociale, come sottolinea il Catechismo della Chiesa cattolica (n. 2423), «la dottrina sociale della Chiesa propone principi di riflessione; formula criteri di giudizio, offre orientamenti per l’azione». In tutto ciò che riguarda la morale sessuale, invece, dichiara in modo tassativo ciò che è lecito e ciò che non lo è. Tuttavia, niente nella Bibbia giustifica questa diversità di atteggiamento rispetto ai testi relativi a Gesù nei Vangeli.
RIFLESSIONI PREVIE
Se si vuole comprendere quale fu l’atteggiamento di Gesù rispetto al matrimonio e, di conseguenza, cosa Gesù si aspettasse dai suoi seguaci, ieri come oggi (cfr. Rom 15,4), mi sembra importante sottolineare che c’è un presupposto fondamentale di cui tener conto quando si legge un testo biblico: i testi non possono mai essere presi alla lettera, sulla base di una lettura fondamentalista, prescindendo dal contesto letterario e socioculturale nel quale furono scritti. Pertanto, i ricordi di Gesù trasmessici dai Vangeli devono essere interpretati adeguatamente, come qualsiasi altro testo, ancor più se antico.
E ciò implica due cose. In primo luogo, non devono essere letti al di fuori del contesto letterario globale dei Vangeli, poiché «un testo fuori contesto si converte facilmente in un pretesto». Né, in secondo luogo, possono essere letti senza tener presente il contesto storico-sociale e culturale nel quale sono nati, se non vogliamo finire per leggerli a partire dal nostro contesto e dai nostri preconcetti, anziché a partire dalla mentalità biblica.
La Bibbia non corrisponde a un dettato di Dio, ma è, in quanto parola umana, rivelazione di Dio pienamente incarnata nel contesto culturale nel quale i testi furono scritti. Così evidenziò il Concilio Vaticano II nella Costituzione Dei Verbum. Per questo, una rilettura continua, attraverso questa «biblioteca» che è la Bibbia, dei testi fondamentali che rispondono a un’esperienza profonda di Dio in un momento concreto, è il filo conduttore di cui è intessuta la Bibbia. Questa rilettura la troviamo già nell’Antico Testamento a proposito dell’esperienza dell’Esodo e per i cristiani culmina con la rilettura attualizzata dell’Antico Testamento condotta da Gesù di Nazareth (cfr. Mt 5,17-48). E portata avanti dai suoi discepoli nel Nuovo Testamento.
L’ATTEGGIAMENTO DI GESÙ RISPETTO AL MATRIMONIO SECONDO I VANGELI
Nonostante Gesù abbia parlato poco del matrimonio, sembra innegabile, secondo i Vangeli (e Paolo lo dà per assodato), il fatto che Gesù proclamò che, nel progetto di Dio, il matrimonio era, in principio, indissolubile. E condannò fermamente il divorzio in due testi fondamentali, in origine indipendenti: nel Vangelo di Marco (10,1-12, un testo che raccoglie Matteo 19,1-12), e in una fonte che si è persa, ma che fu raccolta da Matteo e Luca (Mt 5,31-32; Lc 16,18).
Che intendeva Gesù? Per interpretare adeguatamente questi testi, non dobbiamo dimenticare che Gesù, secondo i Vangeli, pronunciò anche molte altre parole radicali: per esempio, ai discepoli che avrebbero dovuto ricoprire un ruolo di leadership nella Chiesa, disse che non avrebbero dovuto farsi chiamare «padri» o «maestri» » (Mt 23,9-10), né avrebbero dovuto indossare abiti speciali o occupare sempre i primi posti nelle riunioni ecclesiali (Mt 23,4-8). E ammonì tutti i cristiani a non fare giuramenti (Mt 5,33-37), a porgere l’altra guancia (Mt 5,38-42) e ad amare i propri nemici (Mt 5,43-48).
È ovvio che la Chiesa non ha preso alla lettera tutte queste parole, e altre simili (come Mc 10,25), ad eccezione di quelle sul divorzio. La domanda che dobbiamo porci, allora, è se è giustificato che le parole relative al divorzio debbano essere interpretate – per fedeltà a Gesù! – alla lettera. Di modo che, per esempio, un divorziato che si risposi e abbia relazioni sessuali con il proprio partner debba essere escluso dalla partecipazione all’eucarestia, come ha interpretato il Magistero della Chiesa cattolica, a differenza di quanto avvenuto nella Chiesa ortodossa (o in quelle evangeliche), in cui è permesso un nuovo matrimonio.
LE INTENZIONI DELLE PAROLE DI GESÙ SUL DIVORZIO
Per rispondere adeguatamente alla domanda su come si debbano interpretare questi testi è necessario guardare alla volontà di Gesù rivelata dai Vangeli, così come è necessario tenere presente il contesto socioculturale e letterario nel quale si collocano le sue parole sul divorzio.
La volontà di Gesù
A differenza di come sono presentati farisei, scribi e sacerdoti ebrei, Gesù nei Vangeli non assume mai un atteggiamento legalista. Se qualcosa lo caratterizza – e caratterizza il Dio che vuole rivelare con le sue parole e azioni – è la misericordia. Perché così è Dio. E così devono essere i discepoli: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,36).
E lo esemplifica nel modo in cui agisce: accogliendo, condividendo la tavola con i peccatori e gli emarginati, criticando quanti si credevano pii, in maniera da rivelare con questo atteggiamento che Dio ama tutti, buoni e cattivi, facendo sorgere il sole tanto sugli uni quanto sugli altri (Mt 5,44-45).
Più che norme concrete, quello che propugna sono atteggiamenti determinati, profondamente umanizzanti. Egli invita alla perfezione come vocazione (Mt 5,48), non come legge. E le leggi, anche quelle più sacre per gli ebrei, come l’obbligo di non lavorare di sabato (Es 20,8-10), non devono essere interpretate alla lettera, poiché sono promulgate da Dio per il bene dell’essere umano (Mc 2,27).
Nella gerarchia dei valori di Gesù, il bene dell’essere umano supera qualsiasi altra legge, per quanto sacra (Mc 3,1-6; Gv 5,1-18). Per questo non va interpretata alla lettera (Mt 5,21-48).
La situazione socioculturale del matrimonio al tempo di Gesù
La concezione del matrimonio nel mondo ebraico di Gesù è radicalmente diversa da quella odierna. Secondo la legge, la relazione tra moglie e marito non era di eguaglianza, né il matrimonio era una scelta libera della coppia, ma rispondeva a determinati interessi, fondamentalmente economici, delle rispettive famiglie. In questo contesto, la donna era chiaramente marginalizzata, appartenendo fino al matrimonio al padre e poi al marito. Quest’ultimo, secondo la concezione più permissiva della scuola del rabbino Hillel, basata su Dt 24,1, poteva separarsi dalla moglie per qualsiasi motivo (per esempio, perché aveva incontrato una donna più giovane e bella). Oppure, secondo la concezione più rigida della scuola del rabbino Shammai, poteva divorziare solo in caso di adulterio. La donna, invece, non poteva prendere l’iniziativa di divorziare per alcun motivo.
In questo contesto sociale, i farisei chiedono a Gesù (secondo Marco 10,1-12, per metterlo alla prova) se è consentito al marito separarsi dalla moglie. Sanno bene che Gesù non è un legalista e che non interpreta mai la Legge in modo fondamentalista ma sempre a favore dei più vulnerabili (e nel caso del divorzio era la moglie a esserlo). E cercano quindi un’occasione per accusarlo di non rispettare la Legge di Dio.
Gesù rifiuta questa casistica destinata a emarginare le donne (al contrario, secondo testi come Luca 8,1-3, permette persino alle donne, contraddicendo quanto sostenevano i rabbini, di essere discepole; cfr. Lc 8,1-3; 10,38-42). Però, per denunciare l’ingiustizia derivante dalla casistica rabbinica, si rifà alla volontà originaria di Dio nella creazione, che difendeva, come ideale, l’amore indissolubile tra marito e moglie (in Marco 10,5-9, cita il testo di Genesi 1,27 e 2,24). È un ideale, spesso utopico, più che mai attuale, oggi, in un matrimonio plasmato fondamentalmente sull’amore della coppia.
Da buon ebreo del suo tempo, Gesù avrebbe dovuto parlare del divorzio solo dal punto di vista dell’uomo, che era l’unico legittimato a divorziare (cfr. Mc 10,2-9). Però Marco, che vive in una cultura romana, in cui l’uomo e la donna sono maggiormente equiparati quanto a possibilità di divorzio, aggiunge i versetti 11-12, esplicitando l’intenzione di Gesù in un nuovo contesto: questo ideale di unione matrimoniale indissolubile è valido tanto per l’uomo quanto per la donna.
Così facendo, Gesù non proclama una legge, ma un progetto ideale di vita. Perché, come sottolinea lo studioso cattolico Gerhard Lohfink, la forma letteraria che il Vangelo utilizza qui non è, anche se lo sembra, quella di un testo giuridico inappellabile, ma quella di un’esortazione e di una sfida «senza dimenticare il suo carattere provocatorio», come accade anche con altre affermazioni di Gesù (per esempio Mt 7,13s; 19,24).
Gesù, pertanto, vuole smascherare l’ingiustizia contro le donne che deriva dal diritto matrimoniale giudaico e anche promuovere (come profeta, non come legislatore) l’amore radicale nella coppia come applicazione concreta del principio di amore per il prossimo (Mt 22,39). Un amore che trova la sua realizzazione in quel principio che è la quintessenza di quanto chiedono la Legge e i profeti: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12).
Il contesto letterario delle parole sul divorzio
Ciò che abbiamo detto è confermato dal contesto letterario nel quale gli evangelisti situano le parole di Gesù sul divorzio.
Il primo testo, attribuito a Gesù, lo troviamo in Marco 10,1-12. Oltre a quanto abbiamo visto sul senso della forma letteraria di questo testo, conviene tenere presente il contesto letterario nel quale Marco lo situa. Si trova in un blocco fondamentale del suo Vangelo, nel quale – anche per comprendere meglio ciò che significa per i seguaci di Gesù il fatto che Gesù è il Messia, l’Unto (Mc 8,27-39) –, Marco concretizza i valori fondamentali indicati da Gesù a quanti lo vogliono seguire (cfr. Mc 8,31-10,45), inquadrandoli con tre annunci della morte e resurrezione di Gesù (Mc 8,31; 9,31; 10,32-34). Questi valori, che, se vissuti con radicalità, possono facilmente portare alla croce (Mc 8,34), contengono parole di grande radicalità: che i ricchi, se vogliono essere perfetti, devono dare ai poveri i loro averi (Mc 10,23-27); che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli (Mc 10,25); che, se la nostra mano o il nostro piede è occasione di scandalo per i piccoli, è preferibile tagliarli (Mc 9,42-48). O che colui che vuole essere il primo e il più grande deve farsi servitore di tutti (Mc 10,42-45). E affinché non si spiritualizzi indebitamente tutto ciò, lo contrappone a ciò che fanno i re e i politici, allora come oggi.
È dunque tenendo presente questo contesto che dobbiamo interpretare le parole di Gesù sul divorzio. Il secondo testo (Mt 5,31-32 o Lc 16,18) Matteo lo colloca all’interno del discorso della montagna (Mt 5-7) che, in nessun caso, vuole essere un Codice di diritto canonico o una proposta di legge immutabile, ma un ideale dinamico di vita cristiana, impegnata a favore del progetto di Dio (quello che Gesù chiama il Regno di Dio). Luca lo colloca nel cammino verso Gerusalemme (Lc 9,51-19,28), in un ampio testo in cui il terzo evangelista presenta i grandi valori cristiani che, se vissuti con la stessa radicalità di Gesù, finiscono – in un mondo tanto ingiusto, allora come oggi – per condurre alla croce. Un testo che, tra le altre cose, contiene dure critiche contro i ricchi che non vogliono condividere (Lc 12,13-21; 16,1-13.19-31), fino all’affermazione che non si può servire Dio e mammona (Lc 16,13). Questo contesto non permette in nessun caso di interpretare tali testi come leggi immutabili.
Reinterpretazione delle parole sul divorzio in Matteo e Paolo
La conferma la troviamo nel Vangelo di Matteo e nella Prima Lettera di Paolo ai Corinzi, dove le parole di Gesù sul divorzio non sono interpretate alla lettera, come una legge assoluta e senza eccezione, ma vengono attualizzate in rapporto alle nuove situazioni che stavano vivendo le loro comunità.
Per questo, Matteo aggiunge al versetto 5,32 (che non sembra parola di Gesù poiché non si trova in nessun altro testo del Nuovo Testamento) un’eccezione alla proibizione di divorzio: la sua comunità lo accetta in caso di adulterio (o di «impurità legale» per il matrimonio ebraico, secondo alcuni studiosi).
Paolo, in 1Cor 7,10-11, ricorda alla sua comunità, come un ordine del Signore, che moglie e marito non devono separarsi e che, se lo fanno, non devono risposarsi, poiché sembra considerare la possibilità di una riconciliazione (…). Tuttavia non la considera una norma assoluta, poiché accetta almeno un caso concreto in cui il divorzio e le nuove nozze appaiono qualcosa di legittimo: si tratta del caso in cui è un non credente a volersi separare. In questo caso il o la credente è libero (…). Questa eccezione è stata chiamata nella Chiesa “privilegio paolino”.
CONCLUSIONE
Stando così le cose, quale deve essere oggi l’atteggiamento di una Chiesa che vuole essere fedele a Gesù rispetto ai divorziati risposati? Bisogna escluderli dalla partecipazione all’eucarestia a meno che non rispettino alcune condizioni, come quella di non avere rapporti sessuali?
Indipendentemente dal fatto che ci sia stato o meno peccato nel processo di separazione – in alcuni casi è ovvio che non c’è stato e in altri forse sì – dobbiamo tenere presente, per quanto abbiamo visto nei Vangeli, che Gesù accoglie incondizionatamente, confidando che l’esperienza della sua accoglienza amorosa aiuterà ad avvicinarsi al Padre. Di fatto, se andò a mangiare a casa di Zaccheo, non è perché questi aveva chiesto perdono per i suoi peccati e si era riconciliato con il popolo di Dio (Lc 19,1-10). Né pose condizioni ai peccatori invitati alla sua mensa (Mc 2,15-17). Partecipare all’eucarestia è sempre dono e grazia per tutti. E chi pensa di essere senza peccato scagli la prima pietra (Gv 8,1-11). Non partecipiamo all’eucarestia perché siamo buoni, ma affinché si possa esserlo grazie all’unione intima con Gesù.
D’altra parte, con che diritto ci permettiamo di giudicare? E lo stesso vale per gay e lesbiche, un tema che qui non abbiamo potuto trattare ma che allo stesso modo richiederebbe una rilettura e una reinterpretazione dei testi biblici alla luce del contesto socioculturale e letterario nel quale sono collocati.
Dopo quanto abbiamo visto, sembra ovvio che non si possa giudicare ed emarginare i divorziati – neppure se risposati – in nome di Gesù, così come ci è rivelato nei Vangeli. I testi evangelici, letti nel loro contesto, non danno luogo alla loro condanna e ancor meno alla loro esclusione dall’eucarestia: poiché non è questo il senso dei testi che troviamo nei Vangeli.
Inoltre, ogni cristiano deve tenere ben presente l’avvertimento di Gesù che il giudizio sulle persone compete solo a Lui. Ed è giusto che sia così, poiché è ovvio che Egli ci ama. Al contrario, Gesù ci ha ammonito a non cercare di sradicare dalla comunità ciò che si pensa possa essere zizzania, poiché corriamo il pericolo di sradicare con la zizzania anche il grano (Mt 13,24-30.36-43). E ci ha anche invitato a fare molta attenzione nel giudicare gli altri poiché Dio ci giudicherà con lo stesso metro che abbiamo utilizzato per loro (Mt 7,1-2).
Fonte: Adista n. 8/2015
Link: http://www.adistaonline.it/index.php?op=articolo&id=54763