12 giugno 2016
XI domenica del tempo Ordinario anno C
di ENZO BIANCHI


Lc 7,36-8,3
In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.
Nel vangelo secondo Luca è narrato un episodio riguardante Gesù e una donna anonima, avvenuto durante un banchetto. Questo racconto sembra fissato letterariamente, con significative differenze, in tutti e quattro i vangeli (cf. Mc 14,3-9; Mt 26,6-13; Gv 12,1-11), plasmato e collocato da ciascun evangelista nello sviluppo della narrazione in modo conforme alla propria visione teologica. Si potrebbe anche dire che questo episodio “ha vissuto” nelle diverse comunità cristiane, ricevendo una stesura finale diversa in ogni vangelo. Ma questa è un’ipotesi fatta dagli esegeti!
Preferisco dunque leggere questo racconto di Luca, indipendentemente dai possibili paralleli, per cogliere l’atteggiamento di Gesù verso una donna che l’evangelista definisce “peccatrice”, cioè una donna manifestamente peccatrice a causa del suo mestiere di prostituta e della conoscenza che avevano di lei i suoi concittadini. È un racconto scabroso, che ha scandalizzato e scandalizza ancora quanti pensano a se stessi come a persone che devono stare lontane da viziosi, prostitute, peccatori riconosciuti… Gesù però ha mostrato di non fermarsi mai davanti a barriere costruite da altri come difese immunitarie, erette a causa della condizione morale, sessuale, religiosa o etnica. A costo di essere male interpretato e letto come “un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori” (Mt 11,19; Lc 7,34), non temeva di sedere con loro a tavola o di alloggiare nelle loro case, perché sentiva la sua missione come accoglienza dei peccatori, annuncio della buona notizia a quanti erano lontani da Dio e dalla sua Legge. Così quelli che sembravano esclusi dalla comunione con Dio, grazie a Gesù diventavano quelli che ascoltavano la buona notizia!
Gesù è invitato a tavola da Simone, un fariseo, un uomo religioso, osservante della Legge e irreprensibile. Egli accetta l’invito, entra a casa sua e si adagia a tavola insieme a lui. Ed ecco che una donna, notoriamente una prostituta, saputo che Gesù si trova a tavola in casa di quel fariseo, con audacia entra in quel banchetto riservato a uomini portando un vasetto di alabastro pieno di profumo. Entra furtivamente, si ferma “dietro” a Gesù (come i discepoli: cf. Lc 9,23; 14,27), si rannicchia “ai suoi piedi” (in posizione di ascolto, di discepola, come Maria di Betania: cf. Lc 10,39) e fa quello che sovente faceva per mestiere: lavare i piedi dei clienti e profumarli. Fa così anche con Gesù, ma con una significativa novità lo fa gratuitamente, non richiesta, e lava i suoi piedi con le proprie lacrime, baciandoli con tutto l’amore di cui è capace. Ha sentito parlare di Gesù, lo ha ascoltato e lo ama a tal punto da osare con audacia un gesto straordinario.
Ed ecco che, alla vista dei gesti compiuti da questa donna, subito si crea un grande imbarazzo, e gli uomini religiosi là presenti, in primis il fariseo che ha invitato Gesù, restano scandalizzati: Gesù è un rabbi che non le imputa nulla, non l’accusa e si lascia palpare da questa donna, riconoscibile come una prostituta dall’abbigliamento! Quell’intimità sempre disdicevole con una donna appare una grave offesa alla Legge, perché quella donna è impura! Il fariseo è costretto dalla sua etica a pensare: o Gesù non è un profeta e non sa cosa stia avvenendo né chi sia quella donna, oppure è uno che in realtà ama questi gesti, la compagnia delle prostitute, il loro comportamento. La scena è intollerabile, imbarazza, perché ha indubbiamente una qualità erotica: quella prostituta palpa e tasta i piedi di Gesù, li bacia, li bagna con le lacrime e poi li asciuga con i suoi lunghi capelli. È una donna non velata come tutte le altre e fa i gesti nei quali le prostitute sono esperte per sedurre e dare piacere. Infine, tirato fuori un vasetto di profumo, cosparge con l’unguento i piedi Gesù. Questo è davvero troppo!
Gesù invece legge tutto diversamente: c’è una donna rannicchiata ai suoi piedi che tocca il suo corpo, piange fino a lavare i suoi piedi con le lacrime, li asciuga con i suoi capelli, li bacia senza dire una parola e li profuma. Gesù vede una donna che ha sofferto e che soffre, che ama, una donna in cerca di amore, mentre il fariseo vede una peccatrice. Qui sta la differenza tra il rabbi Gesù e gli altri esperti della Legge, gli uomini religiosi: egli non vede prima il peccato, ma la sofferenza, e qui soprattutto vede qualcuno che può essere amato nonostante i suoi peccati e che ama ancora; gli uomini religiosi invece si esercitano prima a spiare, a misurare il peccato, a emettere un giudizio, poi eventualmente vedono la sofferenza come esito del peccato…
Secondo la Legge e il pensiero dominante quella donna impura, toccando il corpo di Gesù, gli comunicherebbe la sua impurità, ma il vangelo sottolinea piuttosto che lei sa trasformare in una manifestazione di amore verso di lui ciò che aveva sempre svolto come prestazione pagata. Spinta dall’amore, agisce senza timore: “nell’amore non c’è timore” (1Gv 4,18)! Ciò che compie sta nel registro amoroso, e Luca descrive le azioni all’imperfetto, cioè come gesti ripetuti, caratterizzati da una lunga durata: “asciugava, baciava, ungeva”… Le mani di questa donna prendono e abbracciano i piedi di Gesù, le sue lacrime li bagnano fino a lavarli, i suoi capelli li asciugano, i suoi baci raccontano con la bocca i suoi sentimenti, le sue mani versano profumo e lo spandono sui suoi piedi. La donna piange perché sente la colpa dei peccati commessi, o forse piange di gioia, perché ha finalmente trovato un uomo che può davvero amare e da cui essere riamata. In un silenzio assoluto lascia che sia il suo corpo a esprimere il suo linguaggio affettivo: audacia, umiltà, amore, e tutto è riassunto nelle sue lacrime, il vero significato nascosto in quei gesti.
Per il fariseo questo palpare è un peccato, un pericolo per Gesù, è l’anticamera di relazioni intime vietate dalla Legge, mentre per Gesù è liturgia di amore, celebrazione dell’amore. Ed è proprio in forza di questa consapevolezza che egli, fino a questo momento silenzioso e oggetto di attenzioni da parte di altri, prende l’iniziativa. Il testo dice letteralmente che Gesù, “rispondendo”, parla. Simone ha solo pensato nel suo cuore, non ha parlato, ma Gesù conosce i pensieri dei cuori (cf. Gv 2,24-25) e così manifesta di essere veramente profeta. Leggendo dunque le intenzioni di chi lo ospita, lo chiama per nome e gli si rivolge con autorevolezza di rabbi: “Simone, ho qualcosa da dirti”. E l’altro replica: “Maestro, di’ pure”. Allora Gesù gli racconta una breve parabola, con lo scopo di far mutare il modo di pensare del fariseo: “Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”. Simone comprende il senso di questa parabola così semplice, e giudica bene, ma anche con una certa prudenza, fiutando l’aria di un trabocchetto: “Suppongo colui al quale ha condonato di più”.
Qui il racconto potrebbe terminare, e l’insegnamento sarebbe chiaro. Ma Gesù prosegue e, voltandosi verso la donna – con uno sguardo che la reintegra nella sua dignità di donna –, chiede a Simone: “Vedi questa donna?”. Domanda non banale, vero invito a vedere non una peccatrice ma una donna. Poi Gesù si dilunga in un confronto tra questa donna e Simone, opponendo ciò che lei ha fatto e ciò che lui non ha fatto; o meglio, ciò che lei gli ha donato e ciò che lui non gli ha donato. Simone lo ha invitato a pranzo, ma non gli ha donato l’acqua per lavare i suoi piedi, mentre la donna li ha lavati con le lacrime e asciugati con i capelli; Simone non gli ha dato un bacio, mentre la donna non ha cessato di baciare i piedi di Gesù; Simone non lo ha profumato, mentre la donna ha unto di profumo i suoi piedi. In breve, Simone non ha saputo donare nulla a Gesù, la donna invece si è fatta tutta dono per lui: ha agito con il corpo che era, non con il corpo che possedeva, con l’interezza del suo essere il suo corpo animato dall’amore per Gesù. Dunque, grazie a questo donarsi che è grande amore, ecco – afferma Gesù – che “sono stati perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato (Hóti egápesen polý). Qui non si può dimenticare lo splendido e lapidario commento del patriarca Athenagoras: “Hóti egápesen polý. Perché lei ha molto amato. Perché Lui ha molto amato. Tutto il cristianesimo è qui”.
Poi Gesù aggiunge una frase che sembra capovolgere quella appena pronunciata: “Invece colui al quale si perdona poco, ama poco”. In realtà sono entrambe vere: colui al quale è perdonato di più ama di più e, nello stesso tempo, questa donna è perdonata perché ha molto amato. Il perdono causa l’amore ma anche l’amore causa il perdono! Sappiamo bene quante dispute esegetiche e teologiche siano sorte a partire da questa apparente contraddizione tra le due sentenze di Gesù, ma preferiamo sottolineare che ciò che è al centro dell’incontro tra Gesù e questa donna è l’amore. In ogni caso i gesti di amore della donna sono insieme indizi e cause del perdono.
Questo racconto è una testimonianza di come Gesù sapeva accogliere le donne, il loro linguaggio corporale, il loro amore così teso a discernere il suo corpo e non solo il suo insegnamento. A questa tavola chi ha incontrato Gesù e, viceversa, chi è stato da lui incontrato? Non Simone, che pure l’aveva invitato, e al quale Gesù cerca di svelare il proprio cuore, se stesso. La donna, invece, ha incontrato Gesù, ed egli l’ha incontrata fino a dichiararle: “I tuoi peccati sono stati perdonati … La tua fede ti ha salvata; prosegui il tuo cammino in pace!”. La peccatrice ha ottenuto il perdono dei suoi peccati, come Gesù le ha dichiarato, perciò si sente resa “creatura nuova” (2Cor 5,17; Gal 6,15), con una vita nuova davanti a sé. Certamente ha compreso che quell’amore che l’aveva spinta a cercare Gesù e a incontrarlo era destato proprio da Gesù e dal suo annuncio della misericordia di Dio. Per questo non è necessario che Gesù le chieda il proposito di non peccare più (cf. Gv 8,11), perché, una volta conosciuto l’amore di Gesù, il peccato non ha più la capacità di rendere schiavo il credente. Questa è la fede che ha salvato la donna, l’ha liberata dall’alienazione, l’ha rimessa in piedi e l’ha resa capace di riprendere il cammino nella pace.
Sarà forse questa donna tra quelle che stavano con Gesù, “curate da spiriti maligni e da infermità”, delle quali Luca ci parla subito dopo? Anche una donna prostituta, infatti, può diventare discepola di Gesù, perché “il peccato può diventare amore” – come scriveva Lacordaire –, essendo sempre, per gli amici del Signore, un’occasione di amore. La vera conversione non si ha quando si diventa perfetti, purissimi, ma quando il peccato diventa amore!
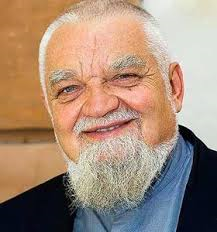




 La collera è l’altra faccia della compassione! Per questo non è possibile dimenticare le parole dure di Gesù, le sue invettive, i suoi atteggiamenti verso alcune situazioni e a volte anche verso gli stessi discepoli. La minaccia, l’invettiva deve essere detta, se è pronunciata come avvertimento urgente e forte, non come giudizio di condanna! Nel vangelo secondo Marco troviamo innanzitutto il verbo orghízomai, andare in collera, che appare come sentimento di Gesù alla vista del lebbroso (cf. Mc 1,41). Perché Gesù è preso da collera di fronte al lebbroso? Perché sente in sé sdegno di fronte a quel malato emarginato. Nella compassione che sale dalle sue viscere c’è anche questo sentimento di sdegno, che grida: “Non è giusto! Perché?”. Questa è santa collera che protesta di fronte alla sofferenza degli uomini concreti incontrati da Gesù. Ma la collera di Gesù si manifesta anche verso i “giusti incalliti”, i pretesi osservanti della Legge. Quando, entrato di sabato nella sinagoga, guarisce un uomo con la mano paralizzata, i farisei lo osservano per poterlo accusare di trasgressione della Torah (cf. Mc 3,1-4). E Gesù “volgendo su di loro uno sguardo di collera (orghé), rattristato per la durezza dei loro cuori…” (Mc 3,5). Qui lo sdegno e l’ira si leggono nello sguardo di Gesù: uno sguardo che discerne e avverte severamente quei presunti sani, quei presunti giusti! Tutti ricordiamo inoltre come Gesù agì dopo l’ingresso trionfale in Gerusalemme. Salito a Gerusalemme, Gesù trova nel tempio ciò che non doveva esservi: vede la dimora di Dio trasformata in una casa di commercio. Allora “avendo fatto una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i tavoli” (Gv 2,15). Qui c’è sdegno, collera manifestata in azioni che non sono violente verso le persone ma provocano un danno economico, un impedimento al commercio praticato nel tempio. Solitamente se si ricorda questa azione di Gesù è solo per dire che egli era violento e non mite. No, Gesù non cede alla violenza, non fa violenza sulle persone, ma compie un gesto profetico carico di significato, e lo fa con sdegno e collera.
La collera è l’altra faccia della compassione! Per questo non è possibile dimenticare le parole dure di Gesù, le sue invettive, i suoi atteggiamenti verso alcune situazioni e a volte anche verso gli stessi discepoli. La minaccia, l’invettiva deve essere detta, se è pronunciata come avvertimento urgente e forte, non come giudizio di condanna! Nel vangelo secondo Marco troviamo innanzitutto il verbo orghízomai, andare in collera, che appare come sentimento di Gesù alla vista del lebbroso (cf. Mc 1,41). Perché Gesù è preso da collera di fronte al lebbroso? Perché sente in sé sdegno di fronte a quel malato emarginato. Nella compassione che sale dalle sue viscere c’è anche questo sentimento di sdegno, che grida: “Non è giusto! Perché?”. Questa è santa collera che protesta di fronte alla sofferenza degli uomini concreti incontrati da Gesù. Ma la collera di Gesù si manifesta anche verso i “giusti incalliti”, i pretesi osservanti della Legge. Quando, entrato di sabato nella sinagoga, guarisce un uomo con la mano paralizzata, i farisei lo osservano per poterlo accusare di trasgressione della Torah (cf. Mc 3,1-4). E Gesù “volgendo su di loro uno sguardo di collera (orghé), rattristato per la durezza dei loro cuori…” (Mc 3,5). Qui lo sdegno e l’ira si leggono nello sguardo di Gesù: uno sguardo che discerne e avverte severamente quei presunti sani, quei presunti giusti! Tutti ricordiamo inoltre come Gesù agì dopo l’ingresso trionfale in Gerusalemme. Salito a Gerusalemme, Gesù trova nel tempio ciò che non doveva esservi: vede la dimora di Dio trasformata in una casa di commercio. Allora “avendo fatto una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i tavoli” (Gv 2,15). Qui c’è sdegno, collera manifestata in azioni che non sono violente verso le persone ma provocano un danno economico, un impedimento al commercio praticato nel tempio. Solitamente se si ricorda questa azione di Gesù è solo per dire che egli era violento e non mite. No, Gesù non cede alla violenza, non fa violenza sulle persone, ma compie un gesto profetico carico di significato, e lo fa con sdegno e collera.  Infine, conosciamo bene le invettive, il “Guai a voi!” ripetuto sette volte nei confronti degli scribi e farisei ipocriti (cf. Mt 23,13-32), parole il cui sdegno è stato ben interpretato dal film di Pasolini, quando ci presenta Gesù che grida con forza, parole taglienti che spogliano le autorità religiose degli orpelli del loro potere per mostrarli quali sono veramente, nella loro qualità malefica! Dunque sdegno, collera, ira erano presenti in Gesù, a testimonianza della sua fede convinta, della sua passione per la giustizia, della sua urgente parola profetica che voleva tenere svegli, non lasciare che gli altri si addormentassero, ammonirli finché c’era tempo. Purtroppo questo Gesù oggi viene censurato da generazioni di credenti che non amano il conflitto, che temono la voce alta, che rifuggono l’urgenza del sì o del no. Sono convinto che, se oggi Gesù tornasse, molti cristiani, soprattutto monaci e monache, non lo seguirebbero, perché lo riterrebbero troppo duro, troppo esigente, non sufficientemente mite e dolce: non hanno colpe, perché non conoscono l’amore e la sua passione forte come la morte, tenace come l’inferno (cf. Ct 8,6).
Infine, conosciamo bene le invettive, il “Guai a voi!” ripetuto sette volte nei confronti degli scribi e farisei ipocriti (cf. Mt 23,13-32), parole il cui sdegno è stato ben interpretato dal film di Pasolini, quando ci presenta Gesù che grida con forza, parole taglienti che spogliano le autorità religiose degli orpelli del loro potere per mostrarli quali sono veramente, nella loro qualità malefica! Dunque sdegno, collera, ira erano presenti in Gesù, a testimonianza della sua fede convinta, della sua passione per la giustizia, della sua urgente parola profetica che voleva tenere svegli, non lasciare che gli altri si addormentassero, ammonirli finché c’era tempo. Purtroppo questo Gesù oggi viene censurato da generazioni di credenti che non amano il conflitto, che temono la voce alta, che rifuggono l’urgenza del sì o del no. Sono convinto che, se oggi Gesù tornasse, molti cristiani, soprattutto monaci e monache, non lo seguirebbero, perché lo riterrebbero troppo duro, troppo esigente, non sufficientemente mite e dolce: non hanno colpe, perché non conoscono l’amore e la sua passione forte come la morte, tenace come l’inferno (cf. Ct 8,6).




