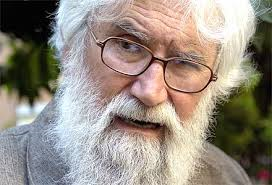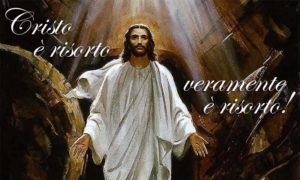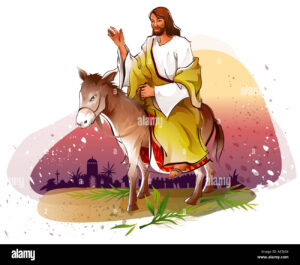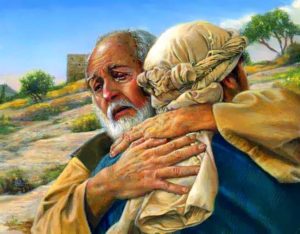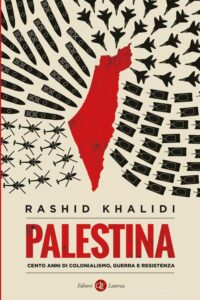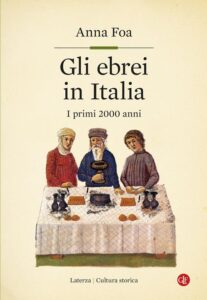lo strazio dei bambini lasciati morire di fame
di Caterina Soffici
Rahaf Ayad riesce a malapena a parlare e a muovere braccia e gambe. Le cadono i capelli, ha le
costole sporgenti, crampi e dolori in tutto il corpo, sbatte le palpebre lentamente. Rahaf è una
bambina di dodici anni e questi sono i sintomi di chi sta morendo di fame. A Gaza i bambini
muoiono di fame. Siwar Ashour, è nata a novembre, ha conosciuto solo la guerra. Ora ha sei mesi e
sua mamma Najwa Aram ha 23 anni. L’ha partorita nell’unica stanza rimasta di una casa distrutta,
dove vivono in 11. La foto di Najwa ci appare oggi sui telefonini, è diventata virale, come si dice.
Ha fatto il giro del mondo, crea scandalo e indignazione. Per quanto? Un giorno? Poi ce ne
dimenticheremo e scrolleremo altre immagini e altre storie.
Non si possono vedere i bambini morire di fame. Le organizzazioni umanitarie dicono che sono
70mila a rischio. Le storie di Rahaf e di Siwar sono due tra le tante. In verità due delle poche che ci
arrivano da Gaza, perché Israele ha sigillato la Striscia e da due mesi non entra un chicco di grano.
Sono storie che parlando di aiuti umanitari sequestrati, 5mila camion dell’Unrwa bloccati. Storie che
raccontano di un sacco di farina da 25 chili che prima della guerra costava 8 dollari e 30 centesimi e
oggi ne costa 416. Ma tanto nessuno ha più soldi e di farina non ce n’è. Così i bambini hanno
crampi allo stomaco e Rahaf dice che si sente il corpo bruciare dall’interno e chiede disperatamente
un pezzo di pollo, un uovo. Ma non c’è pollo e non ci sono uova. Non c’è più niente. Non ci sono
neanche gli ospedali dove andare a morire e i medici spiegano che morire di fame significa avere il
sangue avvelenato, insufficienza renale, danni al fegato, infezioni batteriche e microbiche e
l’immunità che cala a zero. Questo è quello che sta accadendo.
E quindi smettiamola di parlare di guerra in maniera generica. Che quando parliamo di guerra
pensiamo ai soldati, alle armi e ai droni. I professionisti e la geopolitica non ci raccontano di
bambini che muoiono di fame. E qui invece vogliamo parlare di bambini che muoiono sotto gli
occhi impotenti dei genitori.
I bambini non ci devono entrare. E quindi chiamiamo le cose con il loro nome. Quello in atto a
Gaza è un assedio che sta provocando una carestia. Assedio e carestia, due parole antiche, che
vengono direttamente dalla Bibbia. Le parole cambiano la narrazione. La carestia è fame, la fame è
un killer silenzioso, non fa rumore come una bomba, ma uccide lo stesso e Israele sta usando la
fame come un’arma. L’uso della fame come metodo di guerra è un crimine di guerra secondo il
diritto internazionale. È proibito dalla Convenzione di Ginevra e da tutti protocolli. Anche il
mandato di arresto del Tribunale penale internazionale per Benjamin Netanyahu (emesso lo scorso
anno) cita tra le accuse di usare la fame come metodo di guerra, ma Israele nega che ci sia un
problema di carestia, che c’è cibo a sufficienza nella Striscia, che acqua e farina non mancano. Il
piano sarebbe quello di “militarizzare” il controllo degli aiuti, facendoli filtrare a piacimento, perché
non finiscano nella mani di Hamas. È il fallimento ultimo di qualsiasi politica umanitaria, del
concetto stesso di aiuto umanitario, che deve essere imparziale e raggiungere chi ne ha bisogno, a
prescindere da qualsiasi altra considerazione. Rappresenta un valore etico che non dovrebbe essere
mai violato. Ma le convenzioni tra popoli civili e il diritto non sembrano avere più alcun peso.
Quanto pesa una lacrima? si domandava in una poesia Gianni Rodari. “La lacrima di un bambino
capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la Terra”.