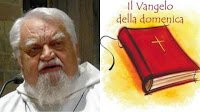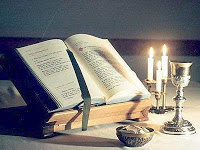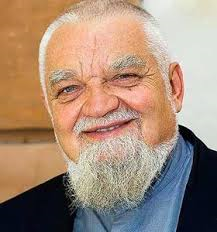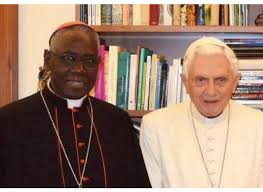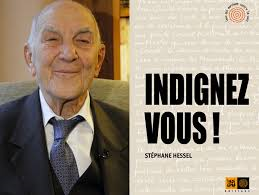“Il capitalismo non è un’idea, è una malattia che ci è passata nelle cellule”
Boris Pahor

105 anni autore di “Necropoli”
lancia il suo manifesto contro la dittatura del denaro e aggiunge:
«Per essere di sinistra non serve fare la rivoluzione, basta ascoltare il popolo. È ora di ribellarsi»
di Marco Pacini
«Quello che mi preoccupa di più è che non vedo una rivolta contro il capitalismo. Dove ci sta portando il capitalismo? Non posso lasciare fuori questa domanda. La crisi, le crisi che stiamo vivendo non sono nate dalla gente semplice, ma dalla vittoria del denaro su tutto e tutti. Stéphane Hessel, che è stato in campo di concentramento con me, scrisse “Indignatevi!”.
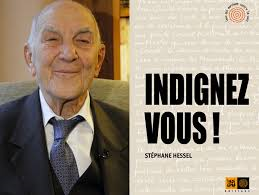
Ma io non vedo più nemmeno questo: vedo piccoli fuochi, proteste, frustrazione… ma non la rivolta morale contro il capitalismo. Viviamo in una società egoista, che fa schifo; il capitalismo non è un’idea, è una malattia che ci è passata nelle cellule, glielo dice un anticomunista»
È come un grido questo congedo di Boris Pahor, dopo oltre un’ora di colloquio. Nonostante il sillabare lento, il tono basso della voce, come può esserlo quello di un uomo che il prossimo agosto compirà 106 anni. Che ha attraversato il buio del Novecento raccontandolo in migliaia di pagine. Soprattutto in “Necropoli”, il capolavoro che ha preso forma nel campo di concentramento nazista di Natzweiler-Struthof e che l’Italia ha scoperto nel 2008, con quasi 40 anni di ritardo da quando fu pubblicato per la prima volta, in sloveno.
«Necropoli riesce a fondere l’assoluto dell’orrore con la complessità della storia», scrisse Claudio Magris nell’introduzione alla prima edizione italiana (fatta eccezione per un una piccola traduzione apparsa nel ’97 con diffusione locale) dell’opera. E con la complessità della storia, con il dovere della memoria, Boris Pahor continua il suo corpo a corpo quotidiano. Lavora ancora lo scrittore della minoranza slovena di Trieste, più volte candidato al Nobel. Qualche pagina al giorno.
Nel tinello, su un piccolo tavolo c’è una vecchia macchina da scrivere, una Remington Deluxe, con un foglio infilato che attende l’inchiostro. «L’ho acquistata a Lubiana tanto tempo fa. L’ho fatta pulire bene, vede? Batte forte… La uso da 40 anni».
In veranda ci sono dei panni appena stesi dalla badante con cui Boris Pahor parla solo in sloveno. Tra i panni si intravede l’azzurro. Chiediamo di uscire. Là sotto c’è il golfo di Trieste: la vista spazia da Pirano, gioiello veneziano incastonato nella piccola fetta di Istria slovena, al castello di Miramare. La Storia in uno sguardo, da questa villetta sul Carso: la Serenissima, gli Asburgo, la Resistenza, la pulizia etnica e linguistica dei fascisti in quest’altopiano slavofono di pietre e boscaglia, le leggi razziali annunciate laggiù a sinistra, tra quei palazzi imperiali un po’ sfuocati da qui, in piazza Unità. L’Italia in attesa fino al 1954, quando finisce l’amministrazione alleata, la cortina di ferro, il confine del “nostro mondo” che passava qui, qualche centinaio di metri più su.
Al numero di cellulare aveva risposto lui, che a 105 anni fa ancora il segretario di se stesso.
«Chi? Ah, l’Espresso? Venga, venga a trovarmi, ma io i 105 anni li ho compiuti ad agosto… di cosa vuole parlare?».
Della storia professore, di quella che stiamo vivendo, e di quella che si annuncia. Del passato, del Novecento, lei forse ha già detto e scritto tutto…
«Molto, forse. O forse non abbastanza, visto che voi giornalisti in Italia non vi siete mai occupati veramente della comunità slovena di Trieste… Noi eravamo la pietra dello scandalo, sa. L’Italia voleva Trieste ma noi triestini sloveni eravamo qui da secoli… Eravamo una comunità culturale forte. Poi è arrivato il fascismo e ci hanno caricati sui treni. In Francia conoscono la nostra storia, nelle scuole italiane non se ne è mai parlato».
E sarebbe più che mai necessario, al risorgere dei nazionalismi, di nostalgie di regime…
«La memoria non è necessaria, è indispensabile. Ma quando si parla di nazionalismo io distinguo. Finché c’era l’Unione sovietica anche l’Europa aveva costretto i popoli alla sottomissione. Appena è crollata l’Urss i popoli hanno cominciato a respirare, a sentirsi liberi».
Ci sono nazionalismi buoni e cattivi? È questo che sta dicendo, professore?
«Senta, le faccio un esempio: i poeti e gli scrittori classici sloveni sono fioriti sotto l’impero austro-ungarico. Li lasciavano fare, non erano oppressi, era un nazionalismo onesto… Poi arrivano il fascismo e il nazismo, e oggi spuntano funghi velenosi qua e là. Ma io sono un disgraziato, ho visto i campi di concentramento e dopo questo non vedo nulla di simile all’orizzonte».
Insomma i “funghi velenosi” non prenderanno il sopravvento?
«Questo dipenderà… Se rinascerà una sinistra più persuasiva resteranno fenomeni isolati e probabilmente non duraturi. Per il momento la sinistra è andata a ramengo, ovunque. Per essere di sinistra non serve essere rivoluzionari: sarebbe stato sufficiente ascoltare il popolo. Invece non sono riusciti a proporre nulla, a costruire uno scenario di sinistra senza comunismo che potesse convincere il popolo. Dire questo non è populismo. Bastava essere di sinistra “a metà” invece di inseguire la destra. E se insegui la destra, se costruisci un modello sociale fatto solo di arrivismo, se non riesci a trovare punti di mediazione e vivi di contrasti interni… beh, allora vince la destra, è ovvio».
Le cronache, e non da oggi, raccontano di un razzismo che rialza la testa, in molti luoghi d’Europa. E in Italia.
«Io sono al limite delle mie forze… questo forse mi induce a non voler vedere? Non credo sia così. Nella società europea in generale non vedo ancora spinte così forti verso il razzismo. Certo i bulbi per una a rinascita di questo fenomeno ci sono ma sono minoranze e io ho visto altro… e come le dicevo sono al limite delle mie forze».
Lei è stato definito nazionalista da una parte della sinistra della Slovenia, poi c’è stato l’episodio di quel sindaco di colore nella cittadina slovena di Pirano e qualcuno le ha dato anche del razzista, quando lei fece intendere di non aver gradito quell’elezione. O almeno così fu interpretato …
«È stato un gigantesco malinteso. Io mi sono incontrato con quel sindaco e mi ha detto: “Forse sono l’unico che ha capito quello che lei voleva dire”».
E che cosa aveva capito?
«Che la memoria, la storia di un luogo, contano. Il che non vuol dire che in loro nome non si debba accogliere. Lui mi disse “vengo dall’Africa e ci sono legato, quello resta il mio essere. Ora sono qui e provo a fare del mio meglio”. Io avevo solo detto che non poteva conoscere, sentire profondamente la storia di Pirano, non che non potesse essere un buon sindaco. Ecco, era tutto qui».
La memoria, la storia…
«Purtroppo siamo senza memoria, senza storia. E quando accade questo tutto viene rimesso in discussione, libertà compresa. Anche gli sloveni hanno interpretato la libertà in modo sbagliato e hanno cominciato presto e rubare».
Ha votato alle ultime elezioni politiche?
«No, non ho seguito le elezioni italiane. Noi della minoranza slovena votavamo sempre con la sinistra, ma vista la malaparata della sinistra italiana mi sono disinteressato. Del resto nemmeno in Slovenia avrei votato la sinistra. Quale sinistra?».
Provi a immaginarne una
«E come? Come si fa a creare un governo sociale se si è completamente immersi nel credo capitalista? È la grande domanda. Sicuramente avrà sentito anche lei la favola dei cospirazionisti che racconta dei grandi capitalisti del mondo riuniti attorno a un tavolo per mettere i popoli l’uno contro l’altro con lo scopo di dominarli meglio… È una favola, naturalmente. Ma non la vediamo questa tendenza al dominio inarrestabile del capitale, del denaro?».
Professore, qualcuno potrebbe leggere queste sue parole come un’evocazione dei “poteri forti”, categoria che va per la maggiore tra i leader di questo governo.
«Questo governo? Lasciamo stare. Sto cercando di capire come pensano di rovinare ancora l’Italia. Non riesco a capire che qualità abbiano per fare questa rivolta di cui io parlo, quella necessaria. Facendo debiti invece di pagarli? Non si può governare con le illusioni. Mai».
Tornando al dominio del denaro, “inarrestabile” suona come una sentenza definitiva. Se la politica nulla può, cos’altro? Una fede? Un miracolo?
«I miracoli non esistono o può farli l’uomo… Io sono un panteista. E mi riconosco nelle parole di Einstein: “sono religioso ma non credente”. Mi inchino davanti alla natura, lo faccio ogni giorno da quando sono uscito dal campo di concentramento. Possono distruggere loro stessi gli uomini e con sé stessi questa palla che chiamiamo mondo, il nostro mondo. Uno mi può dire: ma cosa te ne importa che tu fra poco sarai sottoterra? Dico che me ne importa perché c’è gente che vive, gente che nasce. Pensare a questo è un vivere onesto. La natura è senza coscienza, ma noi ce l’abbiamo, o dovremmo averla».
Che cosa significa “i miracoli può farli l’uomo”?
«Io ricordo noi dei “triangoli rossi”… gli internati politici nei campi di lavoro nazisti. Un pezzo di pane, una minestra di rape, nient’altro. Ho preso la tisi, dovevamo morire come tutti gli altri: gli ebrei gli zingari… Sono qui».
In questo mondo che non le piace.
«Ma potrebbe. Una sola cosa ci vuole: non il tavolo dei capitalisti che tengono in pugno il mondo come nella favola (ma neanche tanto) dei cospirazionisti. Ci vuole un altro tavolo, un incontro universale per l’uomo e la sua sopravvivenza. Durerà un giorno? Un anno? Dieci anni? Non importa. Dobbiamo cercare uno scopo per l’uomo finalmente, interrompere una storia che da Alessandro Magno a Hitler ha significato sterminio. Un incontro universale tra medici, poeti, ingeneri, religiosi… Mi si dice che è un’utopia? Se un uomo è capace di fare “miracoli” come quelli che ogni giorno ci fanno vedere le tecnologie, perché non è in grado di fare questo? Una ricerca per l’uomo, per vivere con senso una vita diversa da quella dell’avere, del conquistare. Nessuno che si chiami uomo resti senza pane. Si può. Solo così l’umanità della grande innovazione avrà creato qualcosa di Nuovo».
Lei è uno scrittore. Che contributo può dare la letteratura, se può darlo, a questa “innovazione”?
«La letteratura vale dove c’è già disposizione di spirito. Vale quando c’è chi accetta, è all’altezza, per ricevere questa ricchezza. Ma che con la letteratura si possa innescare questa rivoluzione morale, intellettuale, psicologica… non ci credo. Altrimenti ci sarebbe riuscito il cristianesimo».
Come trascorre le sue giornate?
«Ho molti incontri, vengono a trovarmi. Ho una biblioteca a Prosecco dove ho messo quasi tutti i libri. Porto lì chi viene a trovarmi, e parliamo. Poi scrivo ancora qualche paginetta. Leggo, possibilmente in lingua originale… Mi sono appena riletto “Vita di Gesù” di Renan».
C’è ancora il tempo per un caffè, che si raffredda nella tazza mentre Boris Pahor ha un’ultima parola da aggiungere:
‘rivolta’