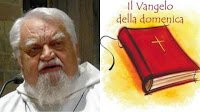MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
17 novembre 2019

La speranza dei poveri non sarà mai delusa
1. «La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita.
Il Salmista descrive la condizione del povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità (cfr 10, 14-15). Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda che si rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Come può permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Perché consente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero?
Nel momento della composizione di questo Salmo si era in presenza di un grande sviluppo economico che, come spesso accade, giunse anche a produrre forti squilibri sociali. La sperequazione generò un numeroso gruppo di indigenti, la cui condizione appariva ancor più drammatica se confrontata con la ricchezza raggiunta da pochi privilegiati. L’autore sacro, osservando questa situazione, dipinge un quadro tanto realistico quanto veritiero.
Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri per impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non è molto diverso oggi. La crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano l’ingente numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono vessati e sfruttati. Tornano alla mente le parole dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo» (Ap 3,17). Passano i secoli ma la condizione di ricchi e poveri permane immutata, come se l’esperienza della storia non insegnasse nulla. Le parole del Salmo, dunque, non riguardano il passato, ma il nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio.
2. Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini.
Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città?
Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri.
Dramma nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, un affetto… Ogni eventuale possibilità offerta, diventa uno spiraglio di luce; eppure, anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia, spesso si infierisce su di loro con la violenza del sopruso. Sono costretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i frutti della stagione, ma sono ricompensati con una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né condizioni umane che permettano di sentirsi uguali agli altri. Non esiste per loro cassa integrazione, indennità, nemmeno la possibilità di ammalarsi.
Il Salmista descrive con crudo realismo l’atteggiamento dei ricchi che depredano i poveri: “Stanno in agguato per ghermire il povero…attirandolo nella rete” (cfr Sal 10,9). È come se per loro si trattasse di una battuta di caccia, dove i poveri sono braccati, presi e resi schiavi. In una condizione come questa il cuore di tanti si chiude, e il desiderio di diventare invisibili prende il sopravvento. Insomma, riconosciamo una moltitudine di poveri spesso trattati con retorica e sopportati con fastidio. Diventano come trasparenti e la loro voce non ha più forza né consistenza nella società. Uomini e donne sempre più estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i nostri quartieri.
3. Il contesto che il Salmo descrive si colora di tristezza, per l’ingiustizia, la sofferenza e l’amarezza che colpisce i poveri. Nonostante questo, offre una bella definizione del povero. Egli è colui che “confida nel Signore” (cfr v. 11), perché ha la certezza di non essere mai abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è l’uomo della fiducia! L’autore sacro offre anche il motivo di tale fiducia: egli “conosce il suo Signore” (cfribid.), e nel linguaggio biblico questo “conoscere” indica un rapporto personale di affetto e di amore.
Siamo dinanzi a una descrizione davvero impressionante che non ci aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia, non fa che esprimere la grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un povero. La sua forza creatrice supera ogni aspettativa umana e si rende concreta nel “ricordo” che egli ha di quella persona concreta (cfr v. 13). È proprio questa confidenza nel Signore, questa certezza di non essere abbandonato, che richiama alla speranza. Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; perciò vive sempre alla presenza di quel Dio che si ricorda di lui. Il suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza per delineare un cammino di liberazione che trasforma il cuore, perché lo sostiene nel più profondo.
4. È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. Egli è colui che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”… Insomma, un povero non potrà mai trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende giustizia e non dimentica (cfr Sal 40,18; 70,6); anzi, è per lui un rifugio e non manca di venire in suo aiuto (cfr Sal 10,14).
Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il “giorno del Signore”, come descritto dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà l’arroganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di emarginazione in cui sono vessati milioni di persone non potrà durare ancora a lungo. Il loro grido aumenta e abbraccia la terra intera. Come scriveva Don Primo Mazzolari: «Il povero è una protesta continua contro le nostre ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le dai fuoco, il mondo salta».
5. Non è mai possibile eludere il pressante richiamo che la Sacra Scrittura affida ai poveri. Dovunque si volga lo sguardo, la Parola di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere perché dipendono dagli altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole schiera di indigenti, Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Sfuggire da questa identificazione equivale a mistificare il Vangelo e annacquare la rivelazione. Il Dio che Gesù ha voluto rivelare è questo: un Padre generoso, misericordioso, inesauribile nella sua bontà e grazia, che dona speranza soprattutto a quanti sono delusi e privi di futuro.
Come non evidenziare che le Beatitudini, con le quali Gesù ha inaugurato la predicazione del regno di Dio, si aprono con questa espressione: «Beati voi, poveri» (Lc 6,20)? Il senso di questo annuncio paradossale è che proprio ai poveri appartiene il Regno di Dio, perché sono nella condizione di riceverlo. Quanti poveri incontriamo ogni giorno! Sembra a volte che il passare del tempo e le conquiste di civiltà aumentino il loro numero piuttosto che diminuirlo. Passano i secoli, e quella beatitudine evangelica appare sempre più paradossale; i poveri sono sempre più poveri, e oggi lo sono ancora di più. Eppure Gesù, che ha inaugurato il suo Regno ponendo i poveri al centro, vuole dirci proprio questo: Lui ha inaugurato, ma ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito di portarlo avanti, con la responsabilità di dare speranza ai poveri. È necessario, soprattutto in un periodo come il nostro, rianimare la speranza e restituire fiducia. È un programma che la comunità cristiana non può sottovalutare. Ne va della credibilità del nostro annuncio e della testimonianza dei cristiani.
6. Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona in un servizio che è autentica evangelizzazione. La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 183).
Recentemente abbiamo pianto la morte di un grande apostolo dei poveri, Jean Vanier, che con la sua dedizione ha aperto nuove vie alla condivisione promozionale con le persone emarginate. Jean Vanier ha ricevuto da Dio il dono di dedicare tutta la sua vita ai fratelli con gravi disabilità che spesso la società tende ad escludere. È stato un “santo della porta accanto” alla nostra; con il suo entusiasmo ha saputo raccogliere intorno a sé tanti giovani, uomini e donne, che con impegno quotidiano hanno dato amore e restituito il sorriso a tante persone deboli e fragili offrendo loro una vera “arca” di salvezza contro l’emarginazione e la solitudine. Questa sua testimonianza ha cambiato la vita di tante persone e ha aiutato il mondo a guardare con occhi diversi alle persone più fragili e deboli. Il grido dei poveri è stato ascoltato e ha prodotto una speranza incrollabile, creando segni visibili e tangibili di un amore concreto che fino ad oggi possiamo toccare con mano.
7. «L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via» (ibid., 195) è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in essi la sua verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze con l’amore di Cristo riceve forza e conferisce vigore all’annuncio del Vangelo.
L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio. «Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione» (ibid., 199) per i poveri nella ricerca del loro vero bene. Non è facile essere testimoni della speranza cristiana nel contesto della cultura consumistica e dello scarto, sempre tesa ad accrescere un benessere superficiale ed effimero. È necessario un cambiamento di mentalità per riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio.
La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati per aver concesso loro un po’ del nostro tempo, ma quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa.
8. A tanti volontari, ai quali va spesso il merito di aver intuito per primi l’importanza di questa attenzione ai poveri, chiedo di crescere nella loro dedizione. Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno. Mettiamo da parte le divisioni che provengono da visioni ideologiche o politiche, fissiamo lo sguardo sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano tesa. Non dimenticate mai che «la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (ibid., 200).
I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente.
9. A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.
Agli occhi del mondo appare irragionevole pensare che la povertà e l’indigenza possano avere una forza salvifica; eppure, è quanto insegna l’Apostolo quando dice: «Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor 1,26-29). Con gli occhi umani non si riesce a vedere questa forza salvifica; con gli occhi della fede, invece, la si vede all’opera e la si sperimenta in prima persona. Nel cuore del Popolo di Dio in cammino pulsa questa forza salvifica che non esclude nessuno e tutti coinvolge in un reale pellegrinaggio di conversione per riconoscere i poveri e amarli.
10. Il Signore non abbandona chi lo cerca e quanti lo invocano; «non dimentica il grido dei poveri» (Sal 9,13), perché le sue orecchie sono attente alla loro voce. La speranza del povero sfida le varie condizioni di morte, perché egli sa di essere particolarmente amato da Dio e così vince sulla sofferenza e l’esclusione. La sua condizione di povertà non gli toglie la dignità che ha ricevuto dal Creatore; egli vive nella certezza che gli sarà restituita pienamente da Dio stesso, il quale non è indifferente alla sorte dei suoi figli più deboli, al contrario, vede i loro affanni e dolori e li prende nelle sue mani, e dà loro forza e coraggio (cfr Sal 10,14). La speranza del povero si fa forte della certezza di essere accolto dal Signore, di trovare in lui giustizia vera, di essere rafforzato nel cuore per continuare ad amare (cfr Sal 10,17).
La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, è di seminare segni tangibili di speranza. A tutte le comunità cristiane e a quanti sentono l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. Ci accompagnino le parole del profeta che annuncia un futuro diverso: «Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20).
Dal Vaticano, 13 giugno 2019
Memoria liturgica di S. Antonio di Padova
Francesco


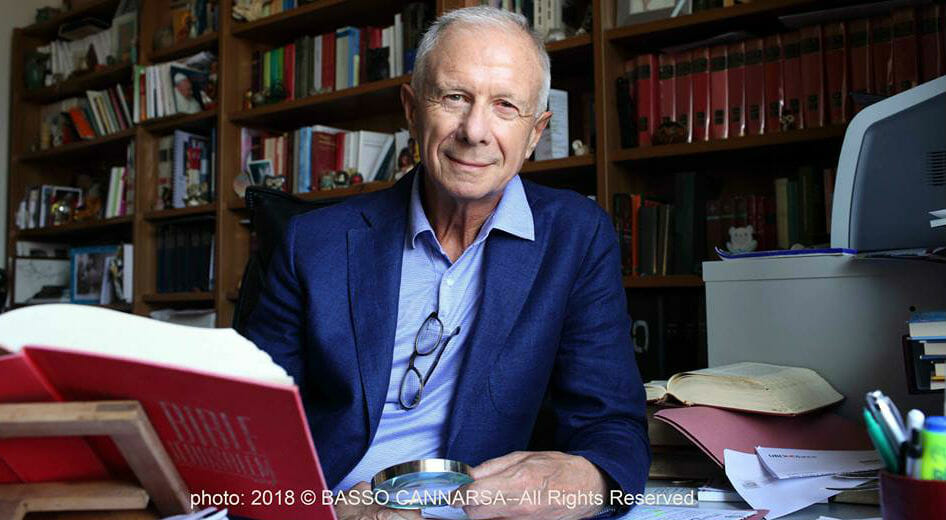
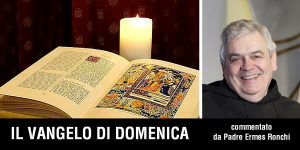






 “Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”
“Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”