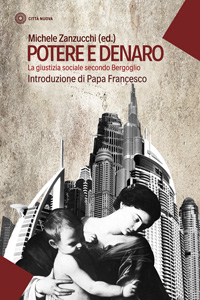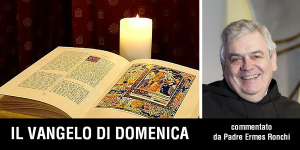La giustizia sociale secondo Jorge Mario Bergoglio
Ne indica i fondamentali e la descrive Michele Zanzucchi nel volume «Potere e denaro» che esce oggi in libreria. Il libro si apre con la prefazione di papa Francesco – pubblicata qui sotto – e propone una raccolta ragionata e fluida di quanto il Pontefice argentino ha detto e scritto su ricchezza e povertà, giustizia e ingiustizia sociale, cura e disprezzo del Creato, finanza sana e perversa, imprenditori e speculatori, sindacati e movimenti popolari, “mammona” e culto del “dio denaro”. La sua è una denuncia forte e decisa della speculazione finanziaria, delle rendite che accentuano la distanza tra ricchi e poveri, della meritocrazia che schiaccia i piccoli, della globalizzazione che crea nuovi scarti e nuove schiavitù, del commercio delle armi e delle guerre che esso provoca. Ma, in spirito evangelico, come papa Francesco scrive nella prefazione, non dobbiamo perdere la speranza.
Zanzucchi è giornalista e scrittore; ha diretto la rivista “Città Nuova” e collabora con “Avvenire”. Ha pubblicato una quarantina di libri tra cui «L’islam spiegato a chi ha paura dei musulmani» (2015) e «Il silenzio e la parola. La luce» (2013). Vive in Libano e insegna giornalismo e linguaggi del giornalismo alla Pontificia Università Gregoriana e massmediologia all’Istituto Universitario “Sophia” di Loppiano, la cittadella del Movimento dei Focolari in provincia di Firenze.
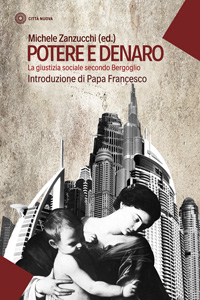
Prima da semplice cristiano, poi da religioso e sacerdote, quindi da Papa, ritengo che le questioni sociali ed economiche non possano essere estranee al messaggio del Vangelo. Perciò, sulla scia dei miei predecessori, cerco di mettermi in ascolto degli attori presenti sulla scena mondiale, dai lavoratori agli imprenditori, ai politici, dando voce, in particolare, ai poveri, agli scartati, a chi soffre. La Chiesa, nel diffondere il messaggio di carità e giustizia del Vangelo, non può rimanere silente di fronte all’ingiustizia e alla sofferenza. Ella può e vuole unirsi ai milioni di uomini e donne che dicono no all’ingiustizia in modo pacifico, adoperandosi per una maggiore equità. Ovunque c’è gente che dice sì alla vita, alla giustizia, alla legalità, alla solidarietà. Tanti incontri mi confermano che il Vangelo non è un’utopia ma una speranza reale, anche per l’economia: Dio non abbandona le sue creature in balia del male. Al contrario, le invita a non stancarsi nel collaborare con tutti per il bene comune.
Quanto dico e scrivo sul potere dell’economia e della finanza vuol essere un appello affinché i poveri siano trattati meglio e le ingiustizie diminuiscano. In particolare, costantemente chiedo che si smetta di lucrare sulle armi col rischio di scatenare guerre che, oltre ai morti e ai poveri, aumentano solo i fondi di pochi, fondi spesso impersonali e maggiori dei bilanci degli Stati che li ospitano, fondi che prosperano nel sangue innocente. Nei miei messaggi in materia economica e sociale desidero sollecitare le coscienze, soprattutto di chi specula e sfrutta il prossimo, perché si ritrovi il senso dell’umanità e della giustizia. Per questo non posso non denunciare col Vangelo in mano i peccati personali e sociali commessi contro Dio e contro il prossimo in nome del dio denaro e del potere fine a se stesso. Mi esprimo con sollecitudine anche perché sono cosciente che altre crisi economiche mondiali non sono impossibili. Quando si verifica il crollo di una finanza staccata dall’economia reale, tanti pagano le conseguenze e tra i tanti soprattutto i poveri e quanti poveri diventano, mentre i ricchi in un modo o nell’altro spesso se la cavano.
Che cosa fare? Una cosa che mi sembra importante è coscientizzare sulla gravità dei problemi. È quanto fa Michele Zanzucchi raccogliendo, sistematizzando e rendendo fruibili ai lettori delle sintesi di alcuni miei pensieri sul potere dell’economia e della finanza. Spero che ciò possa essere utile a coscientizzare e a responsabilizzare, favorendo processi di giustizia e di equità. Non basta un po’ di balsamo per sanare le ferite di una società che tratta spesso tutti e tutto come merce, merce che, quando diventa inutile, viene gettata via, secondo quella cultura dello scarto di cui tante volte ho parlato. Solo una cultura che valorizzi tutte le risorse a disposizione della società, ma in primo luogo quelle umane, può guarirne le malattie profonde. I cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati a sentirsi attori di tale cultura della valorizzazione. Coscientizzare e valorizzare dunque, ma anche rinnegare. Ci sono dei no da dire alla mentalità dello scarto: occorre evitare di uniformarsi al pensiero unico, attuando coraggiosamente delle scelte buone e controcorrente. Tutti, come insegna la Scrittura, possono ravvedersi, convertirsi, diventare testimoni e profeti di un mondo più giusto e solidale.
Tanti, tantissimi uomini e donne di ogni età e latitudine sono già arruolati in un inerme “esercito del bene”, che non ha altre armi se non la passione per la giustizia, il rispetto della legalità e l’intelligenza della comunione. È troppo pensare di introdurre nel linguaggio dell’economia e della finanza, della cooperazione internazionale e del lavoro tale parola, comunione, declinandola come cura degli altri e della casa comune, solidarietà effettiva, collaborazione reale e cultura del dono? Il bene non è quietismo e non porta a essere remissivi. L’arte di amare, unico manuale d’uso dell’esercito del bene, comporta al contrario l’essere attivi, richiede la capacità di coinvolgersi per primi, di non stancarsi di cercare l’incontro, di accettare qualche sacrificio per sé e di avere tanta pazienza con tutti per stabilire una migliore reciprocità. I tre attributi che tradizionalmente spettano al livello più alto a Dio sono il vero, il buono e il bello. Non a caso la Chiesa parla di tre virtù teologali: la fede, la carità e la speranza. Gli esseri umani possono riscoprirsi veri, buoni e belli quanto più entrano nel circolo virtuoso di Dio, che è comunione e amore. Perciò anche in economia queste tre virtù recano benefici. È possibile: il fatto che tanti lavoratori, imprenditori e amministratori siano già al servizio della giustizia, della solidarietà e della pace ci conferma che la via della verità, della carità e della bellezza è ardua, ma praticabile e necessaria, anche in economia e finanza.
Come questo libro testimonia, il mio pensiero si situa nel cammino tracciato dal ricchissimo patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa. Chiunque può farlo proprio, anche solo accedendo a quel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa che tante volte ho citato perché in poche parole offre una panoramica del pensiero ecclesiale in materia sociale. Tra i testi da me redatti, giustamente l’autore ha privilegiato l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium e l’Enciclica Laudato si’. Al contempo non si sono potute tagliare le radici comunitarie del mio pensare, che affondano in particolare nella Chiesa dell’America Latina. Sono ad esempio debitore della grande assemblea di Aparecida, nella quale si è riproposto un metodo ai cristiani per la vita sociale: vedere, giudicare e agire. Possiamo cioè vedere la realtà che ci circonda alla luce della provvidenza di Dio; giudicarla secondo Gesù Cristo, via, verità e vita; agire di conseguenza nella Chiesa e con tutti gli uomini di buona volontà.
Il mondo creato agli occhi di Dio è cosa buona, l’essere umano cosa molto buona (cf. Gen 1, 4-31). Il peccato ha macchiato e continua a macchiare la bontà originaria, ma non può cancellare l’impronta dell’immagine di Dio presente in ogni uomo. Perciò non dobbiamo perdere la speranza: stiamo vivendo un’epoca difficile, ma piena di opportunità nuove e inedite. Non possiamo smettere di credere che, con l’aiuto di Dio e insieme – lo ripeto, insieme – si può migliorare questo nostro mondo e rianimare la speranza, la virtù forse più preziosa oggi. Se siamo insieme, uniti nel suo nome, il Signore è in mezzo a noi secondo la sua promessa (cf. Mt 18, 20); quindi è con noi anche in mezzo al mondo, nelle fabbriche, nelle aziende e nelle banche come nelle case, nelle favelas e nei campi profughi. Possiamo, dobbiamo sperare.
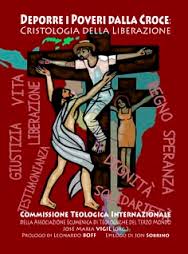




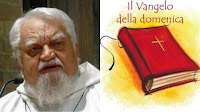




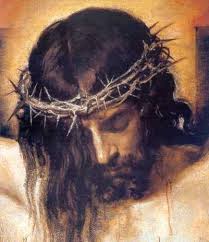 Sì, per noi è Dio e conosciamo l’abituale reazione violenta del Potere nei confronti dei dissidenti. D’altronde, per esso, è sopportabile solo un dio accondiscendente e collaborativo secondo le esigenze dell’oppressione. In caso contrario è pronto un palo verticale allestito dal Potere religioso e uno orizzontale allestito dal Potere civile: la croce delle struttura di peccato su cui inchiodare i giusti e gli indifesi. Noi rifiutiamo il Potere, preferiamo morire piuttosto che opprimere in cambio di qualche sporco vantaggio personale, desideriamo aiutare, cooperare, includere senza prevalere e comandare. Noi rifiutiamo la competizione, la logica del più forte e quella del più furbo, preferiamo perdere ma arrivare tutti insieme, evitiamo i piedistalli per non cadere, i pulpiti per non guardare dall’alto in basso, e l’unico insegnamento che riteniamo veramente indispensabile è quello di
Sì, per noi è Dio e conosciamo l’abituale reazione violenta del Potere nei confronti dei dissidenti. D’altronde, per esso, è sopportabile solo un dio accondiscendente e collaborativo secondo le esigenze dell’oppressione. In caso contrario è pronto un palo verticale allestito dal Potere religioso e uno orizzontale allestito dal Potere civile: la croce delle struttura di peccato su cui inchiodare i giusti e gli indifesi. Noi rifiutiamo il Potere, preferiamo morire piuttosto che opprimere in cambio di qualche sporco vantaggio personale, desideriamo aiutare, cooperare, includere senza prevalere e comandare. Noi rifiutiamo la competizione, la logica del più forte e quella del più furbo, preferiamo perdere ma arrivare tutti insieme, evitiamo i piedistalli per non cadere, i pulpiti per non guardare dall’alto in basso, e l’unico insegnamento che riteniamo veramente indispensabile è quello di