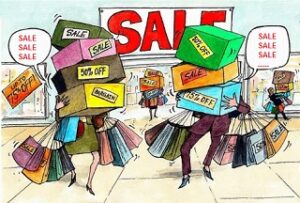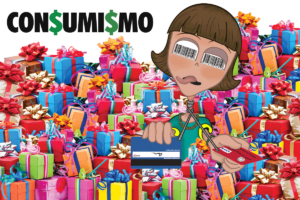«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità universale»
Con queste parole papa Francesco, nel messaggio per la 56esima Giornata mondiale della pace che ricorre l’1 gennaio, ci chiede di interrogarci sul nostro futuro e sulle nostre responsabilità. Che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? È una delle sue domande, e ci ricorda che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che «il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo».
Il Papa rende omaggio all’impegno eroico di quanti si sono spesi nell’emergenza pandemica e ragiona di alcune «scoperte positive» come un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che «ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni».
E ancora «da tale esperienza – osserva – è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali».
Non solo il Covid, ma anche la guerra, «nuova terribile sciagura», guidata però da scelte umane colpevoli viene citata più volte nel messaggio per prossima la giornata mondiale della pace. «La guerra in Ucraina – sottolinea ancora Francesco nel messaggio – miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante». E di certo, «non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate».
.jpg?width=620)
di seguito integralmente il testo del messaggio per la Giornata mondiale della pace del primo gennaio 2023
“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”
«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2).
1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie.
2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle.
Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione che non era del tutto chiara neanche dal punto di vista scientifico, il mondo della sanità si è mobilitato per lenire il dolore di tanti e per cercare di porvi rimedio; così come le Autorità politiche, che hanno dovuto adottare notevoli misure in termini di organizzazione e gestione dell’emergenza.
Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà.
Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di lavoratori informali in molte parti del mondo, rimasti senza impiego e senza alcun supporto durante tutto il periodo di confinamento.
Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario genere. In questo senso, la pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità.
3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo?
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia riposta nel progresso, nella tecnologia e negli effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è trasformata in una intossicazione individualistica e idolatrica, compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia e di pace. Nel nostro mondo che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di squilibri, ingiustizie, povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e generano violenze e anche guerre.
Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo potuto, dall’altra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi veramente eroico, di tante persone che si sono spese perché tutti potessero superare al meglio il dramma dell’emergenza.
Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali.
4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte della pandemia da Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità.
Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante.
Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, perché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23).
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune.
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace.
Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. Formulo i migliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni internazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero.




.jpg?width=1024)
.jpg?width=620)


.jpg?width=1024)