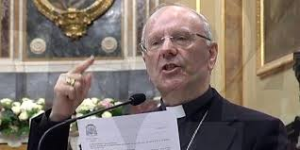la apparente ‘modernità’ della teologia di Sorrentino

la teologia (pre-conciliare) di Pio XIII
Il papa inventato da Paolo Sorrentino merita ulteriori riflessioni e approfondimenti teologici. C’è da chiedersi se questa figura fantastica e struggente, equivoca e coinvolgente, sia davvero una figura moderna. Perché è piuttosto una modernità tridentina, che in maniera spesso subliminale bussa alla porta del cristianesimo odierno, invocando un ritorno indietro verso una fede e una chiesa preconciliare e tradizionalista piuttosto che tradizionale. Ma cosa sarebbe la Chiesa cattolica senza il Vaticano II, o meglio, è possibile oggi un cattolicesimo ispirato esclusivamente alla modernità tridentina?
<!--
Prima dei discorsi “ufficiali” che il giovane papa pronunzierà, viene messo in scena un discorso onirico (I episodio) ispirato al Dio che non si dimentica di nessuno e al fatto che l’armonia con Lui passa attraverso l’armonia con la vita e l’esperienza del gioco, per concludersi sulla felicità, con una serie di passaggi decisamente e volutamente provocatori, non di rado irritanti, che lasciano la folla perplessa e sgomenta. Ed eccoci al primo drammatico discorso (II episodio) tenuto da una loggia in penombra di un pontefice che sceglie il nascondimento e rifugge l’esposizione mediatica. Il tema è la denuncia del fatto che ci siamo dimenticati di Dio. La sua assenza è frutto di questa dimenticanza. Del resto siamo nel tempo della povertà e il mondo è diventato così povero da non avvertire la mancanza di Dio come mancanza (M. Heidegger).
Il Dio dimenticato è un Dio che esige tutto e si potrà vedere il papa solo se ci si ricorderà di Dio, non c’è posto per la chiesa e il suo pontefice supremo in un mondo che ha dimenticato Dio. E bisogna essere più vicini a Dio che agli uomini, perché “tutti noi siamo soli davanti a Dio”. Non è il papa che deve provare l’esistenza di Dio, ma chi si è dimenticato di Lui a dover dimostrare la sua non esistenza. È un Dio col quale Belardo ingaggia una lotta senza pari. Del resto lo stesso Benedetto XVI, nel suo discorso ad Erfurt (stiamo ricordando i 500 anni dalla riforma) aveva detto che la teologia è “lotta con Dio”: “Per Lutero la teologia non era una questione accademica, ma la lotta interiore con se stesso, e questo, poi, era una lotta riguardo a Dio e con Dio”.
Dovremo attendere il V episodio per ascoltare il discorso ai cardinali del nuovo, giovane papa, che ha atteso il rientro della tiara dagli Stati Uniti, cui, a suo dire “incautamente” l’aveva ceduta, mettendola all’asta, Paolo VI. Il mistero di Dio si infittisce e la chiesa dovrà chiudere le sue porte, perché ritorni ad essere il luogo del mistero. Dobbiamo essere “proibiti, inaccessibili e misteriosi” e smettere di guardare al mondo che non ha nulla da dirci, perché solo la chiesa possiede la verità (citazione di Ignazio d’Antiochia). È una profonda e per nulla banale critica alla “chiesa in uscita” e alla visione del Vaticano II: evangelizzazione, ecumenismo, tolleranza non dovranno più appartenere alla chiesa, da cui è bandita la parola “compromesso”.
Nonostante l’innegabile suggestione che può suscitare, la spietata posizione, peraltro estemporanea ed anacronistica, del giovane papa finisce col rinnegare un punto di non ritorno, che il credente oggi non può ritenere alla stregua di una parentesi o di una deriva. Il look, accuratamente scelto per questa occasione e il bacio della pantofola, sembrerebbero elementi di folklore, ma rivelano un’immagine di chiesa, ispirata al senso del mistero ed estremamente esigente, perché il nuovo papa non vuole amici o simpatizzanti, ma solo innamorati. Allorché si sono riempite le piazze di folle plaudenti, i cuori sono rimasti vuoti di Dio. L’immagine della porta piccola e stretta, nonché chiusa, rappresenta simbolicamente l’ecclesiologia di Pio XIII. E il perdono non potrà mai più essere concesso ad libitum.
Le contraddizioni e i mali della chiesa sono, in forma spietata, presenti in tutta la serie, dall’omosessualità del clero alla pedofilia, dalla sovresposizione mediatica al carrierismo, dalla mondanità ai compromessi. Mali da cui non è esente la missione e l’esercizio della carità, come viene rappresentata nel viaggio in Africa e nel discorso lì pronunciato (episodio VIII). Dio è amore, ma il giovane papa non parlerà di Dio, perché chiede a gran voce la pace. Una pace bella e sconcertante, da lui stesso sperimentata in una gita sul fiume in Colorado coi suoi genitori all’età di otto anni. Datemi la pace e vi darò Dio: è questo il suo messaggio all’Africa dilaniata da conflitti e percossa da dittatori che indossano la maschera della carità. Giungiamo così all’epilogo veneziano, con l’ultimo discorso, pronunciato da piazza san Marco (X episodio).
Siamo così al filo rosso di tutta la serie: l’assenza di Dio è il riflesso dell’assenza del padre. Ma a Venezia, ispirandosi alla beata Juana e ribadendo che Dio (una “linea aperta”) non si mostra, non parla, non si fa vedere, non ci conforta, conclude col sorriso di Dio e chiede a tutti di sorridere. Ai bambini amava ripetere: “Pensate a tutte le cose che vi piacciono: quello è Dio”. Il cerchio in un certo senso si chiude perché ritorna il messaggio del discorso onirico iniziale, epurato da tutte le provocazioni morali in esso contenute. Da tutta la vicenda espressa nella serie, emerge con chiarezza l’ispirazione agostiniana adottata da Pio XIII: “se vuoi vedere Dio, hai a disposizione l’idea giusta”.
La contrapposizione delle due città, la dialettica assenza/presenza di Dio, l’amore assoluto della “terza navigazione”, espresso nelle mirabili pagine dei commenti agostiniani alle lettere di Giovanni, sono fonti certamente non secondarie di questa teologia. Potremmo concludere sottolineando la paradossalità costitutiva di questa visione, che ad esempio emerge allorché Lenny Belardo si paragona a Dio, dicendo che la sua natura è la contraddizione e rintracciandone l’immagine nelle proprie contraddizioni. Mi sono chiesto se davvero questa figura fantastica e struggente, equivoca e coinvolgente sia antiquata, lasciandomi interrogare sul fascino che ha esercitato sui giovani studenti di teologia. Mi sono risposto che si tratta di una figura moderna, della modernità tridentina, che in maniera spesso subliminale bussa alla porta del cristianesimo odierno, invocando un ritorno indietro verso una fede e una chiesa preconciliare e tradizionalista piuttosto che tradizionale.
Ma l’elemento più inquietante della teologia di Pio XIII è che quello che emerge dai suoi discorsi potrebbe rivelarsi un Dio senza Cristo, o meglio una teologia senza cristologia. Meglio ancora siamo di fronte a una cristologia sommersa, in cui si rovescia la prospettiva oggi comune nelle teologie contemporanee: non è Cristo che rivela il volto di Dio, ma la questione cruciale di Dio che dischiude il volto di un Gesù, che rimane sempre velato, come il corpo del Cristo di Giuseppe Sanmartino, presente nella cappella Sansevero di Napoli. Il crocifisso dell’immagine rovesciata con cui si risveglia e l’unico cenno al radicalismo della croce presente nell’ultimo passaggio del discorso ai cardinali, ci situano di fronte a una prospettiva teologica unilaterale e forse perdente, ma anche suggestiva e impressionante, con la domanda di fondo: cosa sarebbe la chiesa cattolica senza il Vaticano II, o meglio, è possibile oggi un cattolicesimo ispirato esclusivamente alla modernità tridentina? L’impossibilità è l’orizzonte di una fiction, che meriterebbe ulteriori approfondimenti e riflessioni.
un piccolo, minuscolo pensiero per il natale …
Il natale
è dentro di me
quando vivo
nella mia vita
“prima gli altri
poi me”.
Il natale
lo vedo
quando mi accorgo
che i miei occhi vedono
quello che altri
non vedono.
Lo sfinimento di un affamato
la disperazione di un triste
l’ingiustizia
che cerco di sanare.
Ma per vedere
il natale
bisogna morire
ogni giorno
a se stessi
non sentirsi mai
a posto
chiedere sempre
la vista.
Allora
qualcosa ‘nasce’ in me,
allora
la mia coscienza
si riposa.
Allora il natale
è il tuo stupore,
è la pace che senti.
Non capisci
da dove viene
ma ti ha avvolto
senza rumore.
il vangelo della domenica commentato da p. Maggi
SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE O DOBBIAMO ASPETTARE UN ALTRO?
commento al vangelo della terza domenica di avvento (11 dicembre 2013) di p. Alberto Maggi:
Mt 11,2-11
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
L’evangelista Matteo scrive per una comunità di Giudei, e presenta la figura di Gesù sulla falsa riga della vita e delle opere di Mosè. Mosè liberò il suo popolo, facendo scagliare da Dio le dieci piaghe, le famose dieci piaghe d’Egitto, contro chi si opponeva alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù. Ebbene, l’evangelista presenta Gesù che compie non dieci piaghe, dieci azioni di castigo contro i suoi oppositori o i suoi nemici, ma dieci opere con le quali comunica vita, e comunica vita anche ai suoi rivali, ai suoi nemici. Tutto questo sconcerta, perché l’attività di Gesù non è quella attesa, quella che era stata annunciata da Giovanni il Battista – lo ricordiamo il Messia giustiziere che ha la scure in mano, ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo getta nel fuoco, questo Messia che sarebbe venuto a dividere il popolo tra puri ed impuri, buoni e cattivi. Ed infatti, ad andare in crisi è proprio Giovanni. Leggiamo il vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 2-11. “…Giovanni, che era in carcere…”: l’evangelista dà per scontata la notizia che sia conosciuto che Giovanni è in carcere, anche se in realtà poi ce lo dirà soltanto al capitolo 14. Perché è in carcere ? Secondo Matteo, è perché Giovanni il Battista aveva accusato Erode di essersi preso come sposa la moglie di suo fratello, ma c’è uno storico del tempo, Giuseppe Flavio, che nelle “Antichità giudaiche”, ci dà una lettura politica dell’incarcerazione e poi dell’assassinio di Giovanni Battista. Scrive Giuseppe Flavio che Erode era preoccupato del successo, della gente che seguiva il Battista e dice: ”Erode perciò decise che sarebbe stato molto meglio colpire in anticipo e liberarsi di lui, prima che la sua attività portasse ad una sollevazione”. Quindi per Giuseppe Flavio c’è un motivo politico. Giovanni è in carcere, diremmo nel supercarcere di una fortezza, costruita da Erode il Grande, nella riva orientale del Mar Morto, Macheronte. “…avendo sentito parlare delle opere del Cristo…”: ecco sono tutte opere con le quali Gesù, il Messia, comunica vita anche ai peccatori, anche ai nemici. “… per mezzo dei suoi discepoli …”: è strano che compaiano i discepoli di Giovanni Battista, si vede che non hanno accolto Gesù come colui da seguire. “… mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?»”: la richiesta di Giovanni il Battista ha tutto il sapore di una scomunica, perché questo Gesù non è quello che, il
Messia che Giovanni il Battista aveva annunziato, questo Messia giustiziere, questo Messia che veniva a portare avanti il castigo di Dio. Allora Giovanni Battista, in profonda crisi, gli manda questa scomunica: sei tu quello che doveva venire, o ne dobbiamo aspettare un altro? Gesù non risponde alla polemica con argomenti teologici, biblici, ma con le opere. “Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete “, cioè ciò di cui voi fate esperienza. E qui Gesù elenca sei opere, sei azioni, il numero sei ricorda i giorni della creazione, quindi Gesù, in prolungamento con il Dio della creazione, continua a comunicare vita, e sono tutte azioni con le quali si comunica, si restituisce, o si rallegra la vita delle persone: “… I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati”, i lebbrosi erano considerati non dei malati, ma dei maledetti, castigati, ”… i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo”, cioè la buona notizia. E qual è la buona notizia che i poveri si attendono ? La fine della povertà. Questo elenco Gesù lo prende dalle azioni del Messia, così come erano state annunziate dal profeta Isaia, in due capitoli del suo libro, nel capitolo 35 e nel capitolo 61, ma, in tutte e due i brani, Isaia aveva annunziato anche la vendetta di Dio contro i pagani, contro i peccatori. Gesù la omette: l’azione di Dio, attraverso Gesù, è un’offerta d’amore a tutti, non c’è forma di vendetta o di castigo. Ecco perché Gesù proclama beato, quindi c’è una nuova beatitudine in questo vangelo, “… colui che non trova in me motivo di scandalo !»”. Qual è lo scandalo ? È lo scandalo della misericordia. È strano questo. Mentre il castigo, il castigo di Dio indubbiamente intimorisce, ma non scandalizza le persone, la misericordia scandalizzava e continua ancora a scandalizzare le persone, specialmente le persone religiose, quelle che pensano che Dio li ama per i loro meriti, per i loro sforzi, non sopportano quest’immagine di un Dio misericordia, Dio misericordia significa che il suo amore non conosce gli ostacoli messi dagli uomini, il suo amore vuole arrivare a tutti. Gesù l’aveva annunziato: suo Padre non è il Dio della religione, in ogni religione Dio premia i buoni e castiga i malvagi. Gesù aveva detto: no, l’azione del Padre è come quella del sole che splende sui cattivi e sui buoni, e ugualmente la pioggia. L’azione del Padre di Gesù è quella di una comunicazione d’amore, indipendentemente dal comportamento e dalla risposta delle persone. Questo è quello che scandalizza: che anche chi non lo merita, anche gli indegni, anche gli impuri, i peccatori, possono essere oggetto dell’amore di Dio, senza una previa penitenza, senza una previa purificazione, questo è lo scandalo della misericordia. Ebbene Gesù proclama beati quelli che non si scandalizzano. “Mentre quelli se ne andavano”, se ne vanno senza alcuna reazione, il che significa da una parte incomprensione, dall’altra disaccordo con quello che Gesù ha detto, ”Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento ?”. Era proverbiale l’attività della canna, era anche in una favola conosciuta di Esòpo. La canna cos’è ? è quella che si piega al vento, è l’ immagine della persona opportunista, quella che è sempre disposta a piegare la schiena, pur di rimanere al suo posto. Il vento soffia da una parte, soffia dall’altra, la canna si piega sempre, quindi l’immagine dell’opportunista. “Allora, che cosa siete andati a vedere ? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re !”, nei palazzi dei re ci sono i cortigiani . Chi sono i cortigiani ? Sono quelli ossequienti al potente di turno, sempre pronti a cambiare bandiera, a cambiare casacca, a cambiare credo, pur di rimanere sempre a galla. “Ebbene,” afferma Gesù, ”che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì,” risponde Gesù “io vi dico, anzi, più che un profeta”. Perché di Giovanni Battista Gesù afferma che è più di un profeta ? Perché Giovanni Battista è colui che è stato inviato da Dio a preparare la strada per Gesù. Allora Gesù ci fa comprendere che, per essere inviati da Dio, collaboratori di Dio, non si può essere né opportunisti, né cortigiani, ma bisogna andare sempre dritti per la propria strada. “Egli è colui del quale sta scritto:”, e qui l’evangelista mette insieme due espressioni dell’antico testamento dal libro dell’Esodo e dal profeta Malachia, “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. L’ evangelista presenta la figura di Giovanni Battista come è stata quella di Mosè, che ha portato il suo popolo verso la Terra Promessa, ma lui non c’è entrato. È stato Gesù che poi porterà questo popolo alla liberazione. Ed infine l’elogio di Gesù: “In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli”, il regno dei cieli, lo ricordiamo, in Matteo è la sua comunità, una società alternativa, una comunità dove ci si entra con l’accettazione e l’accoglienza della prima beatitudine, quella della povertà – beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli – “è più grande di lui»”. Giovanni il Battista non ha potuto entrare in questa comunità appunto perché è stato incarcerato, e non ha potuto soprattutto rinascere di nuovo, rinascere dallo Spirito, dal passare da figlio di donna a figlio di Dio.
festa della Immacolata Concezione
ECCO, CONCEPIRAI UN FIGLIO E LO DARAI ALLA LUCE
commento al angelo della solennità della Immacolata Concezione di p. Alberto MAGGI:
Lc 1,26-38
[In quel tempo,] l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Il vangelo di Luca si apre con l’annunzio di due nascite: quella di Giovanni Battista e quella di Gesù. Sono nascite che indicano il compimento delle promesse di Dio anche in casi impossibili.
Nel primo caso i genitori sono anziani e la madre è sterile, e nel secondo è una vergine che ancora non ha avuto rapporti con il proprio marito. Sentiamo come Luca, l’evangelista, ci descrive tutto questo.
“Al sesto mese” – nel sesto mese, come nel sesto giorno, Dio completa la sua creazione – “l’angelo Gabriele” – Gabri-El significa “la forza di Dio” – “fu mandato da Dio”, e qui questa volta la missione dell’angelo è tutta in salita, è difficile.
Se prima è andato a Gerusalemme, nel santuario, nel momento più importante della vita di un sacerdote, appartenente a una delle classi più prestigiose del sacerdozio e ha trovato soltanto incredulità, il sacerdote non ha ascoltato la parola, e per questo è rimasto senza parole da comunicare al popolo.
Ebbene, ora invece la situazione si presenta difficile, va in una città della Galilea; questa regione era talmente disprezzata che il termine Galilea viene dal disprezzo con il quale il profeta Isaia chiama questo luogo il distretto, da qui “Ghelil” in ebraico la nostra Galilea, il distretto dei pagani.
“…in un città chiamata Nazaret” – Nazareth è un piccolo paese mai citato nella Bibbia – “ad una vergine promessa sposa”.
Nella lingua italiana non abbiamo l’equivalente termine (™mnhsteumšnhn) per indicare il rito matrimoniale ebraico.
Il matrimonio ebraico si svolgeva in due tappe:
1. la prima, che chiamiamo sposalizio, quando la ragazza aveva 12 anni e il maschio 18 serviva a valutare la forza, la capacità della ragazza di fare figli e quindi stabilirne la dote.
2. Poi, dopo questa cerimonia dopo la quale erano marito e moglie, ognuno tornava a casa sua e un anno dopo la ragazza veniva portata nella casa del marito e lì incominciava la convivenza.
Quindi la prima parte del matrimonio si chiama lo sposalizio, la seconda le nozze, quindi è una vergine già sposata a “un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, la vergine si chiamava Maria”.
“Entrando da lei disse: «Rallegrati»” – quindi quest’angelo di Dio la invita alla pienezza della gioia – “«piena di grazia»”.
“Piena di grazia” (kecaritwmšnh) non è una costatazione che l’angelo fa delle virtù di Maria, ma dice che è stata riempita della grazia di Dio, e la saluta come venivano salutati i grandi personaggi che hanno compiuto azioni importanti per la storia del popolo, come per esempio Gedeone, “«il Signore è con te»”.
Maria viene turbata da quest’annuncio, anche perché in quell’epoca si pensava che Dio non avrebbe mai rivolto la parola ad una donna. La donna era considerata la più lontana da Dio, e l’angelo le dice: “«Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio»”.
“Grazia” non è una constatazione di virtù di Maria, ma l’amore che Dio ha riversato su questa donna. “«Ecco concepirai un figlio»” – e inizia la prima delle trasgressioni che caratterizzano il vangelo di Luca – “«Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù»”.
Contro ogni tradizione, non spettava alla donna dare il nome al figlio, era il padre che normalmente dava al figlio il proprio nome, così si perpetuava. Qui inizia giù la rottura con la tradizione.
Il primo indizio delle tante rotture della tradizione che poi Gesù porterà a compimento. “«Sarà grande, verrà chiamato Figlio dell’Altissimo»”, Giuseppe è escluso da tutto questo.
Perché Giuseppe viene escluso?
Perché il padre non trasmetteva soltanto la vita fisica, biologica, ma trasmetteva anche la tradizione, trasmetteva anche la spiritualità, ecco in Gesù c’è una nuova creazione, Lui sarà il Figlio di Dio, seguirà il Padre, e annuncia l’angelo a Maria, che in Gesù avranno luogo pieno il compimento delle promesse che Dio aveva fatto al suo popolo, di un regno senza fine.
Maria? Maria accetta, vuole sapere soltanto le modalità, dice: come avverrà questo perché non conosco uomo. Perché non era ancora passata nella seconda fase del matrimonio. Nella prima fase non era permesso avere rapporti con il marito.
“«Rispose l’angelo: lo Spirito Santo»”, la presenza di Maria in questo vangelo si apre e si chiude all’insegna dello Spirito, Maria è la donna dello Spirito. Su di lei all’annunciazione scende lo Spirito Santo, e poi l’ultima volta la troveremo nella parte del vangelo di Luca chiamata gli Atti degli Apostoli, al momento della Pentecoste, quindi Maria è la donna dello Spirito.
Lo Spirito Santo significa che in Gesù si manifesta la vera e nuova definitiva creazione. “«Scenderà su di te la potenza dell’Altissimo, ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà Santo»” – cioè consacrato – “«sarà chiamato Figlio di Dio»”, sta dicendo che sarà il Messia.
E come garanzia, come prova di quanto l’angelo sta assicurando a Maria le dice che Elisabetta, sua parente, la moglie di Zaccaria, “«nella sua vecchiaia»”, quindi l’evangelista sottolinea la difficoltà di questa realizzazione, ma Dio è fedele alle sua promesse nonostante ogni difficoltà. Solo che il compimento delle promesse esige collaborazione da parte dell’uomo, con l’ascolto della sua parola, con il fidarsi, e Zaccaria non si è fidato, e soprattutto con l’agire.
“«Ecco, Elisabetta ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile»”. Vecchiaia e sterilità non sono problemi per l’azione del Signore, per realizzare i suoi progetti. Perché nulla è impossibile a Dio. La forza creatrice di Dio non ha limiti, però esige la collaborazione dell’uomo che come abbiamo detto deve ascoltare la sua parola, fidarsi di questa parola, e poi agire di conseguenza.
“«Allora Maria disse: ecco la serva»”, Maria non dice che è una serva del Signore, dice che è la serva, nei testi biblici Israele viene chiamato il servo del Signore, quindi Maria si viene ad identificare, rappresentare quelli che sempre si sono fidati del Signore, l’Israele del Signore.
E qui c’è l’altra trasgressione con la quale si chiude questo brano, “avvenga di me secondo la tua parola”.
Come si permette Maria di accettare questa proposta senza aver consultato e ottenuto il permesso da parte del padre o del marito?
Era inconcepibile in una cultura del genere che una donna prendesse una qualsiasi decisione senza il permesso. L’autorizzazione da parte del maschio di casa, ecco Maria continua questa trasgressione. Sarà lei a dare il nome al figlio, e sarà lei che decide senza chiedere nulla al marito né al padre.
Quindi il vangelo di Luca si apre con questa novità di aprirsi al nuovo di cui Maria, la donna dello Spirito ne è l’esempio eclatante.
ricordando Charles de Foucauld a 100 anni dalla sua uccisione
Charles de Foucauld, il «fratello» di tutti
giovedì 1 dicembre il centenario della morte
il vicepostulatore
fulcro del suo carisma è la quotidianità di Nazareth come testimonianza del Vangelo

A cento anni dalla sua morte, avvenuta il 1° dicembre 1916 nel deserto algerino di Tamanrasset, il beato Charles de Foucauld ha ancora un messaggio attualissimo da comunicare: «Anzitutto, il fulcro del suo carisma, che è la vita quotidiana di Nazarethh come testimonianza del Vangelo nella semplicità, nell’impegno del lavoro, mantenendo sempre al centro l’umanità che ci lega gli uni agli altri, perché siamo tutti fratelli», ricorda padre Andrea Mandonico, 61 anni, della Società delle Missioni africane, istituto missionario nato nel 1856 a Lione.
Dal 2012 è vicepostulatore della causa di canonizzazione di frère Charles, a cui lo lega una profonda sintonia: «Mentre frequentavo il liceo in Seminario a Crema, un compagno mi passò un libretto su di lui. Rimasi colpito: la sua esperienza mi suggeriva come vivere la fede. Su di lui è incentrata la mia tesi di dottorato in teologia spirituale». Il secondo aspetto del beato che parla agli uomini e alle donne del terzo millennio «è la vicinanza al prossimo.
Amare Dio e il prossimo sono due aspetti inscindibili. Lui si è fatto vicino al popolo tuareg in Algeria, emarginato e povero, e suggerisce a noi oggi una vicinanza agli ultimi per vedere in loro la presenza di Gesù e in chiunque si affaccia alla nostra porta la presenza di Gesù. Fra l’altro, anche i musulmani vivono la regola dell’elemosina e dell’amore al povero». In terzo luogo, Charles de Foucauld «ci ha lasciato l’eredità del dialogo: è stato un uomo che ha dialogato con tutti, perché il dialogo smonta i pregiudizi reciproci e avvicina fino a trasformarsi in amicizia per vivere la fraternità.
Lui l’ha vissuto fino alle estreme conseguenze: venne ucciso in una razzia. Ma era convinto dell’urgenza di stringere rapporti di fraternità e vincere la paura che ci separa gli uni dagli altri». Il bisogno di dialogo e amicizia emerge costantemente anche nelle oltre 7mila lettere (pubblicate quasi tutte in francese, non in italiano) scritte dal Beato Charles, che voleva essere «fratello universale e vivere in amicizia con tutti: giudei cristiani e musulmani», rimarca padre Mandonico, che sta tenendo per il secondo anno consecutivo un seminario su de Foucauld al Centro studi dialogo interreligioso della Pontificia Università Gregoriana, sul tema “Cristianesimo e islam: una fraternità possibile?”.
A dare il via libera alla beatificazione, il 13 novembre 2005, la guarigione inspiegabile della signora Giovanna Pulici, originaria di Desio. «Aveva un tumore osseo in fase terminale, alla fine degli anni Settanta. Curata a Milano, fu mandata a casa dai medici perché non c’era più nulla da fare. Il marito, grande devoto di frère Charles, gli disse: “Pensaci tu”. La donna guarì improvvisamente, il giorno di Pasqua era in chiesa a ringraziare il Signore con sua famiglia». Molti anni dopo, nel 2000, il marito con le figlie era a Roma per l’Anno Santo: «Ha visto passare una piccola sorella di Gesù per strada e l’ha fermata chiedendole: “Quando vedremo fratel Carlo canonizzato?”. Lei rispose che ancora non era beato, perché per far andare avanti la causa occorreva la certificazione di un miracolo. E lui: “Il miracolo ce l’ho io”».
Lo stesso padre Andrea è stato impegnato nella raccolta della testimonianza, del dossier medico di Giovanna e della sua cartella clinica. E riferisce che proprio in occasione del centenario della morte di frère Charles «dalla Francia alcuni vescovi hanno inviato al Santo Padre lettere per chiedergli la canonizzazione anche senza un secondo miracolo, per la fama di santità». Oggi circa 20 associazioni e congregazioni fanno parte della famiglia spirituale del beato e si ispirano al suo carisma.
«io, Foucauld, un’anima alla ricerca di Dio»
il 1° dicembre di cent’anni fa il martirio in Algeria
ora il sacerdote-scrittore Pablo d’Ors immagina un suo «diario» in prima persona

Nella classica biografia del 1921 – ora disponibile nel catalogo delle Paoline – René Bazin lo evocava come «esploratore del Marocco, eremita nel Sahara». A «un ufficiale dissipato e festaiolo, della specie più volgare» si riferiva invece trent’anni dopo Paul Claudel in apertura del suo poetico ritratto del «visconte de Foucauld », ovvero fratel Carlo, come solitamente è chiamato in Italia il beato Charles de Foucauld. Definizioni ineccepibili, nessuna delle quali può essere isolata dalle altre, specie alla vigilia del primo centenario della morte – o, meglio, del martirio – di quest’uomo che si ritrovò a essere tutto, ma solo per scoprire di voler essere nulla. In occasione dell’anniversario arrivano in libreria riproposte suggestive (come un’altra biografia d’epoca, Charles de Foucauld. Esploratore mistico di Michel Carrouges, traduzione di Francesco Calvesi, Castelvecchi, pagine 228, euro 17,50) e utili antologie dagli scritti (le Pagine da Nararet curate da Natale Benazzi per Edizioni di Terrasanta, pagine 154, euro 14,00, oppure le meditazioni sui Vangeli proposte da San Paolo con il titolo Dio di misericordia, pagine 204, euro 12,00). E arriva, molto atteso, il romanzo che il sacerdote-scrittore spagnolo Pablo d’Ors ha dedicato a fratel Carlo, L’oblio di sé (traduzione di Simone Cattaneo, Vita e Pensiero, pagine 414, euro 20,00).
Charles de Foucauld, in effetti, era già stato protagonista di un altro libro di D’Ors, L’amico del deserto, pubblicato lo scorso anno da Quodlibet nella versione di Marino Magliani. Ma si trattava, in quel caso, di un protagonismo per absentiam, dato che l’intero racconto ruotava sì intorno al desiderio di nascondimento e contemplazione caratteristico di fratel Carlo, il cui nome affiorava però in modo intermittente, quasi a convincere il lettore della struttura eccentrica e pressoché iniziatica del libro. In apparenza L’oblio di sé assume un andamento più convenzionale. Quello che D’Ors ci presenta questa volta è addirittura il diario che fratel Carlo avrebbe redatto su richiesta del suo padre spirituale (e vero padre nella fede), l’abate Henri Huvelin. Proprio perché scritto dallo stesso Charles de Foucauld, il resoconto è privo del drammatico finale, che coincide con l’uccisione del religioso francese da parte dei predoni senussiti.
Era il 1° dicembre 1916, fratel Carlo aveva 58 anni e da ormai quindici conduceva un’esistenza da eremita nel Sahara algerino. La chiesa-fortino di Tamanrasset, obiettivo della razzia che gli costò la vita, era stata pensata e costruita come avamposto spirituale nel cuore del deserto. Prima di cadere, l’evangelizzatore dei tuareg aveva messo in salvo l’Eucaristia, che rappresentava il centro della sua spiritualità. È una storia nota, eppure non smette di impressionare, di apparire talmente straordinaria da sembrare inventata da un romanziere. Perché Charles de Foucauld nasce nobile il 15 settembre 1858, presto si ritrova orfano e benestante, passa per svogliato a scuola e per buontempone nell’esercito, dove pure dà prova di coraggio e perfeziona la tecnica del travestimento, che gli tornerà utile da lì a poco, quando – tra il 1883 e il 1884 – compirà il lungo viaggio nel Marocco interno al quale è legata la sua fama di esploratore. La conversione risale al 1886, inizialmente Charles viene ammesso nella Trappa di Nostra Signora delle Nevi, nel-l’Ardèche, ma la sua vocazione è troppo inquieta per conformarsi del tutto alla regola monastica.
Gli anni decisivi sono quelli trascorsi a Nazaret, appunto, tra il 1897 e il 1900. Fratel Carlo lavora come giardiniere nel convento delle Clarisse, inoltrandosi sempre di più nella ricerca spirituale e abbozzando i lineamenti di quella che diventerà in seguito la comunità dei Piccoli fratelli e delle Piccole sorelle del Sacro Cuore. Ordinato sacerdote, si stabilisce in Algeria nel 1901, prima presso l’oasi di Beni Abbes e da ultimo a Tamansarret, dedicandosi tra l’altro alla compilazione del primo, fondamentale dizionario berbero-francese. Una vita che sembra già un romanzo, dicevamo, ma che Pablo d’Ors riesce a ricostruire senza mai insistere sugli elementi più eclatanti, scegliendo di concentrarsi piuttosto sull’interiorità di fratel Carlo. Se la sua entrata in scena può infatti ricordare l’esagitazione del giovane Rimbaud, il titolo scelto per uno dei capitoli finali, La messa sul mondo, riprende alla lettera un’espressione cara al cristocentrismo cosmico di Pierre Teilhard de Chardin, a ribadire la continuità anzitutto spirituale di cui fratel Carlo è testimone. Allo stesso modo, nelle epigrafi che introducono ciascuna sezione del libro, D’Ors si mantiene fedele allo stile di fratellanza universale del suo Charles de Foucauld, che non fa mistero di aver riscoperto il Vangelo dopo aver conosciuto il Corano.
Nell’Oblio di sé appaiono dunque citazioni dai Racconti di un pellegrino russo e dal canzoniere sufi di Yunus Emre, dai maestri del buddhismo zen e dalle poesie del mistico contemporaneo Dag Hammarskjöld, dalle lettere di san Paolo e dal diario di Etty Hillesum. Non è una generica esibizione di sincretismo, ma la consapevolezza di quanto l’avventura di fratel Carlo sia, in realtà, l’avventura di qualunque anima alla ricerca di Dio. Di qualunque corpo, andrà aggiunto, dato che uno degli aspetti più convincenti del libro di D’Ors – autore fra l’altro della magnifica Biografia del silenzio edita da Vita e Pensiero nel 2014 – consiste proprio nell’insistenza sul legame inscindibile tra materiale e immateriale, tra visibile e invisibile. Si comincia a credere quando ci si mette in ginocchio, avverte il fratel Carlo dell’Oblio di sé, e si inizia a progredire nell’imitazione di Cristo quando si impara a praticare il digiuno. Non è un caso, del resto, che tra le pagine più belle ci siano proprio quelle nelle quali gli oggetti della quotidianità, illuminati dalla luce sovrannaturale dell’Eucaristia, rivelano al protagonista la silenziosa vastità della Rivelazione: «Le cose non pretendono nulla da noi: stanno, sono. E così è Dio, pensavo: Colui che sta, Colui che è, Colui che si offre in tutto e in tutti». Il Rimbaud di Vocali non è lontano, il Teilhard de Chardin del Cristo nella materia è già alle porte.
su l’Avvenire
Charles de Foucault
contemplazione, condivisione, universalità
in “Avvenire” del 30 novembre 2016
contemplazione, condivisione, universalità: tre condizioni di vita, tre espressioni di cura. È così che desideriamo raccontare l’esperienza al seguito di frère Charles
nuove forme di collaborazione e di gratuità, incoraggiandoci a sviluppare, insieme ad altre realtà civili ed ecclesiali, riflessioni e iniziative volte a offrire a queste donne prospettive di vita e di speranza. L’esperienza di una nostra fraternità, in un quartiere di Marsiglia, a prevalenza musulmano e multietnico, ci fa sperimentare che cosa significa essere “straniere tra stranieri”. Tocchiamo con mano la bellezza della reciproca ospitalità, dell’ascolto e dell’accoglienza della ricchezza dell’altro, nei gesti di bontà e di cura donati e ricevuti. Sono vie quotidiane, piccole e nascoste, segni di speranza e di pace tra persone di diversa cultura e religione. Fin dalla sua presenza nel Sahara, Charles de Foucauld si era proposto di «abituare tutti gli abitanti, cristiani, musulmani, ebrei, idolatri» a considerarlo «come loro fratello, il fratello universale». Egli voleva essere «il fratello di tutti gli uomini senza eccezione né distinzione » e desiderava che quanti lo avvicinavano, credenti e non credenti, diventassero, a loro volta, fratelli di altri uomini e donne. L’universalità è la terza prospettiva di vita ereditata al seguito di frère Charles. Per noi, la “fraternità universale” ha trovato, nel corso degli anni, diverse forme di espressione. Frequentare ambiti lavorativi diversi, essere inserite in ambienti sociali, culturali e religiosi differenti (quartieri popolari, rurali e cittadini), vivere in comunione con le comunità cristiane di appartenenza, sono manifestazioni della creatività e originalità dell’esperienza spirituale foucauldiana. L’incontro con la vicenda di frère Charles, fratello universale al seguito di Gesù di Nazareth, sia per ciascuno concreta possibilità per vivere relazioni di cura e benevolenza verso quanti incontriamo: relazioni pienamente umane poiché autenticamente evangeliche. (A cura delle “Discepole del Vangelo”)
il nostro mare-cimitero: 5000 morti in meno di un anno
migranti
negli ultimi 10 mesi quasi 5 mila vittime
oltre 3.500 hanno perso la vita nel Mediterraneo
e nel 2015 sono state 65 milioni le persone costrette a lasciare il proprio paese

i quattro cardinali che vogliono una chiesa immobile non la ‘chiesa in uscita’ di papa Francesco
quattro cardinali chiedono spiegazioni su “Amoris laetitia”

di Andrea Tornielli
in “La Stampa-Vatican Insider”
Quattro porporati chiedono al Papa di chiarire alcuni dubbi riguardanti l’interpretazione dell’esortazione post-sinodale «Amoris laetitia» sul matrimonio e la famiglia
sono i cardinali Walter Brandmüller, già presidente del Pontificio comitato di scienze storiche;
Raymond L. Burke, patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta,
e gli arcivescovi emeriti Carlo Caffarra (Bologna)
e Joachim Meisner (Colonia)
La lettera, consegnata nelle mani del Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 19 settembre è stata pubblicata lunedì 14 novembre dal sito dell’Espresso curato da Sandro Magister e dal quotidiano online La Nuova Bussola quotidiana.

 I porporati hanno deciso di rendere pubblico il documento consegnato all’ex Sant’Uffizio perché fino a questo momento non hanno ricevuto risposta. «Abbiamo constatato un grave smarrimento di molti fedeli e una grande confusione – scrivono i quattro porporati – in merito a questioni assai importanti per la vita della Chiesa. Abbiamo notato che anche all’interno del collegio episcopale si danno interpretazioni contrastanti del capitolo ottavo di “Amoris laetitia”. La grande Tradizione della Chiesa ci insegna che la via d’uscita da situazioni come questa è il ricorso al Santo Padre, chiedendo alla Sede Apostolica di risolvere quei dubbi che sono la causa di smarrimento e confusione».
I porporati hanno deciso di rendere pubblico il documento consegnato all’ex Sant’Uffizio perché fino a questo momento non hanno ricevuto risposta. «Abbiamo constatato un grave smarrimento di molti fedeli e una grande confusione – scrivono i quattro porporati – in merito a questioni assai importanti per la vita della Chiesa. Abbiamo notato che anche all’interno del collegio episcopale si danno interpretazioni contrastanti del capitolo ottavo di “Amoris laetitia”. La grande Tradizione della Chiesa ci insegna che la via d’uscita da situazioni come questa è il ricorso al Santo Padre, chiedendo alla Sede Apostolica di risolvere quei dubbi che sono la causa di smarrimento e confusione».
 «Il Santo Padre – si legge ancora nella lettera – ha deciso di non rispondere. Abbiamo interpretato questa sua sovrana decisione come un invito a continuare la riflessione e la discussione, pacata e rispettosa. E pertanto informiamo della nostra iniziativa l’intero popolo di Dio, offrendo tutta la documentazione. Vogliamo sperare che nessuno interpreti il fatto secondo lo schema “progressisticonservatori”: sarebbe totalmente fuori strada. Siamo profondamente preoccupati del vero bene delle anime, suprema legge della Chiesa, e non di far progredire nella Chiesa una qualche forma di politica.
«Il Santo Padre – si legge ancora nella lettera – ha deciso di non rispondere. Abbiamo interpretato questa sua sovrana decisione come un invito a continuare la riflessione e la discussione, pacata e rispettosa. E pertanto informiamo della nostra iniziativa l’intero popolo di Dio, offrendo tutta la documentazione. Vogliamo sperare che nessuno interpreti il fatto secondo lo schema “progressisticonservatori”: sarebbe totalmente fuori strada. Siamo profondamente preoccupati del vero bene delle anime, suprema legge della Chiesa, e non di far progredire nella Chiesa una qualche forma di politica.
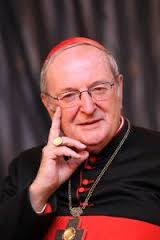 Vogliamo sperare che nessuno ci giudichi, ingiustamente, avversari del Santo Padre e gente priva di misericordia. Ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo nasce dalla profonda affezione collegiale che ci unisce al Papa, e dall’appassionata preoccupazione per il bene dei fedeli». Il documento ha la forma dei «dubia» (dubbi) che vengono solitamente presentati alla Congregazione per la dottrina della fede secondo una forma che permette di rispondere con un «sì» o con un «no».
Vogliamo sperare che nessuno ci giudichi, ingiustamente, avversari del Santo Padre e gente priva di misericordia. Ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo nasce dalla profonda affezione collegiale che ci unisce al Papa, e dall’appassionata preoccupazione per il bene dei fedeli». Il documento ha la forma dei «dubia» (dubbi) che vengono solitamente presentati alla Congregazione per la dottrina della fede secondo una forma che permette di rispondere con un «sì» o con un «no».
Questo il testo dei quesiti, riguardanti il capitolo VIII dell’esortazione dedicato all’accompagnamento delle famiglie ferite e al discernimento:
1. Si chiede se, a seguito di quanto affermato in “Amoris laetitia” nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive “more uxorio” con un’altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da “Familiaris consortio” n. 84 e poi ribadite da “Reconciliatio et paenitentia” n. 34 e da “Sacramentum caritatis” n. 29. L’espressione “in certi casi” della nota 351 (n. 305) dell’esortazione “Amoris laetitia” può essere applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere “more uxorio”?
2. Continua ad essere valido, dopo l’esortazione postsinodale “Amoris laetitia” (cfr. n. 304), l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l’esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi?
3. Dopo “Amoris laetitia” n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l’adulterio (cfr. Mt 19, 3-9), si trova in situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)?
4. Dopo le affermazioni di “Amoris laetitia” n. 302 sulle “circostanze attenuanti la responsabilità morale”, si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 81, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, secondo cui: “le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta”?
5. Dopo “Amoris laetitia” n. 303 si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 56, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, che esclude un’interpretazione creativa del ruolo della coscienza e afferma che la coscienza non è mai autorizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azioni intrinsecamente cattive per il loro oggetto?
qui sotto un breve commento di Andrea Grillo che giustamente evidenzia i forti limiti della ‘lettera’ e dei suoi estensori che usano un linguaggio che non ha più alcun riferimento con la realtà, utilizzano Scrittura e tradizione per immunizzarsi nei confronti del reale, chiedono di stare fermi e immobili, non di essere una chiesa in uscita:

5 Dubbi, 4 Cardinali, 3 certezze
di Andrea Grillo
in Come se non
del 14 novembre 2016
(http://www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non)
Dopo quelle scritte durante il Sinodo, più o meno clandestinamente, un’altra lettera, sempre con le solite firme, ora selezionate. Ma questa volta non vengono espressi timori o desideri. No, questo è un elenco di “dubbi”. La cosa interessante è che il dubbio non è tanto su “Amoris Laetitia”, ma sul disegno del papa in quanto tale. Ma l’effetto, inatteso, è che i 4 cardinali, formulando i loro 5 dubbi, fanno sorgere nel popolo di Dio 3 grandi certezze. Dai loro 5 dubbi nascono le nostre 3 certezze. La dinamica ecclesiale riserva anche queste sorprese. Se esperti uomini di Chiesa, dopo 7 mesi dalla presentazione del testo di AL, continuano a “non capire” – o a non volere capire – che cosa è mutato e si abbarbicano ostinatamente alle loro “evidenze sospette”, tutto ciò determina, nel corpo ecclesiale, una nuova coscienza, talmente radicale, da diventare certezza. La loro diffidenza verso AL ci consente una nuova confidenza col Vangelo. Anche questo, in certo modo, è ministero ecclesiale.
Certitudo prima
Nella Chiesa cattolica, a causa di una vicenda storica complessa, ma della quale avrebbero dovuto accorgersi da tempo anche questi Signori Cardinali, può accadere che si parli un linguaggio che non ha più alcun riferimento alla realtà. Si può parlare di soggetti sposati davanti alla legge come se vivessero “more uxorio” e di “atti intrinsecamente negativi” come se fosse fuori dalla storia. Alla radice di questo disagio sta una mancanza di riconoscimento della realtà e una radicale pretesa di autosufficienza. A nulla vale la esperienza: si è imparato a nascondersi dietro la corazza di una “scienza triste”, identificata con il Vangelo, e ci si atteggia a “difensori del bene delle anime”. Ma si è perso il legame tanto con le anime quanto con il bene.
Certitudo altera
Viene il tempo in cui occorre scegliere tra iniziare processi di conversione o occupare spazi di potere. Ad ogni costo i 4 firmatari ritengono che per un pastore e per un uomo di Chiesa non vi sia alternativa. Può soltanto occupare spazi di potere e gettare bombe lacrimogene per impedire la vista del reale. E si usa ogni mezzo. Soprattutto si pretende che la Scrittura e la Tradizione siano al servizio delle operazioni di “immunizzazione dal reale” perseguite negli ultimi 40 anni. Il popolo di Dio e il magistero ecclesiale guarda a questi tentativi come si guarda, con la giusta comprensione, ai bambini che, privati del loro giocattolo preferito, pestano i piedi e chiedono giustizia.
Certitudo tertia
Da ormai 7 mesi è iniziata la strada di una recezione ricca e complessa di Amoris Laetitia. I pastori che hanno a cuore il bene dei loro fedeli conoscono la strada, si sono messi in cammino: qualcuno davanti al popolo, per incitare alla marcia; qualcuno in mezzo al popolo, per tenere bene la andatura comune; qualcuno nelle retrovie, a custodire quelli col passo più lento. I pastori sanno dove stare. I cardinali che salgono al primo piano, si mettono alla finestra e cercano in qualche modo di far rientrare la Chiesa in uscita, temono gli ospedali da campo, rifuggono i campi profughi. Salgono alla finestra e si dicono “dove andremo a finire?”. E l’unica risposta è “Bisogna finire di andare”. Stare. Fermi. Sordi. Immuni. Lontani. Indifferenti. Con un sentimento di infinita differenza dal mondo estraneo. Ma anzitutto da Francesco, papa strano. Che spuzza di vita. E che osa non subordinare il Vangelo alla legge.
botte al marito perché ha la moglie zingara e per di più va in televisione – intervista ai due coniugi
“tua moglie è la zingara che va in televisione”
e scatta l’aggressione
timpano lesionato per Paolo Cagna Ninchi, marito di Dijana Pavlovic, nota attivista rom. Violenza venerdì sera nella zona di viale Ungheria a Milano

Aggredito sotto casa da uno sconosciuto che l’ha insultato perché “tua moglie è la zingara che va in televisione”. Lo rende noto l’associazione Upre Roma (impegnata in progetti contro la discriminazione e per l’inclusione della comunità rom). Vittima del pestaggio, il suo presidente Paolo Cagna Ninchi, marito di Dijana Pavlovic, rappresentante della Consulta rom e sinti milanese “da tempo minacciata sia sui social network che nel quartiere in cui abita”, si precisa nella nota. L’episodio violento sarebbe avvenuto venerdì sera nella zona di viale Ungheria.
Il presidente Upre – si legge nella nota – ha riportato una lesione al timpano dell’orecchio sinistro che ha reso necessario un intervento chirurgico. “Si tratta di un crimine d’odio come tanti altri, che i rom e i non rom che “li difendono” (che nella classifica della mentalità razzista sono peggio dei rom stessi) subiscono. Una famiglia normale con un bimbo di 7 anni che abita in una periferia di Milano è costretta da tempo a vivere nella paura di scendere sotto casa per portare fuori il cane o fare la spesa al supermercato per il solo fatto che è classificata come famiglia zingara”. L’associazione denuncia “questo crimine a palese sfondo razziale attuato in un clima d’odio e insofferenza che sfoga il proprio malessere sulla fragilità altrui”. Chiede a Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale) di intervenire con decisione nel condannare i crimini d’odio e all’amministrazione di Milano, “a passare ai fatti. La zona di viale Ungheria è abbandonata a se stessa. C’è bisogno non di costosi progetti di riqualificazione urbana, intesi come interventi immobiliari, ma di meno costosi, più rapidi ed efficaci interventi sulla vivibilità”.
Solidarietà da Milano in Comune, che “condanna con fermezza questa aggressione, ritenendola frutto anche del clima di incitamento all’odio razziale a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane”, e da Sinistra X Milano, la quale “richiama i valori di accoglienza, solidarietà e inclusione di tantissimi cittadini e cittadine milanesi riconfermati anche dalla grande festa di popolo che l’1 novembre ha accolto l’arrivo dei primi profughi alla Montello”.
Intervista a Dijana Pavlovic e Paolo Cagna Ninchi
a cura di Antonio Chiocchi
(dal Rapporto sui Diritti Globali 2014)
La persecuzione dei rom ha una storia antica: nasce con la loro venuta in Europa nel Quattrocento. Con Dijana Pavlovic e Paolo Cagna Ninchi, fondatori dell’associazione UPRE ROMA, seguiamo questa storia dagli inizi fino agli approdi della contemporaneità. Viaggiamo con loro tra le costanti e le varianti di questa persecuzione: mai smentita, sempre confermata e sempre modificatasi. Volendo usare una espressione sintetica, ma efficace, possiamo dire che i rom e i sinti sono i condannati dal potere, per il loro essere ed esistere. L’inaccettabilità dei rom e dei sinti da parte dei sistemi di potere che hanno governato il mondo corrisponde all’accettazione incondizionata da parte dei rom e dei sinti dei linguaggi della libertà del mondo e della libertà come mondo. Come ci ricordano Dijana e Paolo, la patria dei rom e dei sinti è più grande di tutte le piccole patrie: è la terra di cui non si può essere nemici e che tutti ci riconosce.
Agli occhi del potere, il problema di fondo sollevato dai rom e dai sinti nasce da qui. Costituiscono l’inaccettabile e l’intollerabile, perché non si appropriano della terra, ma la solcano; non la usano, ma la attraversano; non la occupano, ma la abitano. Più i rom e i sinti ci ricordano queste verità primordiali, più le società oppressive che li perseguitano devono toglier loro la parola. Contro di loro la voce dell’oppressione risuona proprio per renderli muti e invisibili. Il loro abitare il mondo non solo è deriso e offeso, ma è soprattutto interdetto. Anche per questo l’architettura e l’estetica dei campi in cui sono segregati sono così misere, estraneanti e vuote di senso dell’umanità.
Il razzismo sotto traccia, di cui parlano Dijana Pavlovic e Paolo Cagna Ninchi, dà impulso, vita e sostanze alle pratiche di esclusione contro cui da sempre i rom e i sinti hanno dovuto combattere. Ed è vero: proprio questa secolare oppressione che non è stata capace di distruggerli dimostra tutto il loro coraggio e la loro determinazione. Da condannati dal potere, si trasformano in indomabile resistenza all’odio, alla violenza e alla discriminazione.
Redazione Diritti Globali:
Contro i rom e i sinti si è sedimentato e diffuso nel tempo un’inestinguibile avversione che, non di rado, è sfociata nell’odio, nella persecuzione e nella violazione di tutti i più elementari diritti umani. V’è in ciò qualcosa di antico e continuamente risorgente? Cosa, invece, di specifico è stato partorito nella contemporaneità delle società neoliberali e, più ancora, nella crisi globale che sta impoverendo il mondo?
Dijana Pavlovich e Paolo Cagna Ninchi:
Nelle prime cronache del 1400 giunte sino a noi si parla di questi gruppi stravaganti per abbigliamento e usi che si fermavano ai bordi delle città e che, ben presto, divennero oggetto di attenzione delle autorità per la loro estraneità. Quindi il pregiudizio è antico e di conseguenza la discriminazione e poi la persecuzione sono antichi e hanno conservato intatti i loro segni che si sono impressi in modo indelebile su questo popolo, fino alle estreme conseguenze dello sterminio su base razziale del nazifascismo. Gli effetti della crisi globale che sta impoverendo il mondo, più che sul piano delle condizioni materiali di un popolo che ha fatto della capacità di sopravvivere in qualunque condizione un proprio modo di essere, agiscono sul rapporto con la popolazione maggioritaria che, anche senza l’aiuto degli imprenditori della paura e dello sfruttamento politico, ne fa il capro espiatorio preferito, insieme con gli immigrati, del proprio malessere non solo economico, ma diremmo anche di perdita di senso nella società neoliberale.
RDG:
Volendo fare il punto, secondo quanto suggeritovi dalla vostra esperienza, quali sono le problematiche più preoccupanti della situazione dei rom e dei sinti in Italia e in Europa? L’Unione Europea, con i suoi continui appelli al rispetto dei loro diritti, quanto è conseguente nella salvaguardia dell’integrità culturale dei rom e dei sinti? I suoi programmi di integrazione e inclusione accolgono e rispettano effettivamente la loro diversità costitutiva?
DP e PCN:
Osservando la situazione dal punto di vista di quello che fanno le istituzioni nazionali ed europee si possono cogliere segnali di consapevolezza che le politiche sinora attuate per rom e sinti non hanno prodotto i risultati sperati, nonostante i rilevanti investimenti disponibili. Sono importanti le direttive anche recenti per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione, ma vale la pena di sottolineare un punto di criticità che pare finalmente affrontato anche se non risolto. Per dirla con uno slogan: passare dall’assistenza all’autonomia. Da questo punto di vista anche i recenti programmi del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea partono dall’investire sulle comunità e sulla loro capacità di organizzare progetti per sé. La possibilità che questo si realizzi, poi, è tutta legata alle condizioni dei singoli Paesi e rimanda quindi al rapporto tra istituzioni le comunità locali.
RDG:
Passiamo a un esempio concreto. In attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011, in Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato la strategia nazionale 2012-2020 di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti. Che giudizio date di quella strategia in sé? Qual è il suo stato attuale di realizzazione? Quali i suoi nodi irrisolti?
DP e PCN:
La strategia nazionale coglie questo mutamento di prospettiva: la sua stessa elaborazione è stata frutto di confronto con le comunità rom e sinte, sino al punto che nodi cruciali come l’abitare sono stati declinati non più in base ai paradigmi della società maggioritaria, ma in base alle diverse culture ed esigenze delle comunità. Ma il punto fondamentale della strategia è l’impegno per le amministrazioni a far partecipare rom e sinti alle decisioni che li riguardano. E questo ovviamente è il punto critico di una strategia che deve essere realizzata a livello locale e quindi si scontra con la “politica”, tant’è che i tavoli regionali di applicazione previsti sono stati a oggi realizzati solo in quattro regioni e questo definisce la difficoltà della sua applicazione.
RDG:
Esiste un localismo anti-rom che è una coerente filiazione del globalismo anti-rom. Ma tra localismo e globalismo vi sono pure delle contraddizioni, a volte positive. Come agevolare una trasformazione delle politiche locali a favore dei rom? Come fare in modo che le politiche globali sostengano attivamente la libertà e i diritti dei i rom?
DP e PCN:
La dimensione locale è molto importante, basti vedere la diversa condizione di rom e sinti in Sud Italia rispetto al Nord Italia. Su queste differenze non agiscono solo la politica e il generale atteggiamento discriminatorio, ma anche tradizioni e culture che, per esempio nel caso del nostro Meridione, hanno punti di contatto che rendono più facile l’incontro e la tolleranza. Viceversa, per generalizzare, l’egoismo leghista coglie un’evoluzione culturale di una società malata che ha trovato la sua espressione più drammatica nella tragedia familiare di Pietro Maso che uccide i genitori per soldi. Per questo è decisiva la capacità anche da parte delle comunità rom e sinte di trovare punti di relazione a livello locale, sia usando gli strumenti istituzionali disponibili, sia sviluppando una propria capacità di relazione.
RDG:
Sicuramente, contro i rom si è scatenato da sempre un atteggiamento di razzismo puro. Ma la loro marginalità sociale e la loro povertà, in questi anni di crisi globale, si sono molto accentuate. Prendiamo due dimensioni geopolitiche dello stesso problema: l’Ungheria neoliberale del dopo-URSS e tre importanti metropoli italiane come Roma, Milano e Napoli. Ci sembra che, dal pregiudizio razziale e culturale, si sia passati a pratiche di espulsione e confinamento a raggio sempre più ampio. Il vocabolario dei diritti è stato definitivamente espulso dal vissuto dei rom e dei sinti? Le istituzioni democratiche si sono trasformate in istituzioni attivamente segregative?
DP e PCN:
Come sempre, anche per rom e sinti non si può generalizzare ed è giusto osservare la situazione da più punti di vista. La crescita a livello globale delle diseguaglianze, del distacco tra ricchi e poveri, dello sfruttamento politico della crisi con la crescita dei movimenti ultranazionalisti e fascisti in Paesi come l’Ungheria, ha portato a veri e propri pogrom in molti villaggi rom. Eppure, in Ungheria le comunità sono numericamente forti, organizzate e persino riconosciute dalla Stato. Nelle grandi città italiane rimane la concezione dell’emarginazione anche fisica delle comunità rom e sinte e la cosa da segnalare è che tutte e tre le città, Roma, Napoli e Milano, sono governate da giunte di centro sinistra, segno che al di là della convenienza politica – a sinistra meno si parla di rom meglio è – esiste un razzismo sotto traccia che è parte di una cultura che pervade tutta la società. Le scelte, comunque presentate, sono sempre scelte culturalmente segregative sia quelle istituzionali, sia quelle dell’assistenza caritatevole. Questo ha portato le comunità rom e sinte a introiettare il senso di un’ineluttabile esclusione e a una profonda sfiducia nei confronti delle une e delle altre.
RDG:
Sovente, rom e sinti sono stati definiti “cittadini senza patria”. Non ritenete che questa definizione sia una negazione politica, culturale e sociale della loro esistenza? Un’espressione di etnocentrismo differenziale e razzista? E ancora: avere la lingua per patria non significa, forse, avere il mondo come patria? Nasce da qui il pacifismo assoluto dei rom, unico popolo a non aver mai condotto una guerra?
DP e PCN:
«Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà», questo verso di una canzone anarchica è da sempre l’essenza del popolo rom e insieme la sua condanna all’emarginazione nel mondo delle troppe patrie e delle troppe bandiere, ma è, nello stesso tempo, l’affermazione della sua esistenza politica, culturale, sociale. Il popolo delle cento tribù e dei cento dialetti e delle cento religioni è unito da questa profonda, istintiva certezza di essere ovunque a casa sua e questo gli impedisce di riconoscere i confini, di avere pretese territoriali e di fare la guerra per una patria perché la sua patria è più grande di tutte le patrie.
RDG:
I diritti dei rom e dei sinti all’abitazione, al lavoro, all’istruzione e alla salute sono quelli più violati, in Europa come in Italia. Non credete che queste violazioni siano forme avanzate e radicali di negazione del diritto all’esistenza? La crisi globale nega questi diritti perfino a fasce crescenti di cittadini autoctoni. Ai rom e ai sinti è applicata una strategia ancora più dura: l’elusione completa del riconoscimento giuridico. Sta nascendo contro i rom e i sinti un diritto-contro, esteso a livello globale e capillarizzato nei territori locali? Un diritto-contro che trasforma le cittadinanze imperfette in cittadinanze da cancellare?
DP e PCN:
È difficile rispondere a questa domanda con un sì o con un no. Si potrebbe dire che per rom e sinti non c’è niente di nuovo sotto il sole, a differenza delle altre minoranze che pur vittime di emarginazione sociale e culturale non subiscono le stesse forme di esclusione. Basti pensare che i rom italiani, che risiedono in Italia dal 1400, nelle statistiche scolastiche si trovano assimilati agli stranieri e che per loro solo in questi ultimi anni si pensa che possano abitare in case e non unicamente nei cosiddetti “campi nomadi”. Come sempre, la situazione è articolata e vista dall’Europa la contraddizione di fondo è tra le politiche generali proposte per l’inclusione e la realtà locale in peggioramento, di fronte all’asprezza della crisi che induce anche culture politiche come quella francese a espellere i rom dal Paese. L’unica cosa positiva è la capacità del popolo rom di sopravvivere, una capacità costruita nei secoli. Il problema da affrontare oggi è invece quello di vivere, di essere cioè una cittadinanza da riconoscere.
superare una teologia mummificata e lontana dalla vita – se lo dicono anche i vescovi italiani …
monsignor Galantino:
la teologia deve
“uscire,
annunciare,
abitare,
educare e
trasfigurare”
“Uscire dall’autoreferenzialità; annunciare la credibilità della fede che la informa; abitare spazi civili e sociali dai quali spesso si trova marginalizzata; educare a uno sguardo attento e critico sul ‘Dio per l’uomo’, sull’uomo stesso e sul mondo; trasfigurare la speculazione e il pensiero stesso per farne voce di una bellezza quasi sacramentale: quella della Parola che risuona, incessantemente, nelle parole umane”. Concludendo il suo intervento all’incontro di apertura del ciclo annuale di conferenze della Pontificia Università Gregoriana, monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha preso in prestito le cinque “vie” del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze per declinare il ruolo della teologia nella cultura contemporanea. “La teologia – la sua tesi di fondo – ha pieno diritto di parola in quella delicata operazione che è la legittimazione di un umanesimo in cui vi sia spazio per ricomporre i molti tratti di un’umanità dispersa nell’unico mosaico del volto di Cristo”. “Non si tratta di un’operazione ideologica o mossa da tendenze proselitistiche, né è in discussione la rispettabilità di opinioni e fedi diverse”, ha puntualizzato il vescovo: “Ad essere implicata è piuttosto la plausibilità di un pensiero cristiano sul fatto umano”
barricate italiane di fronte alla disperazione
barricate a Gorino
mons. Perego (Migrantes)
“un episodio preoccupante che mostra come l’aria di chiusura sta arrivando anche da noi”
“Dodici donne e otto bambini, donne sole e con i propri figli hanno trovato all’arrivo al comune di Gorino nel ferrarese – meno di 4mila abitanti, 1,6% di immigrati – la strada sbarrata e, soprattutto, le porte chiuse dell’ostello dove dovevano essere ospitati. È un episodio preoccupante, che avviene in una terra dove la solidarietà era sempre stata un elemento fondamentale anche perché dimostra una cattiva informazione sulle storie e le tragedie di chi sbarca; preoccupante infine perché dimostra l’incapacità delle istituzioni di preparare una comunità all’accoglienza, continuando ad improvvisare gli arrivi”.
A dirlo oggi il direttore generale della Fondazione Migrantes, monsignor Giancarlo Perego, commentando la protesta degli abitanti di Gorino, scesi in strada per impedire l’accesso in paese a 12 donne e 8 bambini, che il prefetto di Ferrara aveva destinato all’ostello del paese. 
“L’episodio – ha aggiunto monsignor Perego – è un segnale che dimostra come l’aria di chiusura e di ‘muri’ che si respira in altri Paesi europei sta arrivando anche nelle nostre città e nei nostri paesi, al punto tale che una Valle, con una delle oasi naturali del Po a protezione di flora e fauna, oggi arriva a non essere in grado di fare un gesto di ospitalità per proteggere donne e bambini in fuga da guerre, disastri ambientali e violenze. La nostra democrazia come la nostra sicurezza non si può difendere rifiutando il diritto all’ospitalità. In quelle famiglie in cammino ritroviamo in modi diversi la storia di fuga della famiglia di Nazareth”.