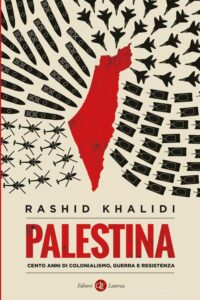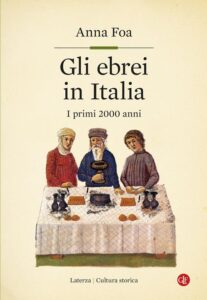un grande grazie a papa Francesco
«Signore Gesù, Tu che sei la luce del mondo,
ti ringraziamo per il dono di papa Francesco,
grazie per la sua testimonianza di semplicità
grazie per la sua attenzione agli ultimi, ai poveri, ai dimenticati
grazie per la capacità di parlare a tutti
grazie per il coraggio di andare controcorrente
grazie per la sapienza di chiamare bene il bene e male il male.
Signore Gesù, tu che ci hai fatto scoprire la misericordia,
insegnaci a capire e seguire la lezione di perdono
che ha contraddistinto tutta la vita di papa Francesco.
Aiutaci a capire che non esiste peccato,
che il Padre buono non perdoni.
E se qualche colpa papa Francesco ha commesso,
tu abbine misericordia in virtù della forza del suo amore.
Signore Gesù che sei amico e fratello di tutti,
grazie per l’umiltà di papa Francesco
grazie per l’insegnamento che non c’è nessun uomo
che possa essere considerato superiore agli altri
grazie per gli abbracci ai malati e ai dimenticati
grazie per averci fatto capire con papa Francesco
che dobbiamo amare chi nessuno ama.
Signore Gesù tu che sei il maestro della pace,
insegnaci a capire, come ha sempre detto papa Francesco
che non esiste nessuna guerra giusta
che ogni conflitto è sempre una sconfitta
che sparare in nome di Dio è una bestemmia
che bisogna cercare anche il più piccolo appiglio
per trasformare i pensieri bellicosi in sogno di pace.
Signore Gesù che ami la vita come nessuno,
insegnaci, come ha testimoniato papa Francesco
che non esiste nessuna esistenza
che non valga la pena di essere vissuta
che siamo tutti amati da Dio come figli unici
che ogni vita va custodita e difesa sempre
dal concepimento alla sua fine naturale.
Signore Gesù tu che ci chiedi di pregare sempre,
fa che impariamo sull’esempio di papa Francesco
il valore del dialogo tra le Chiese e le religioni
insegnaci a ripulire il nostro vocabolario
dalle parole che dividono e feriscono,
guidaci ad essere una comunità di credenti
che mettono Dio e non l’uomo al centro.
Signore Gesù tu che hai amato i poveri,
insegnaci a essere, come papa Francesco
uomini e donne che vivono l’essenziale
persone libere dalle schiavitù delle mode
e capaci di guardare agli altri non per ciò che hanno
ma per quello che sono e possono diventare
alla luce della speranza che nasce dalla fede.
Signore Gesù tu che ci aspetti tutti nel tuo Regno,
stringi nel tuo abbraccio papa Francesco,
e a noi che piangiamo la sua scomparsa
e sentiamo il vuoto della sua assenza
insegna a custodirne le parole e i gesti
perché forti del suo esempio e della sua testimonianza
sappiamo riconoscere in Te l’unico re della nostra vita.
Amen