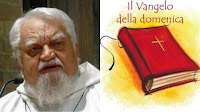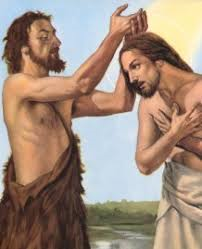le curie sono periciolose – parola di papa Francesco
papa Francesco
il “catalogo” delle malattie della curia
da ‘altranarrazione’ dicembre 23, 2016

introduzione:
Burocrazia e Vangelo non vanno d’accordo. Infatti il Vangelo vive nelle strade del mondo non nei palazzi. Collaborare alla costruzione del Sogno di Dio non è un lavoro d’ufficio. Non si può stare in giacca e cravatta né in clergyman perché per strada ci si sporca. Si è operai non amministrativi. Non c’è orario e non è possibile seguire un’agenda prestabilita. Infatti non si può dire al povero torna domani perché oggi c’è la riunione con la Caritas. Non si può dire al malato aspetta a soffrire perché oggi c’è la riunione sulla pastorale sanitaria. Non si può dire alla coppia di giovani precari tornate domani perché oggi c’è il convegno sull’indissolubilità del matrimonio. Dentro i palazzi la realtà si può vedere solo dalle finestre, dall’alto e da lontano. Lo scollamento deforma il giudizio e rende insensibili. Non si sa cos’è la disoccupazione, l’oppressione, l’emarginazione. Non si può essere solidali rimanendo al proprio tavolino, circondati solo dalle proprie sicurezze.

testo di papa Francesco
“La Curia è chiamata a migliorarsi, a migliorarsi sempre e a crescere in comunione, santità e sapienza per realizzare pienamente la sua missione. Eppure essa, come ogni corpo, come ogni corpo umano, è esposta anche alle malattie, al malfunzionamento, all’infermità. E qui vorrei menzionare alcune di queste probabili malattie, malattie curiali. Sono malattie più abituali nella nostra vita di Curia. Sono malattie e tentazioni che indeboliscono il nostro servizio al Signore. Credo che ci aiuterà il “catalogo” delle malattie – sulla strada dei Padri del deserto, che facevano quei cataloghi – di cui parliamo oggi: ci aiuterà a prepararci al Sacramento della Riconciliazione, che sarà un bel passo di tutti noi per prepararci al Natale.
- La malattia del sentirsi “immortale”, “immune” o addirittura “indispensabile” trascurando i necessari e abituali controlli. Una Curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi è un corpo infermo. Un’ordinaria visita ai cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi di tante persone, delle quale alcuni forse pensavano di essere immortali, immuni e indispensabili! È la malattia del ricco stolto del Vangelo che pensava di vivere eternamente (cfr Lc 12, 13-21) e anche di coloro che si trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio di tutti. Essa deriva spesso dalla patologia del potere, dal “complesso degli Eletti”, dal narcisismo che guarda appassionatamente la propria immagine e non vede l’immagine di Dio impressa sul volto degli altri, specialmente dei più deboli e bisognosi. L’antidoto a questa epidemia è la grazia di sentirci peccatori e di dire con tutto il cuore: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Lc 17, 10).
- Un’altra: La malattia del “martalismo” (che viene da Marta), dell’eccessiva operosità: ossia di coloro che si immergono nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, “la parte migliore”: il sedersi sotto i piedi di Gesù (cfr Lc 10,38-42). Per questo Gesù ha chiamato i suoi discepoli a “riposarsi un po’” (cfr Mc 6,31) perché trascurare il necessario riposo porta allo stress e all’agitazione. Il tempo del riposo, per chi ha portato a termine la propria missione, è necessario, doveroso e va vissuto seriamente: nel trascorrere un po’ di tempo con i famigliari e nel rispettare le ferie come momenti di ricarica spirituale e fisica; occorre imparare ciò che insegna il Qoèlet che «c’è un tempo per ogni cosa» (3,1-15).
- C’è anche la malattia dell’“impietrimento” mentale e spirituale: ossia di coloro che posseggono un cuore di pietra e un “duro collo” (At 7,51-60); di coloro che, strada facendo, perdono la serenità interiore, la vivacità e l’audacia e si nascondono sotto le carte diventando “macchine di pratiche” e non “uomini di Dio” (cfr Eb 3,12). È pericoloso perdere la sensibilità umana necessaria per farci piangere con coloro che piangono e gioire con coloro che gioiscono! È la malattia di coloro che perdono “i sentimenti di Gesù” (cfr Fil 2,5-11) perché il loro cuore, con il passare del tempo, si indurisce e diventa incapace di amare incondizionatamente il Padre e il prossimo (cfr Mt 22,34-40). Essere cristiano, infatti, significa «avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5), sentimenti di umiltà e di donazione, di distacco e di generosità.
- La malattia dell’eccessiva pianificazione e del funzionalismo. Quando l’apostolo pianifica tutto minuziosamente e crede che facendo una perfetta pianificazione le cose effettivamente progrediscano, diventando così un contabile o un commercialista. Preparare tutto bene è necessario, ma senza mai cadere nella tentazione di voler rinchiudere e pilotare la libertà dello Spirito Santo, che rimane sempre più grande, più generosa di ogni umana pianificazione (cfr Gv 3,8). Si cade in questa malattia perché «è sempre più facile e comodo adagiarsi nelle proprie posizioni statiche e immutate. In realtà, la Chiesa si mostra fedele allo Spirito Santo nella misura in cui non ha la pretesa di regolarlo e di addomesticarlo… – addomesticare lo Spirito Santo! – … Egli è freschezza, fantasia, novità».
- La malattia del cattivo coordinamento. Quando i membri perdono la comunione tra di loro e il corpo smarrisce la sua armoniosa funzionalità e la sua temperanza, diventando un’orchestra che produce chiasso, perché le sue membra non collaborano e non vivono lo spirito di comunione e di squadra. Quando il piede dice al braccio: “non ho bisogno di te”, o la mano alla testa: “comando io”, causando così disagio e scandalo.
- C’è anche la malattia dell’“alzheimer spirituale”: ossia la dimenticanza della “storia della salvezza”, della storia personale con il Signore, del «primo amore» (Ap 2,4). Si tratta di un declino progressivo delle facoltà spirituali che in un più o meno lungo intervallo di tempo causa gravi handicap alla persona facendola diventare incapace di svolgere alcuna attività autonoma, vivendo uno stato di assoluta dipendenza dalle sue vedute spesso immaginarie. Lo vediamo in coloro che hanno perso la memoria del loro incontro con il Signore; in coloro che non fanno il senso deuteronomico della vita; in coloro che dipendono completamente dal loro presente, dalle loro passioni, capricci e manie; in coloro che costruiscono intorno a sé dei muri e delle abitudini diventando, sempre di più, schiavi degli idoli che hanno scolpito con le loro stesse mani.
- La malattia della rivalità e della vanagloria. Quando l’apparenza, i colori delle vesti e le insegne di onorificenza diventano l’obiettivo primario della vita, dimenticando le parole di San Paolo: «Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,1-4). È la malattia che ci porta a essere uomini e donne falsi e a vivere un falso “misticismo” e un falso “quietismo”. Lo stesso San Paolo li definisce «nemici della Croce di Cristo» perché «si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra» (Fil 3,19).
- La malattia della schizofrenia esistenziale. E’ la malattia di coloro che vivono una doppia vita, frutto dell’ipocrisia tipica del mediocre e del progressivo vuoto spirituale che lauree o titoli accademici non possono colmare. Una malattia che colpisce spesso coloro che, abbandonando il sevizio pastorale, si limitano alle faccende burocratiche, perdendo così il contatto con la realtà, con le persone concrete. Creano così un loro mondo parallelo, dove mettono da parte tutto ciò che insegnano severamente agli altri e iniziano a vivere una vita nascosta e sovente dissoluta. La conversione è alquanto urgente e indispensabile per questa gravissima malattia (cfr Lc 15,11-32).
- La malattia delle chiacchiere, delle mormorazioni e dei pettegolezzi. Di questa malattia ho già parlato tante volte ma mai abbastanza. E’ una malattia grave, che inizia semplicemente, magari solo per fare due chiacchiere e si impadronisce della persona facendola diventare “seminatrice di zizzania” (come satana), e in tanti casi “omicida a sangue freddo” della fama dei propri colleghi e confratelli. È la malattia delle persone vigliacche che non avendo il coraggio di parlare direttamente parlano dietro le spalle. San Paolo ci ammonisce: «Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri» (Fil 2,14-18). Fratelli, guardiamoci dal terrorismo delle chiacchiere!
- La malattia di divinizzare i capi: è la malattia di coloro che corteggiano i Superiori, sperando di ottenere la loro benevolenza. Sono vittime del carrierismo e dell’opportunismo, onorano le persone e non Dio (cfr Mt 23,8-12). Sono persone che vivono il servizio pensando unicamente a ciò che devono ottenere e non a quello che devono dare. Persone meschine, infelici e ispirate solo dal proprio fatale egoismo (cfr Gal 5,16-25). Questa malattia potrebbe colpire anche i Superiori quando corteggiano alcuni loro collaboratori per ottenere la loro sottomissione, lealtà e dipendenza psicologica, ma il risultato finale è una vera complicità.
- La malattia dell’indifferenza verso gli altri. Quando ognuno pensa solo a sé stesso e perde la sincerità e il calore dei rapporti umani. Quando il più esperto non mette la sua conoscenza al servizio dei colleghi meno esperti. Quando si viene a conoscenza di qualcosa e la si tiene per sé invece di condividerla positivamente con gli altri. Quando, per gelosia o per scaltrezza, si prova gioia nel vedere l’altro cadere invece di rialzarlo e incoraggiarlo.
- La malattia della faccia funerea. Ossia delle persone burbere e arcigne, le quali ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malinconia, di severità e trattare gli altri – soprattutto quelli ritenuti inferiori – con rigidità, durezza e arroganza. In realtà, la severità teatrale e il pessimismo sterile sono spesso sintomi di paura e di insicurezza di sé. L’apostolo deve sforzarsi di essere una persona cortese, serena, entusiasta e allegra che trasmette gioia ovunque si trova. Un cuore pieno di Dio è un cuore felice che irradia e contagia con la gioia tutti coloro che sono intorno a sé: lo si vede subito! Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno di humor, e persino autoironico, che ci rende persone amabili, anche nelle situazioni difficili. Quanto bene ci fa una buona dose di sano umorismo! Ci farà molto bene recitare spesso la preghiera di san Thomas More: io la prego tutti i giorni, mi fa bene.
- La malattia dell’accumulare: quando l’apostolo cerca di colmare un vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando beni materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al sicuro. In realtà, nulla di materiale potremo portare con noi perché “il sudario non ha tasche” e tutti i nostri tesori terreni – anche se sono regali – non potranno mai riempire quel vuoto, anzi lo renderanno sempre più esigente e più profondo. A queste persone il Signore ripete: «Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo … Sii dunque zelante e convertiti» (Ap 3,17-19). L’accumulo appesantisce solamente e rallenta il cammino inesorabilmente! E penso a un aneddoto: un tempo, i gesuiti spagnoli descrivevano la Compagnia di Gesù come la “cavalleria leggera della Chiesa”. Ricordo il trasloco di un giovane gesuita che, mentre caricava su di un camion i suoi tanti averi: bagagli, libri, oggetti e regali, si sentì dire, con un saggio sorriso, da un vecchio gesuita che lo stava ad osservare: questa sarebbe la “cavalleria leggera della Chiesa?”. I nostri traslochi sono un segno di questa malattia.
- La malattia dei circoli chiusi, dove l’appartenenza al gruppetto diventa più forte di quella al Corpo e, in alcune situazioni, a Cristo stesso. Anche questa malattia inizia sempre da buone intenzioni ma con il passare del tempo schiavizza i membri diventando un cancro che minaccia l’armonia del Corpo e causa tanto male – scandali – specialmente ai nostri fratelli più piccoli. L’autodistruzione o il “fuoco amico” dei commilitoni è il pericolo più subdolo[15]. È il male che colpisce dal di dentro[16]; e, come dice Cristo, «ogni regno diviso in se stesso va in rovina» (Lc 11,17).
- E l’ultima: la malattia del profitto mondano, degli esibizionismi, quando l’apostolo trasforma il suo servizio in potere, e il suo potere in merce per ottenere profitti mondani o più poteri. È la malattia delle persone che cercano insaziabilmente di moltiplicare poteri e per tale scopo sono capaci di calunniare, di diffamare e di screditare gli altri, perfino sui giornali e sulle riviste. Naturalmente per esibirsi e dimostrarsi più capaci degli altri. Anche questa malattia fa molto male al Corpo perché porta le persone a giustificare l’uso di qualsiasi mezzo pur di raggiungere tale scopo, spesso in nome della giustizia e della trasparenza! E qui mi viene in mente il ricordo di un sacerdote che chiamava i giornalisti per raccontare loro – e inventare – delle cose private e riservate dei suoi confratelli e parrocchiani. Per lui contava solo vedersi sulle prime pagine, perché così si sentiva “potente e avvincente”, causando tanto male agli altri e alla Chiesa. Poverino!
Fratelli, tali malattie e tali tentazioni sono naturalmente un pericolo per ogni cristiano e per ogni curia, comunità, congregazione, parrocchia, movimento ecclesiale, e possono colpire sia a livello individuale sia comunitario. Occorre chiarire che è solo lo Spirito Santo – l’anima del Corpo Mistico di Cristo, come afferma il Credo Niceno-Costantinopolitano: «Credo… nello Spirito Santo, Signore e vivificatore» – a guarire ogni infermità. È lo Spirito Santo che sostiene ogni sincero sforzo di purificazione e ogni buona volontà di conversione. È Lui a farci capire che ogni membro partecipa alla santificazione del corpo e al suo indebolimento. È Lui il promotore dell’armonia[18]: “Ipse harmonia est”, dice san Basilio. Sant’Agostino ci dice: «Finché una parte aderisce al corpo, la sua guarigione non è disperata; ciò che invece fu reciso, non può né curarsi né guarirsi». La guarigione è anche frutto della consapevolezza della malattia e della decisione personale e comunitaria di curarsi sopportando pazientemente e con perseveranza la cura. Dunque, siamo chiamati – in questo tempo di Natale e per tutto il tempo del nostro servizio e della nostra esistenza – a vivere «secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità» (Ef 4,15-16)”.
dal Discorso di Papa Francesco per la presentazione degli auguri natalizi della curia romana, 22/12/2014
fermarsi è importante per ripartire meglio …
presa di coscienza
«Nel sistema, l’unico luogo possibile per l’epifania di Dio sono coloro che non-sono-sistema: l’altro dal sistema, il povero»
Enrique Dussel
Fermiamoci. Smettiamola di collaborare con un’organizzazione economico-sociale che devasta sia l’umanità sia il pianeta. Nulla giustifica l’ingiustizia nemmeno la propria sopravvivenza. Il fine infatti non giustifica i mezzi anche se a scuola ci hanno insegnato il contrario. Ci ritroviamo su un campo di battaglia con la lista dei nemici da abbattere. Ci mettono fretta, non abbiamo il tempo di verificare colpe e responsabilità. Agiamo su sentenze emesse da altri.
Fermiamoci. Smettiamola di invidiare i ricchi e il loro benessere sporco del sangue dei poveri, il vuoto in cui si alienano i personaggi famosi e le deformazioni ontologiche a cui si espongono gli arrampicatori sociali. Non c’è cosa più avvilente di un oppresso che desidera diventare come il suo padrone. La liberazione non consiste nel mettersi al posto dell’oppressore ma nel costruire una convivenza pacifica in cui ogni essere umano possa esprimersi e così realizzarsi. È utopia che attende volontà.
Fermiamoci. Smettiamola di obbedire agli ordini che contrastano con la nostra coscienza. Dobbiamo formarci con spirito di iniziativa, da autodidatti, evitando di abbeverarci ai pozzi avvelenati dal Sistema. Dobbiamo uscire dal pantano del gossip, dall’insulto alla morale rappresentato dal calcio milionario e dedicarci alla preghiera e all’analisi. Abbandoniamo la stampa prezzolata e riflettiamo sulla lettera ai giudici di don Milani e sui discorsi di Calamandrei. Abbandoniamo le trasmissioni-spazzatura e leggiamo le omelie di Oscar Romero e i testi di Ignacio Ellacuría. Perché se non conosciamo le lettere dei condannati a morti della resistenza non conosciamo la libertà e non la meritiamo. Perché se non conosciamo il martirio di Iqbal Masih non conosciamo la dignità e non la meritiamo.
Fermiamoci. Smettiamola di produrre debito, non solo finanziario, ma soprattutto ecologico e umanitario. Saremo ricordati dalle generazioni future per le nostre discariche difficilmente trasportabili in musei (e comunque non molto attraenti per i turisti), per aver sostituito il plancton con la plastica e per aver spostato i campi di concentramento e di sterminio in mare.
Fermiamoci e ricominciamo su basi totalmente nuove
Dal Vangelo e dalle Costituzioni nella loro sostanza autentica
il commento al vangelo della domenica
attenti al pallone … non sembra ma è pericoloso!
pallone gonfiato
«I 1000 individui più ricchi del mondo hanno un patrimonio netto di poco inferiore al doppio del patrimonio totale dei 2,5 miliardi di individui più poveri»
Luciano Gallino
Finalmente sono iniziate le partite del mondiale di calcio
Così posso distrarmi dai problemi personali e sociali, ma soprattutto identificarmi con vincenti, milionari e stelle del firmamento. Questo evento cambia davvero la mia capacità di percezione del mondo. Nei giorni del torneo mi sembra tutto più bello, significativamente diverso, vedo le cose con occhi nuovi.
L’attività compiuta dalla camorra in discariche abusive non mi appare più come sversamento di rifiuti tossici, pericolosi per la salute dei cittadini presenti e futuri, ma come deposito prolungato e sistematico di materiale ecologico riutilizzabile, dopo qualche anno, per la fangoterapia nei centri benessere.
Il colore rosso nell’aria di Taranto e quella sensazione di respirare ferro non mi appaiono più come conseguenze dell’inquinamento industriale, ma come il risultato della simultanea e multiforme accensione di fumogeni a scopo celebrativo.
La fila multioraria al pronto soccorso non mi appare più come una disfunzione, generata dalla politica, del sistema sanitario pubblico, ma come un tentativo di organizzare spazi di socializzazione, di condivisione delle preoccupazioni legate alla salute e di scambio di informazioni su diagnosi e cure.
La precarietà di milioni di persone non mi appare più come un fenomeno endemico ad un sistema economico-sociale basato sullo sfruttamento della manodopera, ma come opportunità di festeggiamento, ogni 15 giorni circa, per la firma di un nuovo contratto di lavoretto.
La disoccupazione di milioni di persone non mi appare più come tragedia determinata dalla politica che si inginocchia (per tornaconto) davanti al Capitale, ma come occasione di tempo libero per visitare centri per l’impiego, siti internet con offerte di lavoro, e per perfezionarsi nella compilazione del CV.
Grazie al pallone gonfiato nulla è come sembra.
la paura è una brutta consigliera … costruire ‘comunità accoglienti’
comunità accoglienti
uscire dalla paura
lettera alle comunità cristiane
a 25 anni dal documento “Ero forestiero e mi avete ospitato” (1993-2018)

- Introduzione
Venticinque anni fa, la Commissione ecclesiale per le migrazioni pubblicava il documento Ero forestiero e mi avete ospitato, interpretando e accompagnando il fenomeno dell’immigrazione nei suoi inizi e sviluppi in Italia “con gli occhi della fede”. A venticinque anni di distanza avvertiamo la necessità, come pastori, di condividere una riflessione sul tema dell’immigrazione: parola di aiuto al discernimento comunitario, di stimolo a rendere la nostra fede capace, ancora una volta, di incarnarsi nella storia, di gratitudine e di incoraggiamento a quelle comunità che già hanno accolto.
Ciò che ci spinge a prendere nuovamente la parola è il profondo cambiamento che in questi anni continua a segnare il fenomeno migratorio nel nostro Paese, per rispondere nuovamente alla domanda del Signore a Caino, richiamata da papa Francesco nel suo viaggio a Lampedusa: “Dov’è tuo fratello?” (Gn 4,9).
- L’immigrazione nel 1993
L’immigrazione nel 1993 era un fenomeno “nuovo” ed emergente, di cui non si riusciva ancora a cogliere le dimensioni e le prospettive. Secondo i dati del Ministero dell’Interno gli immigrati regolari in Italia erano infatti 987.405, in maggioranza europei dell’Unione Europea e dell’Europa orientale (36,85%); seguivano gli africani (29,13%), gli asiatici (17,47%) e gli americani (15,95%); 559.294 erano stati i permessi di soggiorno per lavoro e 144.410 per ricongiungimento familiare; 7.476 le richieste d’asilo, 65.385 erano gli studenti nelle scuole1; 10.000 i matrimoni misti e tra stranieri (3% del totale); 17.000 i nati nelle famiglie con almeno un genitore straniero2.
-
L’immigrazione nel 2018
Dal 1993 ad oggi l’immigrazione è diventata nel nostro Paese un fenomeno sorprendente nel suo incremento, anche se negli ultimi anni esso si è fermato ed è aumentato invece il numero degli emigranti italiani.
3. Alla fine del 2017 erano in accoglienza nel nostro Paese 183.681 richiedenti asilo e rifugiati: appena il 3 per mille dei residenti4.
nei cinque continenti alla ricerca di un lavoro e di una vita dignitosa.
-
Immigrazione, sfida pastorale

Nel Messaggio per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 papa Francesco, in continuità con il Magistero di Papa Benedetto e del Santo Papa Giovanni Paolo II, ha ribadito che «tutti i credenti e gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie responsabilità»6. I Vescovi italiani – negli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 – hanno ricordato che il fenomeno delle migrazioni è «senza dubbio una delle più grandi sfide educative»7. Siamo consapevoli che nemmeno noi cristiani, di fronte al fenomeno globale delle migrazioni, con le sue opportunità e i suoi problemi, possiamo limitarci a risposte prefabbricate, ma dobbiamo affrontarlo con realismo e intelligenza, con creatività e audacia, e al tempo stesso, con prudenza, evitando soluzioni semplicistiche. Riconosciamo che esistono dei limiti nell’accoglienza. Al di là di quelli dettati dall’egoismo, dall’individualismo di chi si rinchiude nel proprio benessere, da una economia e da una politica che non riconosce la persona nella sua integralità, esistono limiti imposti da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose. Siamo, inoltre, consapevoli che il periodo di crisi che sta ancora attraversando il nostro Paese rende più difficile l’accoglienza, perché l’altro è visto come un concorrente e non come un’opportunità per un rinnovamento sociale e spirituale e una risorsa per la stessa crescita del Paese. «L’opera educativa – hanno ricordato sempre i Vescovi italiani – deve tener conto di questa situazione e aiutare a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione. Particolare attenzione va riservata al numero crescente di minori, nati in Italia, figli di stranieri»8. Per quanto riguarda nello specifico l’educazione dei giovani all’integrazione, sembra importante richiamare qui il ruolo che potrebbero avere alcune delle realtà che ruotano attorno alle parrocchie, in particolare quella degli oratori e dell’associazionismo.
Vogliamo ricordare inoltre che il primo diritto è quello di non dover essere costretti a lasciare la propria terra. Per questo appare ancora più urgente impegnarsi anche nei Paesi di origine dei migranti, per porre rimedio ad alcuni dei fattori che ne motivano la partenza e per ridurre la forte disuguaglianza economica e sociale oggi esistente.
-
“Siate premurosi nell’ospitalità” (Rm 12,13)
La realtà del fenomeno, la sua complessità, le domande che suscita, chiedono alle nostre comunità di avviare “processi educativi” che vadano al di là dell’emergenza, verso l’edificazione di comunità accoglienti capaci di essere “segno” e “lievito” di una società plurale costruita sulla fraternità e sul rispetto dei diritti inalienabili di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco nella Evangelii gaudium: «Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci»9.
a. Le migrazioni “segno dei tempi”
Un processo che inizia con un atto di umiltà e di ascolto di ciò che l’immigrazione, con i suoi volti, le sue storie, le sue domande dice a noi, comunità cristiane. Si tratta di cogliere le migrazioni come “un segno dei tempi”10, come hanno ricordato gli ultimi Pontefici: un luogo frequentato da Dio, che chiede al credente di “osare” la solidarietà, la giustizia e la pace.
Leggere le migrazioni come “segno dei tempi” richiede innanzitutto uno sguardo profondo, uno sguardo capace di andare oltre letture superficiali o di comodo, uno sguardo che vada “più lontano” e cerchi di individuare il perché del fenomeno. Prima ancora di “aprire” o “chiudere” gli occhi davanti allo straniero è necessario interrogarsi sulle cause che lo muovono, anche se – e forse proprio perché – oggi appare più difficile che mai riuscire a distinguere quanti fuggono da guerre e persecuzioni da quanti sono mossi dalla fame o dai cambiamenti climatici. Papa Francesco ci ricorda la necessità di «avere “una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi”. Si tratta di una responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione da cui poi è difficile tornare indietro»11. Si tratta di prendere coscienza dei meccanismi generati da un’economia che uccide e della inequità che genera violenza: «Quando la società – locale, nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità»12. Significa riscoprire la capacità di pensare in grande per agire “politicamente” in senso forte e responsabile, così da colpire efficacemente, ovunque si trovino, poteri e persone che prosperano sulla morte degli altri, cominciando dai trafficanti di armi fino a quelli di esseri umani.
b. Uno sguardo purificato
Occorre avere uno sguardo diverso di fronte a coloro che bussano alle nostre porte, che inizia da un linguaggio che non giudica e discrimina prima ancora di incontrare. I termini stessi che spesso ancora utilizziamo per parlare di immigrati (clandestini, extracomunitari…) portano in sé una matrice denigratoria Se noi siamo parte di una comunità, essi ne sono esclusi.
c. Per una “convivialità delle differenze”
Incontrare un immigrato significa fare i conti con la diversità. La prima diversità è quella fisica, la più visibile: «La sua singolarità colpisce: quegli occhi, quelle labbra, quegli zigomi, quella pelle diversa dalle altre lo distinguono e ricordano che si ha a che fare con qualcuno. […] quel volto così altro porta il segno di una soglia»13. Egli è l’altro, non è colui che scegliamo di invitare a casa nostra, bensì colui che si erge, non scelto, davanti a noi: è colui che giunge a noi portato semplicemente dall’accadere degli eventi.
In questo incontro emerge la paura. Anzi, due paure si ritrovano a confronto: la mia paura e quella che prova lo straniero. La sua paura è quella di chi è venuto in un mondo a lui radicalmente estraneo, dove non è di casa e non ha casa, un mondo di cui non conosce nulla. La mia è quella di ritrovarmi di fronte ad uno sconosciuto che è entrato nella “mia” terra, che è presente nel “mio” spazio e che, nonostante sia solo, mi lascia intravvedere che forse molti altri lo seguiranno. «Queste paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l’odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all’incontro con l’altro, all’incontro con il diverso, all’incontro con il prossimo, che di fatto è un’occasione privilegiata di incontro con il Signore»14.
d. Dalla paura… all’incontro
Tutto questo lo sanno bene quelle comunità e parrocchie che in questi anni hanno deciso in vario modo di accogliere, anche a seguito dell’appello di papa Francesco del settembre 2015, appello che sta ancora producendo i suoi frutti. Per questo è nostra intenzione promuovere nei primi mesi del prossimo anno un meeting di queste realtà di accoglienza.
e. Dall’incontro… alla relazione
Da un incontro vero nasce la relazione e il dialogo: non più una semplice conoscenza dell’altro, non più solo un confronto di identità, ma una conoscenza “simpatica” dei valori dell’altro. Un dialogo che non ha come fine l’uniformità, ma il camminare insieme, il ricercare un “con-senso”, un senso condiviso a partire da presupposti differenti. è nel dialogo, allora, che si modificano i pregiudizi, le immagini, gli stereotipi, e siamo indotti a riflettere sui nostri condizionamenti culturali, storici, psicologici, sociologici: siamo interrogati sulle nostre certezze e sulla nostra identità. Nel dialogo, aperto alle persone di altre Chiese e di altre religioni, si allarga anche la comunione e la fraternità. Questo è l’inizio di un cammino che può trasformare la possibilità della convivenza in una scelta consapevole. L’immigrazione, con le reazioni di rigetto che talvolta suscita, mette in luce un atteggiamento presente nelle società occidentali e che non le è direttamente connesso: il crescente individualismo, che sempre più spesso si manifesta anche fra connazionali e addirittura all’interno delle famiglie.
f. Dalla relazione… all’interazione
la partecipazione attiva di tutti alla vita economica, produttiva, sociale, culturale e politica, avviando processi di cittadinanza e non soltanto di mera ospitalità. «In conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa – scrive papa Francesco – è disponibile ad impegnarsi in prima persona per realizzare tutte le iniziative (…), ma per ottenere i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità politica e della società civile, ciascuno, secondo le responsabilità proprie»16. L’opera della Chiesa nel campo della mobilità umana non può che essere sussidiaria all’azione dello Stato e delle istituzioni internazionali.
-
Conclusione
«La civiltà ha fatto un passo decisivo – scriveva il cardinale e teologo Jean Daniélou – forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero, da nemico (hostis) è divenuto ospite (hospes) […]. Il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo»17. È il passo che le nostre comunità devono saper compiere, non dimenticando l’importanza dell’ospitalità che porta all’incontro: «Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2).
Roma, 20 maggio 2018
Solennità di Pentecoste
CEMi – Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI
1 I dati riportati sono presenti in: Caritas di Roma, Dossier Statistico Immigrazione 1994, Anterem Edizioni Ricerca, Roma, 1994.
2Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese 1994.
3 I dati riportati sono presenti in: Caritas e Migrantes, Rapporto Immigrazione 2016, Tau Editrice, Todi (PG), 2017.
4 Fondazione Migrantes, Il Diritto d’Asilo 2018 “Accogliere, proteggere, promuovere, integrare”, Tau Editrice, Todi (PG), 2018.
5 Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2017, Tau Editrice, Todi (PG), 2017.
6 Papa Francesco, Messaggio per la 104a Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018.
7 Cei, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma, 2010, n. 14.
8 Ibidem.
9 Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 222.
10Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2006.
11 Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 51.
12 Ivi, n. 59.
13 J. Kristeva, Stranieri a noi stessi. L’Europa, l’altro, l’identità, Donzelli, Milano 2014, p. 7.
14 Papa Francesco, Omelia 14 gennaio 2018.
15 «Intesa come processo bidirezionale che riconosce e valorizza la ricchezza della cultura dell’altro» (Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, Rispondere ai rifugiati e ai migranti. Venti punti di azione pastorale, 2018).
16 Papa Francesco, Messaggio per la 104a Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018.
17 J. Danielou (1905-1974), Pour une théologie de l’hospitalité, in La vie spirituelle 367 (1951), p. 340.
se non hai soldi puoi crepare …
l’alba dei migranti
«Quale diritto avete di opprimere il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri?»
profeta Isaia 3,15

Sei malato, ma devi dormire fuori perché non hai i documenti e neanche i soldi.
Non basta la malattia, il bisogno; ci vogliono i documenti o almeno i soldi.
Infatti, se hai i soldi, anche malato e senza documenti, un posto te lo trovano.
Nel cuore dell’Impero (e dicono del cristianesimo) funziona così: i documenti contano più della malattia e del bisogno. E i soldi contano più dei documenti, della malattia e del bisogno.
Gli abitanti felici di questo inferno la chiamano legalità: che hanno promosso a quarta virtù teologale accanto alla fede, alla speranza e alla carità. Sulle ultime tre un compromesso si trova ma sulla legalità sono rigidi. È ammessa solo una deroga: i soldi.
Gli abitanti felici di questo inferno difendono il decoro: che sei tu a violare dormendo sui cartoni, non loro a lasciarti fuori.
Sei malato, non hai documenti e neanche i soldi.
Quindi dormi fuori.
Domani l’alba arriverà solo per te. Per gli abitanti dell’inferno infatti è sempre notte.
la vera motivazione di Francesco d’Assisi e di papa Francesco
Francesco d’Assisi: alterità e identità
«Quando crollano i beni di un istituto religioso, io dico: “Grazie, Signore!”, perché questi incominceranno ad andare sulla via della povertà e della vera speranza nei beni che ti dà il Signore»
papa Francesco
La povertà di Francesco era diversa da quella dei suoi contemporanei: non era protesta verso i ricchi né riflessione sociologica.
 Francesco non ne sapeva niente di queste cose: giovane commerciante di stoffe, desiderava solo vestirsi come il suo Dio. Quel Signore che indossa la povertà con i poveri; la misericordia con i peccatori; la compassione con i deboli; la vicinanza con i lontani.
Francesco non ne sapeva niente di queste cose: giovane commerciante di stoffe, desiderava solo vestirsi come il suo Dio. Quel Signore che indossa la povertà con i poveri; la misericordia con i peccatori; la compassione con i deboli; la vicinanza con i lontani.
Quel Signore che indossa una tunica, senza sandali né bastone e va per le strade augurando la pace.
papa Francesco sta cambiando la chiesa
“il papato sta cambiando”
José María Castillo
dal blog di José Maria Castillo in “Religión Digital” dell’8 giugno 2018

Senza che noi cristiani ce ne rendiamo conto, stiamo assistendo a quello che molti non si immaginano: papa Francesco, senza toccare il «dogma», sta cambiando il papato.
Mi spiego. Contro coloro che attaccano l’ortodossia e la rettitudine di papa Francesco, la mia coscienza mi dice che non debbo tacere. Si tratta di qualcosa di fondamentale per il papato e quindi anche per la Chiesa. Per questo voglio e debbo affermare quello che spiego qui di seguito.
Questo papa non ha toccato nessun «dogma di fede divina e cattolica», così come questa questione fondamentale è stata espressa e definita nel concilio Vaticano I (costituzione dogmatica Dei Filius, cap. 3, Denz 3011). Per questo insisto sul fatto che papa Francesco sta cambiando il papato non per quello che dice, ma per la sua maniera di vivere.
Cosa significa questo? Il Vangelo prima di tutto non è una «dottrina religiosa», ma è soprattutto un «progetto di vita». E sottolineo il fatto fondamentale che ogni cristiano sia certo che il centro del Vangelo non è la «fede» in Gesù, ma la «sequela» di Gesù. Ma è successo che la teologia ed il governo della Chiesa hanno posto il centro del cristianesimo nell’«ortodossia della fede» ed hanno spostato la «sequela di Gesù» nell’ambito della spiritualità. Ebbene, stando così le cose, si capisce quello che sta succedendo nella Chiesa. Il Magistero della Chiesa può controllare (e controlla) la «dottrina della fede». Quello che non può e non ha motivo di controllare è la «generosità della sequela» di Gesù.
Ebbene, in una Chiesa che funziona così, è capitato quello che doveva capitare. L’ortodossia religiosa si è preoccupata fino all’eccesso di considerare come dottrine di fede non poche cose che non appartengono alla fede. Mentre la sequela di Gesù si considera come un tema relativo alla generosità dei più ferventi.
C’è un vuoto enorme nella Chiesa. Un vuoto che non si spiega alla gente. Se leggiamo i vangeli con attenzione, quello che vi si sottolinea è che, quando Gesù si riferisce alla fede dei discepoli e degli apostoli, lo fa per rimproverarli per la loro vigliaccheria, la loro paura, i loro dubbi e la loro incredulità (Mt 8, 26; 14, 31; 16, 8; 17, 20; Mc 4, 40; 16, 11.13.14; Lc 8, 25; 24,11.41; Gv 20, 25-31).
Tuttavia Gesù è stato sempre rispettoso e tollerante con quegli uomini che avevano una fede così piccola, più piccola di un granello di senape (Mc 11, 23 par; Mt 21, 21; 17, 20; Lc 17, 6). Molto diverso è stato il problema della «sequela». In questa questione Gesù è stato esigente ed intollerante fino a livelli che fanno impressione e non sono facili da comprendere. Gesù esige di lasciare tutto di fronte ad una sola parola: «Seguimi». Senza spiegazioni, ragioni o motivi. Famiglia, casa, denaro, attività…, qualunque sia. Tutto si subordina alla chiamata di Gesù. Non per avere alcune credenze o osservanze religiose. Ma per vivere il «progetto di vita» che Gesù ha vissuto. Nella maniera in cui ognuno possa fare questo.
E questo sta facendo papa Francesco. Che è l’ultima parola che Gesù ha detto a san Pietro: «Tu seguimi» (Gv 21, 22). È vero: il papato sta cambiando. Dai papi che centravano tutto nel comandare nella fede degli altri al papa che centra tutto nel seguire Gesù, facendo quello che ha fatto Gesù: aiutare coloro che soffrono, stare con quelli con cui nessuno vuole stare, realizzando ogni giorno (nella maniera in cui questo sia possibile) il «progetto di vita» che ha vissuto Gesù.
Il papato sta cambiando. Non perché papa Francesco stia modificando quello in cui bisogna credere. E non perché stia riformando la Curia Vaticana. Tutto questo non cambia il papato e non cambia la Chiesa. Il cambiamento si realizzerà quando le cose si metteranno al loro posto. La fede come deve essere e dove deve stare. Ed al centro di tutto la sequela di Gesù. Come lo stesso Gesù ha lasciato detto nel Vangelo. E questo sta facendo (senza dirlo) papa Francesco.
Con l’ortodossia della fede tutto continua e continuerà così come sta continuando. La sequela di Gesù ed il suo Vangelo ci fanno tanta paura che è normale abbandonare la proposta di Gesù e continuare con la nostra (grande o piccola) ricchezza. Come ha fatto quel giovane di cui raccontano i vangeli.