
un altro papato per il XXI secolo
Nel 1995, Giovanni Paolo II, nell’enciclica Ut unum sint, espresse la volontà di cercare un nuovo modo di esercitare il primato del vescovo di Roma come ministero di comunione di tutte le Chiese. La proposta suscitò grande interesse, ma ben presto venne dimenticata.
Nelle pagine che seguono indicherò gli elementi centrali del documento e ne analizzerò criticamente i presupposti teologici. Non appaiono forse troppo radicati nel passato? Nell’Ut unum sint il vescovo di Roma non appare ancora prigionero del papato? La tesi è semplice: per avanzare – «Tu seguimi» (Gv 21,22) – verso una comunione delle Chiese nel XXI secolo è imprescindibile riformare interamente l’immaginario e il quadro concettuale e istituzionale della Chiesa e dei ministeri. E così reimmaginare un altro “ministero di Pietro”, liberato dall’“ordine sacro”, dalla “successione” e da Roma.
1. La novità e l’ambiguità della vita
Ut unum sint (Perché siano uno) è un’enciclica sull’“impegno ecumenico” e si presenta come un commento sul Decreto del Concilio Vaticano II Unitatis redintegratio (1964), da cui è ripresa quasi la metà delle 162 citazioni. Il suo interesse, tuttavia, è centrato sul passato, il maggiore problema dell’ecumenismo.
Il ministero del vescovo di Roma, riconosce l’enciclica, «costituisce una difficoltà per la maggior parte degli altri cristiani, la cui memoria è segnata da certi ricordi dolorosi» (UUS 88). Bisognerebbe piuttosto dire “la” difficoltà, come affermò apertamente Paolo VI nel 1967: «Il papa, lo sappiamo, è senza dubbio l’ostacolo più grave sul cammino dell’ecumenismo».
(…). Negli anni ’90 del XX secolo, dopo tre decenni post-conciliari di impegno più o meno ottimistico, tutti gli sforzi ecumenici si erano ripetutamente incagliati sulla “roccia di Pietro”, o, meglio, sulla roccia del papato vaticano. Le commissioni teologiche interecclesiali arrivavano senza grosse difficoltà ad accordi basilari rispetto ai grandi dibattiti che ci avevano diviso in passato: il Filioque, la giustificazione, i sacramenti, Maria… Bastavano la buona volontà e la lettura critica dei testi fondanti del cristianesimo, soprattutto del Nuovo Testamento. Neppure un certo primato simbolico del vescovo di Roma appariva come un ostacolo insormontabile: le Chiese ortodosse non hanno mai avuto alcun problema ad accettarlo, purché non consistesse in un primato giurisdizionale, e qualcosa di simile si potrebbe dire anche della Chiesa luterana. Ma il dialogo falliva nel momento in cui Roma rivendicava un primato inteso come potere giurisdizionale sulle altre Chiese. Lì non era più possibile andare avanti. Il problema è il papato.
In maniera inattesa, lo stesso Giovanni Paolo II, il papa conservatore e inflessibile, arrivò infine a riconoscerlo nell’enciclica. Dopo aver evidenziato insistentemente il ruolo vitale e insostituibile del vescovo di Roma nella vera comunione di tutte le Chiese, egli afferma: «Sono convinto di avere a questo riguardo una responsabilità particolare, soprattutto nel constatare l’aspirazione ecumenica della maggior parte delle Comunità cristiane e ascoltando la domanda che mi è rivolta di trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova» (UUS 95).
È per questa frase che si cita e si continuerà a citare l’enciclica. La sorpresa e l’interesse suscitati da queste parole furono considerevoli. Un papa di radicate posizioni tradizionaliste rivendicava la necessità di ripensare la figura del vescovo di Roma, la sua funzione nella Chiesa. Questa frase constituisce la principale o unica novità dell’enciclica, l’unico passo avanti in relazione alla Costituzione conciliare Lumen gentium sulla Chiesa e al Decreto conciliare Unitatis redintegratio sull’ecumenismo.
Ma in che consiste propriamente “l’essenziale” del primato o della missione del vescovo di Roma? È questo il nodo della questione che l’enciclica lascia praticamente intatto. La sezione dedicata alla funzione del papa nel cammino ecumenico verso la comunione si apre con questa frase: «La Chiesa cattolica è consapevole di aver conservato il ministero del Successore dell’apostolo Pietro, il Vescovo di Roma, che Dio ha costituito quale “perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità”» (UUS 88).
I termini impiegati sono quanto mai ambigui e confusi tanto dal punto di vista storico quanto da quello teologico, ma l’enciclica non li chiarisce né li giustifica; li dà per scontati come se sapessimo cosa significano. Li stabilisce come fondamento senza fondarli.
Si capisce bene come tutti i tentativi portati avanti da allora per proporre una nuova forma di esercizio del “primato” romano siano falliti (…). Tutto si limitava a vaghe promesse intorno alla sinodalità e a disquisizioni senza fine su ciò che significano il primato e l’infallibilità.
E si comprende come, dieci anni dopo la Ut unum sint, il cardinal Kasper facesse propria l’espressione utilizzata da Paolo VI nel 1967, tornando a riconoscere che il papato è il «maggior ostacolo per la piena comunione ecumenica». Oggi, 21 anni dopo l’enciclica, constatiamo che non si è mosso alcun passo avanti per rendere effettiva la volontà di «trovare una forma di esercizio del primato che… si apra ad una situazione nuova».
È come se non si sapesse verso dove avanzare. Ma l’enciclica indica una direzione: il passato. È la direzione corretta?
2. È sufficiente tornare al primo millennio?
Ut unum sint propone come modello da seguire la relazione tra le Chiese di Oriente e di Occidente durante il primo millennio, prima della divisione del 1054, dando per scontato che tutte le Chiese in questo arco di tempo riconoscessero il vescovo di Roma como garante ultimo della piena comunione: «Il cammino della Chiesa è iniziato a Gerusalemme il giorno di Pentecoste e tutto il suo originale sviluppo nell’oikoumene di allora si concentrava attorno a Pietro e agli Undici (cfr. At 2,14). Le strutture della Chiesa in Oriente e in Occidente si formavano dunque in riferimento a quel patrimonio apostolico. La sua unità, entro i limiti del primo millennio, si manteneva in quelle stesse strutture mediante i Vescovi, successori degli Apostoli, in comunione con il Vescovo di Roma. Se oggi noi cerchiamo, al termine del secondo millennio, di ristabilire la piena comunione, è a questa unità così strutturata che dobbiamo riferirci» (UUS 55).
Bisogna riconoscere la carica innovativa legata al fatto di proporre il primo millennio come modello per l’esercizio attuale del primato romano. Nel primo millennio non esistevano ancora i dogmi del primato di giurisdizione e dell’infallibilità, che furono definiti dal Concilio Vaticano I nel 1870! Il papa stava pensando forse di revocarli? Sarebbe stato inimmaginabile per qualunque papa e, se possibile, ancora di più per Giovanni Paolo II. Più ragionevole pensare che si riferisse al primato e all’infallibilità secondo il modello del primo millennio, ma «senza rinunciare all’essenziale».
E qui torniamo all’impasse di sempre: in cosa consiste l’essenziale di questi dogmi? È possibile trovare nel primo millennio una qualche “struttura” unanimemente accettata dalle Chiese assimilabile al primato di giurisdizione e all’infallibilità?
(…). Lasciamo, allora, parlare la storia (…):
– fino agli ultimi decenni del II secolo, la Chiesa di Roma, formata da diverse chiese o comunità, non era retta da alcun “vescovo”, ma da un “collegio di presbiteri”;
– godeva tra tutte le Chiese di prestigio e di autorità morale particolari, a causa del fatto che lì si conservavano la tomba e la memoria di Pietro e di Paolo (morti a Roma probabilmente durante la persecuzione di Nerone dell’anno 64) e della generosità di cui dava prova nel sostenere economicamente altre Chiese più povere (…), oltre, senza dubbio, al fatto che Roma era la capitale dell’Impero (“città eterna” e “caput mundi”);
– verso la fine del II secolo, Ireneo di Lione (…) riconosceva alla Chiesa di Roma il “primato”, ma non la potestà di intervenire in altre Chiese e la stessa cosa insegnerà San Cipriano, vescovo di Cartagine, alla fine del III secolo;
– dalla fine del II secolo, i vescovi di Roma cominciarono a intervenire, ma risulta che tale intervento spesso non venisse accettato (…);
– a partire dal III secolo, si scatenò una grande lotta per il potere tra le grandi metropoli dell’impero (…);
– il prestigio e l’autorità di Roma aumentarono sensibilmente con la cristianizzazione dell’intera città, e ancora di più allorché il vescovo, dopo l’abbandono di Roma da parte dell’imperatore e il suo trasferimento a Ravenna, assunse in qualche modo il ruolo e gli attributi dell’imperatore, come pontifex maximus; (…) benché vescovi come San Basilio e Sant’Ambrogio non ammettessero la volontà di controllo di Roma sui vescovi;
– il Concilio di Calcedonia (451), lo stesso che definì la dottrina di Cristo come una persona con due nature, riconobbe al vescovo di Costantinopoli l’uguaglianza di diritti con il vescovo di Roma, ma tale canone non venne riconosciuto da Leone Magno, vescovo di Roma tra il 440 e il 461, che può essere definito come il “primo papa”: il primo a chiamarsi “vicario di Pietro”, a elaborare la dottrina della “successione di Pietro” e a rivendicare la “pienezza del potere” per intervenire in tutte le Chiese e in tutte le questioni (…).
Il problema è che la UUS si appella alla storia, ma questa non avalla le affermazioni generiche sull’esistenza, fin dal principio, di una struttura di comunione di tutte le Chiese intorno al vescovo di Roma. (…).
Richiama l’attenzione, inoltre, e ci mette in guardia, il fatto che UUS 55, che si riferisce esplicitamente a Unitatis redintegratio n. 14, non citi la frase iniziale di questo paragrafo: «Le Chiese d’Oriente e d’Occidente hanno seguito per molti secoli una propria via, unite però dalla fraterna comunione nella fede e nella vita sacramentale, sotto la direzione della Sede romana di comune consenso accettata, qualora fra loro fossero sorti dissensi circa la fede o la disciplina». Una frase che menziona due degli elementi storici indiscutibili della relazione tra le diverse Chiese: la loro diversità («hanno seguito per molti secoli una propria via») e il «comune consenso» nel ricorrere all’arbitrato della Chiesa di Roma. Ut unum sint fa un passo indietro rispetto all’Unitatis redintegratio.
Ma (…) anche nell’ipotetico caso in cui il vescovo di Roma avesse esercitato fin dal principio una reale potestà su tutte le altre Chiese e questa fosse stata effettivamente riconosciuta da tutte, saremmo per questo obbligati a riprodurre oggi le strutture di un passato remoto? Non possiamo ignorare o relegare il passato al momento di ricostruire la comunione delle Chiese nel presente, ma la fedeltà al passato non consiste nel riprodurlo servilmente, bensì nel lasciarsene ispirare per avanzare creativamente verso un’altra Chiesa, altri ministeri, un altro modello di comunione.
(…). Essere fedeli allo Spirito che ha guidato le Chiese dell’antichità significa continuare ad andare avanti, aprendo cammini inediti come hanno fatto quelle.
3. E cosa dire della «volontà di Cristo»?
Noi cristiani torniamo a Gesù – a ciò che egli ha detto, fatto, voluto – per orientare le nostre vite, per costruire il futuro giusto e libero da lui atteso, annunciato, anticipato. La storia di Gesù, trasformatrice della storia, è il criterio della nostra prassi personale ed ecclesiale. Ci riferiamo alla sua storia per costruire la nostra. Dove, per “storia di Gesù”, intendo la sua vita umana mossa dallo Spirito trasformatore, creatore di nuova storia, di un nuovo mondo. (…).
Ut unum sint rimanda a Gesù per porre le basi di un nuovo modo di esercitare il primato di Pietro. Al numero 95, troviamo l’affermazione che «la funzione del Vescovo di Roma risponde alla volontà di Cristo»: «è per il desiderio di obbedire veramente alla volontà di Cristo che io mi riconosco chiamato, come Vescovo di Roma, a esercitare tale ministero». Al numero 96 il papa si chiede: «La comunione reale, sebbene imperfetta, che esiste tra tutti noi, non potrebbe indurre i responsabili ecclesiali e i loro teologi ad instaurare con me e su questo argomento un dialogo fraterno, paziente, nel quale potremmo ascoltarci al di là di sterili polemiche, avendo a mente soltanto la volontà di Cristo per la sua Chiesa, lasciandoci trafiggere dal suo grido “siano anch’essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21)?».
E al numero 90 afferma: «Nel Nuovo Testamento, la persona di Pietro ha un posto eminente. (…) Il posto assegnato a Pietro è fondato sulle parole stesse di Cristo, così come esse sono ricordate nelle tradizioni evangeliche». (…).
L’enciclica non dice “volontà di Gesù”, ma “volontà di Cristo”, come è abituale nei documenti del magistero gerarchico. Ci rimanda non tanto al Gesù storico, ma alla figura di “Cristo” reinterpretata e “ricostruita” dalle comunità cristiane ed espressa nei testi evangelici. Ebbene, il Gesù della storia è il primo criterio al momento di riformare la Chiesa e i suoi ministeri o di ridefinire le relazioni ecumeniche nella “nuova situazione” che viviamo, se non vogliamo correre il rischio di fondarci, senza esserne consapevoli, sui nostri stessi pregiudizi proiettati su Gesù o il rischio di definire “volontà di Cristo” quelle che sono mere credenze e di utilizzare come argomento teologico quelle che sono mere convinzioni. (…).
È necessario, allora, (…) tenere conto dei dati che, in relazione alla figura di Pietro molti bravi esegeti considerano storicamente sicuri. Eccone un breve riassunto:
– benché non tutte le notizie che il Nuovo Testamento offre su Pietro siano storiche, nessuno mette in dubbio il fatto che egli occupasse un ruolo rilevante tra i discepoli, che Gesù gli avesse conferito un ruolo speciale nel compito di annunciare il Regno e di riunire il disperso Israele, e che la sua figura fosse legata in particolate ad alcune Chiese, come la Chiesa di Matteo (Antiochia?) o di Roma, dove egli morì;
– è assai probabile che, dopo la morte di Gesù e la dispersione (se ci fu) dei discepoli/e, Pietro abbia guidato la loro riunificazione intorno alla confessione che egli era stato risuscitato o esaltato da Dio; così bisognerebbe intendere il fatto che sia stato “il primo” a cui Gesù risorto era apparso (1 Cor 15,5; Lc 24,34), per quanto abbia ben potuto condividere tale ruolo con Maria di Magdala, sempre che non sia a lei che spetti il protagonismo della confessione pasquale;
– c’è un ampio consenso sul fatto che il testo di Mt 16,17-19 sia una creazione postpasquale propria di Matteo o della tradizione che egli raccoglie; potrebbe avere come scopo quello di rivendicare il posto o l’autorità della stessa Chiesa (forse Antiochia, dove probabilmente scrive Matteo, o un’altra vicina) in quanto fondata da Pietro, rispetto ad altre Chiese che si richiamavano a Paolo o al “Discepolo Amato”; il potere di “legare e sciogliere”, che qui si attribuisce a Pietro, si applicò prima ai discepoli in generale (Mt 18,18) o ai Dodici (Gv 20,23) (…);
– vale la pena segnalare il fatto che anche Paolo riconobbe la preminenza di Pietro (Gal 1,18; 2,1-10), ma che ciò non gli impedì di scontrarsi con lui duramente in Antiochia (Gal 2,11-14), e persino di rompere con lui definitivamente, poiché a partire da questo episodio (anno 49?) non abbiamo notizia che abbiano avuto altri contatti. (…);
– per il resto, le Chiese neotestamentarie si organizzarono internamente in modi molto diversi; basta guardare alle comunità di Gerusalemme, Antiochia, Corinto e Roma.
In conclusione, secondo i dati esegetici di cui disponiamo, Gesù non pensava a una Chiesa futura provvista di determinate strutture organizzative (annunciò piuttosto l’arrivo di una trasformazione profonda del mondo che chiamava “Regno di Dio”, e comportava l’eliminazione di tutte le malattie e le ingiustizie, e la cui realizzazione era imminente).
Non affidò a Pietro nessuna missione da lasciare in eredità, per il futuro, a un “successore”, né costituì il gruppo dei Dodici perché guidassero la Chiesa o le Chiese, bensì per simboleggiare e promuovere la riunificazione finale degli ebrei della Diaspora. Di fatto, sembra certo che la maggior parte dei Dodici non guidò alcuna Chiesa e che, al contrario, alcuni che non rientravano tra i Dodici lo fecero: è il caso di Giacomo, il fratello di Gesù, a Gerusalemme, e il caso del Discepolo Amato che fu la figura di riferimento di importanti comunità; è il caso, in particolare, di Paolo, che fondò e “governò” numerose Chiese. Né nella mente di Gesù né nelle comunità del Nuovo Testamento incontriamo qualcosa che assomigli a un vescovo di Roma come “successore di Pietro”, e tanto meno a un “primato di giurisdizione” nel senso che sembra attribuirgli la Ut unum sint.
Ma (…) anche nel caso in cui il Gesù storico avesse conferito espressamente a Pietro la potestà di presiedere alla Chiesa in generale, per essere il fondamento e la garanzia della sua comunione, per pronunciare l’ultima parola in tutte le questioni di dottrina e di morale, saremmo per questo oggi, duemila anni dopo, vincolati a tale pratica e obbligati a mantenerla in quanto tale? Non significherebbe questo negare (…) l’“incarnazione” umana e storica di Dio in lui? Non ci condanneremmo a bloccare così l’azione dello Spirito e la trasformazione della nostra Chiesa e della storia?
4. Che modello di unità, di comunione e di ecumenismo?
“Che tutti siano uno”. Il titolo dell’enciclica riprende la preghiera di Gesù, citata sei volte nel testo (…). I termini “unità” o “unione” si ripetono circa 200 volte e altre 130 il termine “comunione”.
La domanda cruciale è: che modello di unione? È necessaria un’unità istituzionale organica e centralizzata? Un solo gregge sotto un solo pastore? Ut unum sint riconosce la necessità di superare il modello ecumenico impostosi durante il secondo millennio, centrato sulla figura di un papa plenipotenziario, ma resta legata a un modello eccessivamente romanocentrico e papista. (…).
La Chiesa romana continua a considerarsi il centro e la base. Seguendo la Lumen gentium e l’Unitatis redintegratio del Concilio Vaticano II, l’enciclica afferma che la Chiesa cattolica romana è quella in cui è custodita la pienezza della verità e, pertanto, la garanzia della piena comunione: «La Costituzione Lumen gentium in una sua affermazione fondamentale che il Decreto Unitatis redintegratio riecheggia, scrive che l’unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica. Il Decreto sull’ecumenismo sottolinea la presenza in essa della pienezza (plenitudo) degli strumenti di salvezza. La piena unità si realizzerà quando tutti parteciperanno alla pienezza dei mezzi di salvezza che Cristo ha affidato alla sua Chiesa (UUS 86).
Sono note le discussioni conciliari sfociate nella scelta del termine subsistit invece di est, volendo evitare la mera identificazione dell’unica Chiesa con la Chiesa cattolica romana. Lo fa anche la Ut unum sint, ma insistendo sul fatto che solo in essa si trova presente la pienezza salvifica. (…). Di più: «La Chiesa cattolica (…) sostiene che la comunione delle Chiese particolari con la Chiesa di Roma, e dei loro Vescovi con il Vescovo di Roma, è un requisito essenziale – nel disegno di Dio – della comunione piena e visibile» (UUS 97). Il Decreto Unitatis redintegratio non si esprimeva in questi termini così netti; lo avrebbe fatto di lì a poco la Dominus Jesus (2000).
(…). L’enciclica invita a rivedere il modo di esercitare il ministero papale, ma non contempla alcun cambiamento di modello di tale ministero né alcuna riduzione sostanziale dei poteri che i dogmi cattolici gli hanno attribuito nel secondo millennio: il primato e l’infallibilità. (…).
È così allora che il vescovo di Roma mantiene l’ultima parola: «L’autorità docente ha la responsabilità di esprimere il giudizio definitivo» (UUS 81). E rimane ben chiaro che il “Successore di Pietro” è l’unico abilitato, in ultima istanza, a «dichiarare ex cathedra che una dottrina appartiene al deposito della fede», per insegnare la verità.
(…). È un’enciclica sulla vera unità, sull’unione nella verità. Ma qui (…) le questioni si complicano. Che cos’è la verità? Chi la conosce? Può essere espressa una volta per tutte? Si afferma che «l’espressione della verità può essere multiforme», ma si aggiunge subito dopo che le nuove forme di espresssione devono presentare «il messaggio evangelico nel suo immutabile significato» (UUS 19). Un significato immutabile? Si tratta di una grave contraddizione, se, come è giusto, chiamiamo “significato” il senso (sempre parziale, culturale, storico) espresso in una o in tutte le parole. L’immutabile – ma esiste? È Dio stesso immutabile nel senso che diamo a questo termine? – sarebbe piuttosto, in ogni caso, il “referente”, il “senso sconosciuto e inesprimibile” a cui si riferiscono tutte le parole e che sempre le trascende. Il significato è ciò che dice la parola; il referente è ciò che la parola non riesce mai a dire del tutto. Il referente è la “verità”, il Mistero indicibile che nessuna parola umana è in grado di esprimere.
Qui tocchiamo il decisivo punto debole dell’enciclica sulla comunione. La quale dà per scontato che il significato immutabile possa identificarsi con la verità in sé, immutabile, e che il vescovo di Roma, e solo lui, possieda la facoltà di esprimerla in maniera piena. (…).
L’enciclica mantiene intatto il paradigma tradizionale, piramidale, gerarchico. Il potere sacro proviene dall’alto e si trasmette per successione gerarchica. È questo paradigma di fondo (…) a rendere il papato – e, al di là di esso, ogni sistema ministeriale e ogni modello istituzionale cattolico e cristiano nel suo insieme – anacronistico e insostenibile. Non si tratta di applicare alcuni aggiustamenti e attualizzazioni al modo di esercitare il ministero, ma di concepirlo secondo un modello radicalmente distinto. (…).
5. Immaginiamo che papa Francesco…
Quattro anni e mezzo fa è stato eletto papa un vescovo “venuto da lontano”, argentino e gesuita, che ha voluto chiamarsi Francesco, che cammina con un altro portamento, parla con un altro garbo e un’altra freschezza, diffonde nel mondo di oggi un messaggio dagli accenti assai diversi da quelli a cui ci avevano abituato i due ultimi papi.
Certamente, muove passi nella giusta direzione con la sua freschezza e la sua libertà francescana, con il suo invito a essere «Chiesa in uscita», in esodo e in pellegrinaggio, in cammino di liberazione, «Chiesa che incontra cammini nuovi», «Chiesa povera, per i poveri e a partire dai poveri», «ospedale da campo» per qualunque ferito si presenti e non dogana religiosa, dottrinale o morale («chi sono io per giudicare?»); con la sua denuncia di un’«economia assassina» e il suo appello a una «rivoluzione della tenerezza» e al tempo stesso a una «coraggiosa rivoluzione culturale» (…); con la sua rinuncia al palazzo vaticano, al protocollo e al fasto; con la sua voluta autodenominazione come “vescovo di Roma” e la sua affermazione che non «si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo» e che «non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori» (Evangelii gaudium 16).
Non si è ancora concretizzata, tuttavia, alcuna riforma del ministero papale e di tutti i ministeri, del vecchio paradigma che li sostiene. Non sappiamo dove egli arriverà. Neppure sappiamo se realmente vorrà avanzare molto più in là di una reforma della Curia e del suo funzionamento, fino alla riforma effettiva e radicale del “ministero petrino”, fino a partorire un altro papato conforme all’attuale società democratica e alla Chiesa che sogniamo, profetica e vicina. E, nel caso volesse arrivare fin dove è necessario, non sappiamo se glielo permetterebbero i poteri e i timori, gli interessi inconfessati, le congiure occulte, i fronti di resistenza.
Il mio sogno è che un giorno, durante l’eucarestia quotidiana a Santa Marta, dopo aver proclamato il vangelo dell’invio dei dodici apostoli (Mt 10,5-13), papa Francesco si alzi e parli così:
“Che la pace sia con voi, sorelle, fratelli della Chiesa cattolica e di tutte le Chiese! Gesù ci ha inviato ad annunciare la pace e a curare, come pellegrini del mondo, senza bisaccia né bastone. Ci ha chiamato a essere Chiesa di sorelle e fratelli, Chiesa fraterna e compagna di tutti i poveri e i feriti lungo la strada.
Io non sono che il più piccolo dei vostri fratelli, ma la grazia del caso ha voluto pormi qui, come vescovo di Roma e come papa, carico di indumenti e di poteri eccessivi. È arrivato il momento di prendere una grossa decisione, arrischiata e tranquilla. Ci anima lo Spirito di Gesù, di Maria di Magdala e di Simon Pietro, di Francesco e di Chiara di Assisi. Siamo chiamati a essere semplici e coraggiosi, a muovere un passo che avremmo già dovuto compiere da secoli. È arrivato il momento di sciogliere la zavorra storica che ci impedisce di essere discepole/i di Gesù, profeti sognatori e sovversivi come lo è stato lui. Non voglio più parlarvi come un personaggio infallibile investito di poteri sacri, creazioni umane spurie. Prendete le mie parole come volete. Vi propongo, insieme e in pace, di reinventare o di ribaltare tutte le strutture che impediscono alla Chiesa di essere povera, libera e fraterna, senza dimenticare il passato né legarci ad esso, senza legarci neppure alle nostre sacre Scritture, bensì lasciandoci ispirare e spingere da queste. È il momento che la Chiesa sia totalmente democratica, attui la separazione dei poteri e sia governata da un sistema più rappresentativo della volontà della gente dei sistemi democratici vigenti, ostaggi del sistema finanziario.
E voglio che cominciamo dal papato, come sognò Giovanni Paolo I, come chiese Giovanni Paolo II in una frase dimenticata di un’enciclica, come rivendicò Benedetto XVI quando era un semplice teologo. Ritengo che i dogmi del primato giurisdizionale e dell’infallibilità papale, definiti dal Concilio Vaticano I, oggi non abbiano più senso e che non dobbiamo perderci in sottili disquisizioni per far loro dire il contrario di ciò che dicono alle orecchie di chiunque; ritengo che neppure sia necessario derogarli solennemente, ma riconoscerli semplicemente come schemi linguistici e produzioni umane di altri tempi, oggi inservibili, e lasciarli da parte con la stessa facilità con cui lo facciamo con immagini e idee che hanno smessi di esserci utili. E andare avanti.
E per andare avanti per una nuova strada, voglio rinunciare e rinuncio a tutti i titoli che il sogno di grandezza è andato attribuendo al vescovo di Roma: Sommo Pontefice, Vicario di Cristo, Successore di Pietro, Santo Padre, Papa. Voglio spogliarmi di ogni fasto e orpello vaticano, povere spoglie umane della storia, la nostra storia istituzionale spesso così poco evangelica. E in nessun modo voglio più essere il presidente di uno Stato con tutto l’apparato di nunzi e ambasciatori e relazioni di potere.
Voglio che nessuno sia vescovo per designazione del vescovo di Roma, e che ogni vescovo o vescova non sia altro che il o la rappresentante della sua comunità cristiana, e che questa lo o la scelga in un modo che dobbiamo concretizzare e definire tutti insieme e che lo sia solo per un certo tempo.
Voglio che il vescovo o la vescova di Roma sia, come il vescovo di qualunque altra diocesi, scelto/a dai cristiani e dalle cristiane di Roma, e che non torni più ad avere potere sugli altri vescovi della Chiesa che chiamiamo cattolica, e tanto meno sulle altre Chiese che chiamiamo “sorelle separate” e che dobbiamo chiamare “sorelle” e basta.
Voglio che si dia un grande passo avanti nel cammino verso l’ecumenismo in cui ci troviamo incagliati da un secolo. È un piccolo semplice passo. Basta che tutte le Chiese, a cominciare dalla “Chiesa cattolica”, si riconoscano reciprocamente come vere Chiese di Gesù, senza esigere che cambino le particolarità di ciascuna. Che si riconoscano in profonda comunione spirituale ed evangelica benché siano diverse le loro dottrine e le loro istituzioni. E che preghino tutti i giorni per chiedere, alimentare, accogliere tra loro la massima unità nella maggiore diversità. E che, dal mutuo riconoscimento fraterno e sororale, le Chiese creino le nuove strutture di “comunione”, di rappresentanza e di coordinamento che sembrino loro più convenienti. E con questo basta, sorelle, fratelli. Torniamo a Gesù. Cominciamo da capo. Nel nome di Gesù. Amen”.
Cristo in maestà tra gli evangelisti, Presbiterio della Chiesa di Santa Maria del Castello (Giornico – CH), immagine originale e licenza




![[L’esclusiva] Viaggio nei campi di sterminio dei migranti in Libia. Ecco la testimonianza choc dell’orrore che non vogliamo vedere](http://notizie.tiscali.it/export/sites/notizie/.galleries/16/migranti-libia.jpg_250962432.jpg)







 Testo di Papa Francesco
Testo di Papa Francesco Il vostro perdono per uomini e donne di Chiesa che non vogliono guardarvi o non hanno voluto guardarvi, è acqua benedetta per noi; è pulizia per noi; è aiutarci a tornare a credere che al cuore del Vangelo c’è la povertà come grande messaggio, e che noi – i cattolici, i cristiani, tutti – dobbiamo formare una Chiesa povera per i poveri; e che ogni uomo e donna di qualsiasi religione deve vedere in ogni povero il messaggio di Dio che si avvicina e si fa povero per accompagnarci nella vita”.
Il vostro perdono per uomini e donne di Chiesa che non vogliono guardarvi o non hanno voluto guardarvi, è acqua benedetta per noi; è pulizia per noi; è aiutarci a tornare a credere che al cuore del Vangelo c’è la povertà come grande messaggio, e che noi – i cattolici, i cristiani, tutti – dobbiamo formare una Chiesa povera per i poveri; e che ogni uomo e donna di qualsiasi religione deve vedere in ogni povero il messaggio di Dio che si avvicina e si fa povero per accompagnarci nella vita”.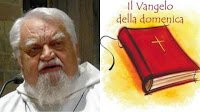
 Un quadro terribile, che conferma la sistematica violazione dei diritti umani nel paese che l’Italia ha rifornito di armamenti e soldi per fermare i flussi migratori. Salvare i migranti da quell’inferno, interrompere i finanziamenti – trovati attingendo ai fondi per la cooperazione – è ormai un imperativo. Non ci si può dire preoccupati per le sorti di chi viene ricacciato in Libia e allo stesso tempo finanziarne gli aguzzini. In questi giorni il nostro Parlamento discute la legge di bilancio, che prevede risorse per la cooperazione allo sviluppo che in realtà vengono utilizzate per tutt’altri fini. In particolare, il Maeci (Ministero affari esteri, Cooperazione internazionale) ha istituito un fondo straordinario per l’Africa per il 2017, con una dotazione di 200 milioni di euro, volto a finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo e di controllo e prevenzione dei flussi di migranti irregolari. Fondi che sono stati in parte finalizzati a progetti specifici nei principali paesi interessati dalla rotta del Mediterraneo Centrale – Niger, Libia e Tunisia in particolare – in parte sono invece transitati per il contenitore europeo dei Fondi Fiduciari per poi arrivare direttamente nelle casse dei Paesi africani coinvolti. Un sistema di vasi comunicanti – sia tra Italia e Europa, che tra il Maeci e il Ministero degli Interni – che rende ancora più difficile il monitoraggio del loro utilizzo. È però evidente che l’utilizzo reale del Fondo per l’Africa ha poco a che vedere con l’obiettivo dello sviluppo previsto dalla legge. Le risorse più ingenti sono infatti quelle stanziate per il contrasto all’immigrazione e il controllo delle frontiere. L’esempio più esplicito del sistema di vasi comunicanti è il fondo allocato per il Niger, con cui questo paese s’impegna a creare nuove unità specializzate necessarie al controllo dei confini. Una militarizzazione delle frontiere che obbliga i migranti a uscire dalle rotte abituali, aumentandone i rischi e trasformando così il deserto, come già il Mediterraneo, in un cimitero a cielo aperto. Il fondo per l’Africa è dunque diventato lo strumento centrale per l’esternalizzazione delle frontiere, affidando a paesi che violano sistematicamente i diritti umani l’intercettazione dei migranti per deportarli in luoghi dove sono esposti a trattamenti violenti e disumani.
Un quadro terribile, che conferma la sistematica violazione dei diritti umani nel paese che l’Italia ha rifornito di armamenti e soldi per fermare i flussi migratori. Salvare i migranti da quell’inferno, interrompere i finanziamenti – trovati attingendo ai fondi per la cooperazione – è ormai un imperativo. Non ci si può dire preoccupati per le sorti di chi viene ricacciato in Libia e allo stesso tempo finanziarne gli aguzzini. In questi giorni il nostro Parlamento discute la legge di bilancio, che prevede risorse per la cooperazione allo sviluppo che in realtà vengono utilizzate per tutt’altri fini. In particolare, il Maeci (Ministero affari esteri, Cooperazione internazionale) ha istituito un fondo straordinario per l’Africa per il 2017, con una dotazione di 200 milioni di euro, volto a finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo e di controllo e prevenzione dei flussi di migranti irregolari. Fondi che sono stati in parte finalizzati a progetti specifici nei principali paesi interessati dalla rotta del Mediterraneo Centrale – Niger, Libia e Tunisia in particolare – in parte sono invece transitati per il contenitore europeo dei Fondi Fiduciari per poi arrivare direttamente nelle casse dei Paesi africani coinvolti. Un sistema di vasi comunicanti – sia tra Italia e Europa, che tra il Maeci e il Ministero degli Interni – che rende ancora più difficile il monitoraggio del loro utilizzo. È però evidente che l’utilizzo reale del Fondo per l’Africa ha poco a che vedere con l’obiettivo dello sviluppo previsto dalla legge. Le risorse più ingenti sono infatti quelle stanziate per il contrasto all’immigrazione e il controllo delle frontiere. L’esempio più esplicito del sistema di vasi comunicanti è il fondo allocato per il Niger, con cui questo paese s’impegna a creare nuove unità specializzate necessarie al controllo dei confini. Una militarizzazione delle frontiere che obbliga i migranti a uscire dalle rotte abituali, aumentandone i rischi e trasformando così il deserto, come già il Mediterraneo, in un cimitero a cielo aperto. Il fondo per l’Africa è dunque diventato lo strumento centrale per l’esternalizzazione delle frontiere, affidando a paesi che violano sistematicamente i diritti umani l’intercettazione dei migranti per deportarli in luoghi dove sono esposti a trattamenti violenti e disumani. L’esempio più lampante, come riportano le tante denunce documentate, è quello della Libia, per la quale il Maeci stanzia dieci milioni, gestiti dal Ministero degli Interni italiano, che si aggiungono agli altri due milioni e 500mila euro forniti per la riparazione di quattro motovedette assegnate alla guardia costiera libica perché svolga la sua violenta opera di intercettamento e respingimento. Con gli stessi obiettivi, dodici milioni sono stati destinati al governo tunisino per il pattugliamento delle zone costiere e delle frontiere terrestri. Con questo utilizzo dei fondi l’Italia viola le Convenzioni Internazionali, affidando ad altri Paesi i respingimenti sistematici di cittadini stranieri, potenziali richiedenti protezione internazionale.
L’esempio più lampante, come riportano le tante denunce documentate, è quello della Libia, per la quale il Maeci stanzia dieci milioni, gestiti dal Ministero degli Interni italiano, che si aggiungono agli altri due milioni e 500mila euro forniti per la riparazione di quattro motovedette assegnate alla guardia costiera libica perché svolga la sua violenta opera di intercettamento e respingimento. Con gli stessi obiettivi, dodici milioni sono stati destinati al governo tunisino per il pattugliamento delle zone costiere e delle frontiere terrestri. Con questo utilizzo dei fondi l’Italia viola le Convenzioni Internazionali, affidando ad altri Paesi i respingimenti sistematici di cittadini stranieri, potenziali richiedenti protezione internazionale.