papa Francesco riconosce la corruzione in Vaticano
papa Francesco
«sì, c’è corruzione in Vaticano ma non perdo la serenità»
il pontefice e i mali della chiesa
«a Buenos Aires ero più ansioso. Scrivo bigliettini a San Giuseppe li metto sotto la sua statua»
 <img alt=” ” title=” ” src=”http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2017/02/08/Interni/Foto%20Interni%20-%20Trattate/LAPR0459-ktcD-U43280693999875Z9D-1224×916@Corriere-Web-Sezioni-593×443.jpg?v=20170209071459″/>
<img alt=” ” title=” ” src=”http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2017/02/08/Interni/Foto%20Interni%20-%20Trattate/LAPR0459-ktcD-U43280693999875Z9D-1224×916@Corriere-Web-Sezioni-593×443.jpg?v=20170209071459″/>ampi stralci del colloquio di Francesco con i superiori degli ordini religiosi, pubblicato nel numero 4000 de «La Civiltà cattolica» e trascritto dal direttore, padre Spadaro
«Il Papa è in ritardo», mi dicono all’ingresso dell’Aula Paolo VI il 25 novembre 2016. Dentro, nel luogo in cui si svolgono i Sinodi, erano in attesa 140 Superiori Generali di Ordini e Congregazioni religiose maschili (Usg), riuniti alla fine della loro 88a Assemblea Generale. Fuori una leggera pioggia. «Andate e portate frutto. La fecondità della profezia»: questo il tema dell’Assemblea che si è svolta dal 23 al 25 novembre presso il «Salesianum» di Roma. Non è comune che il Pontefice arrivi in ritardo. Alle 10,15 ecco arrivare i fotografi e quindi il Papa a passo svelto. Dopo l’applauso di saluto, Francesco esordisce: «Scusate per il ritardo. La vita è così: piena di sorprese. Per capire le sorprese di Dio bisogna capire le sorprese della vita. Grazie tante». E ha proseguito dicendo che non voleva che il suo ritardo influisse sul tempo fissato per stare insieme. Per questo l’incontro è durato comunque tre ore piene. A metà dell’incontro si è avuta una pausa. Era stata preparata una saletta riservata per il Papa, ma lui ha esclamato: «Perché mi volete far stare tutto da solo?». E così la pausa ha visto il Papa gioiosamente tra i Generali a prendere un caffè e uno spuntino, salutando l’uno e l’altro. Non vi è stato alcun discorso preparato in anticipo né da parte dei religiosi né da parte del Papa. Le telecamere del Ctv hanno ripreso solamente i saluti iniziali e poi sono andate via. L’incontro doveva essere libero e fraterno, fatto di domande e risposte non filtrate. Il Papa non ha voluto leggerle in anticipo. Dopo aver ricevuto un brevissimo saluto da parte di p. Mario Johri, ministro generale dei Frati Cappuccini e presidente dell’Usg, e di p. David Glenday, comboniano, segretario generale, il Papa ha ascoltato le domande dell’Assemblea.
E se ci fossero critiche?
«È bene essere criticato — afferma il Papa —, a me piace questo, sempre. La vita è fatta anche di incomprensioni e di tensioni. E quando sono critiche che fanno crescere, le accetto, rispondo. Le domande più difficili però non le fanno i religiosi, ma i giovani. I giovani ti mettono in difficoltà, loro sì. I pranzi con i ragazzi nelle Giornate Mondiali della Gioventù o in altre occasioni, queste situazioni mi mettono in difficoltà. I giovani sono sfacciati e sinceri e loro ti chiedono le cose più difficili. Adesso fate le vostre domande».
Santo Padre, noi riconosciamo la sua capacità di parlare ai giovani e di infiammarli per la causa del Vangelo. Noi sappiamo anche del suo impegno per avvicinare i giovani alla Chiesa; per questo ha convocato il prossimo Sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Quali motivazioni l’hanno spinta a convocare il Sinodo sui giovani? Quali suggerimenti ci offre per raggiungere i giovani oggi?
Alla fine del Sinodo scorso ogni partecipante ha dato tre suggerimenti sul tema da affrontare nel prossimo. Poi sono state consultate le Conferenze episcopali. Le convergenze sono andate su temi forti, quali gioventù, formazione sacerdotale, dialogo interreligioso e pace. Nel primo Consiglio post-sinodale è stata fatta una bella discussione. Io ero presente. Ci vado sempre, ma non parlo. Per me importante è ascoltare davvero. È importante che io ascolti, ma lascio che siano loro a lavorare liberamente. In questo modo capisco come emergono le problematiche, quali sono le proposte e i nodi, e come si affrontano.
Hanno scelto i giovani. Ma alcuni sottolineavano l’importanza della formazione sacerdotale. Personalmente ho molto a cuore il tema del discernimento. L’ho raccomandato più volte ai gesuiti: in Polonia e poi alla Congregazione Generale . Il discernimento accomuna la questione della formazione dei giovani alla vita: di tutti i giovani, e in particolare, a maggior ragione, anche dei seminaristi e dei futuri pastori. Perché la formazione e l’accompagnamento al sacerdozio ha bisogno del discernimento.
Al momento è uno dei problemi più grandi che abbiamo nella formazione sacerdotale. Nella formazione siamo abituati alle formule, ai bianchi e ai neri, ma non ai grigi della vita. E ciò che conta è la vita, non le formule. Dobbiamo crescere nel discernimento. La logica del bianco e nero può portare all’astrazione casuistica. Invece il discernimento è andare avanti nel grigio della vita secondo la volontà di Dio. E la volontà di Dio si cerca secondo la vera dottrina del Vangelo e non nel fissismo di una dottrina astratta. Ragionando sulla formazione dei giovani e sulla formazione dei seminaristi, ho deciso il tema finale così come è stato comunicato: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
La Chiesa deve accompagnare i giovani nel loro cammino verso la maturità, e solo con il discernimento e non con le astrazioni i giovani possono scoprire il loro progetto di vita e vivere una vita davvero aperta a Dio e al mondo. Dunque ho scelto questo tema per introdurre il discernimento con maggior forza nella vita della Chiesa. L’altro giorno abbiamo avuto la seconda riunione del Consiglio post-sinodale. Si è discusso abbastanza bene su questo argomento. Hanno preparato la prima bozza sui Lineamenta che si dovrà inviare subito alle Conferenze episcopali. Hanno lavorato anche religiosi. È uscita una bozza ben preparata.
Questo comunque è il punto chiave: il discernimento, che è sempre dinamico, come la vita. Le cose statiche non vanno. Soprattutto con i giovani. Quando io ero giovane, la moda era fare riunioni. Oggi le cose statiche come le riunioni non vanno bene. Si deve lavorare con i giovani facendo cose, lavorando, con le missioni popolari, il lavoro sociale, con l’andare ogni settimana a dar da mangiare ai senzatetto. I giovani trovano il Signore nell’azione. Poi, dopo l’azione si deve fare una riflessione. Ma la riflessione da sola non aiuta: sono idee… solo idee. Dunque due parole: ascolto e movimento. Questo è importante. Ma non solamente formare i giovani all’ascolto, bensì innanzitutto ascoltare loro, i giovani stessi. Questo è un primo compito importantissimo della Chiesa: l’ascolto dei giovani. E nella preparazione del Sinodo la presenza dei religiosi è davvero importante, perché i religiosi lavorano molto con i giovani.
Che cosa si aspetta dalla vita religiosa nella preparazione del Sinodo?
Quali speranze Lei ha per il prossimo Sinodo sui giovani, alla luce della diminuzione delle forze della vita religiosa in Occidente?
Certo, è vero che c’è una diminuzione delle forze della vita religiosa in Occidente. Certamente è collegata al problema demografico. Ma è anche vero che a volte la pastorale vocazionale non risponde alle attese dei giovani. Il prossimo Sinodo ci darà idee. La diminuzione della vita religiosa in Occidente mi preoccupa.
Ma mi preoccupa anche un’altra cosa: il sorgere di alcuni nuovi Istituti religiosi che sollevano alcune preoccupazioni. Non dico che non debbano esserci nuovi Istituti religiosi! Assolutamente no. Ma in alcuni casi mi interrogo su che cosa stia accadendo oggi. Alcuni di essi sembrano una grande novità, sembrano esprimere una grande forza apostolica, trascinano tanti e poi… falliscono. A volte si scopre persino che dietro c’erano cose scandalose… Ci sono piccole fondazioni nuove che sono davvero buone e che fanno sul serio. Vedo che dietro queste buone fondazioni ci sono a volte anche gruppi di vescovi che accompagnano e garantiscono la loro crescita. Però ce ne sono altre che nascono non da un carisma dello Spirito Santo, ma da un carisma umano, da una persona carismatica che attira per le sue doti umane di fascinazione. Alcune sono, potrei dire, «restaurazioniste»: esse sembrano dare sicurezza e invece danno solo rigidità. Quando mi dicono che c’è una Congregazione che attira tante vocazioni, lo confesso, io mi preoccupo. Lo Spirito non funziona con la logica del successo umano: ha un altro modo. Ma mi dicono: ci sono tanti giovani decisi a tutto, che pregano tanto, che sono fedelissimi. E io mi dico: «Benissimo: vedremo se è il Signore!».
Alcuni poi sono pelagiani: vogliono tornare all’ascesi, fanno penitenze, sembrano soldati pronti a tutto per la difesa della fede e di buoni costumi… e poi scoppia lo scandalo del fondatore o della fondatrice… Noi sappiamo, vero? Lo stile di Gesù è un altro. Lo Spirito Santo ha fatto rumore il giorno della Pentecoste: era all’inizio. Ma di solito non fa tanto rumore, porta la croce. Lo Spirito Santo non è trionfalista. Lo stile di Dio è la croce che si porta avanti fino a che il Signore non dice «basta». Il trionfalismo non va bene d’accordo con la vita consacrata.
Dunque, non mettete la speranza nel fiorire improvviso e massiccio di questi Istituti. Cercate invece l’umile cammino di Gesù, quello della testimonianza evangelica. Benedetto XVI ce lo ha detto molto bene: la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione.
Perché ha scelto tre tematiche ne per le prossime tre Giornate mondiali della gioventù che condurranno alle Giornate mondiali di Panama?
I temi ni per le prossime tre Giornate mondiali non li ho scelti io! Dall’America Latina hanno chiesto questo: una forte presenza na. È vero che l’America Latina è molto na, e a me è sembrata una cosa molto buona. Non ho avuto altre proposte, e io ero contento così. Ma la Madonna vera! Non la Madonna capo di un ufficio postale che ogni giorno manda una lettera diversa, dicendo: «Figli miei, fate questo e poi il giorno dopo fate quest’altro». No, non questa. La Madonna vera è quella che genera Gesù nel nostro cuore, che è Madre. Questa moda della Madonna superstar, come una protagonista che mette se stessa al centro, non è cattolica.
Santo Padre, la sua missione nella Chiesa non è facile. Malgrado le sfide, le tensioni, le opposizioni, Lei ci offre la testimonianza di un uomo sereno, di un uomo di pace. Qual è la sorgente della sua serenità? Da dove viene questa fiducia che la ispira e che può sostenere anche la nostra missione? Chiamati a essere guide religiose, cosa ci suggerisce per vivere con responsabilità e pace il nostro compito?
Qual è la sorgente della mia serenità? No, non prendo pastiglie tranquillanti! Gli italiani danno un bel consiglio: per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo. Io non ho problemi nel dire che questa che sto vivendo è un’esperienza completamente nuova per me. A Buenos Aires ero più ansioso, lo ammetto. Mi sentivo più teso e preoccupato. Insomma: non ero come adesso. Ho avuto un’esperienza molto particolare di pace profonda dal momento che sono stato eletto. E non mi lascia più. Vivo in pace. Non so spiegare.
Per il conclave, mi dicono che nelle scommesse a Londra ero nel numero 42 o 46. Io non lo prevedevo affatto. Ho pure lasciato l’omelia pronta per il Giovedì santo . Nei giornali si diceva che ero un king maker, ma non il Papa. Al momento dell’elezione io ho detto semplicemente: «Signore, andiamo avanti!». Ho sentito pace, e quella pace non se n’è andata.
Nelle Congregazioni Generali si parlava dei problemi del Vaticano, si parlava di riforme. Tutti le volevano. C’è corruzione in Vaticano. Ma io sono in pace. Se c’è un problema, io scrivo un biglietto a san Giuseppe e lo metto sotto una statuetta che ho in camera mia. È la statua di san Giuseppe che dorme. E ormai lui dorme sotto un materasso di biglietti! Per questo io dormo bene: è una grazia di Dio. Dormo sempre sei ore. E prego. Prego a mio modo. Il breviario mi piace tanto e mai lo lascio. La Messa tutti i giorni. Il rosario…. Quando prego, prendo sempre la Bibbia. E la pace cresce. Non so se questo è il segreto… La mia pace è un regalo del Signore. Che non me la tolga!
Credo che ciascuno debba trovare la radice dell’elezione che il Signore ha fatto su di lui. Del resto, perdere la pace non aiuta affatto a soffrire. I superiori devono imparare a soffrire, ma a soffrire come un papà. E anche a soffrire con molta umiltà. Per questa strada si può andare dalla croce alla pace. Ma mai lavarsi le mani dai problemi! Sì, nella Chiesa ci sono i Ponzio Pilato che se ne lavano le mani per stare tranquilli. Ma un superiore che se ne lava le mani non è padre e non aiuta.
Santo Padre, nei suoi interventi ci ha detto spesso che ciò che specifica la vita religiosa è la profezia. Ci siamo confrontati a lungo su cosa significhi essere radicali nella profezia. Quali sono le «zone di sicurezza e di conforto» da cui siamo chiamati a uscire? Lei ha parlato alle monache di una «ascesi profetica e credibile». Come la intende in una prospettiva rinnovata di «cultura della misericordia»? Come può la vita consacrata contribuire a tale cultura?
Essere radicali nella profezia. A me questo importa tanto. Prenderò come «icona» Gioele 3. Mi viene spesso in mente, e so che viene da Dio. Dice: «Gli anziani avranno sogni e i giovani profetizzeranno». Questo versetto è un nocciolo della spiritualità delle generazioni. Essere radicali nella profezia è il famoso sine glossa, la regola sine glossa, il Vangelo sine glossa. Cioè: senza calmanti! Il Vangelo va preso senza calmanti. Così hanno fatto i nostri fondatori.
La radicalità della profezia dobbiamo trovarla nei nostri fondatori. Loro ci ricordano che siamo chiamati a uscire dalle nostre zone di conforto e sicurezza, da tutto quello che è mondanità: nel modo di vivere, ma anche nel pensare strade nuove per i nostri Istituti. Le strade nuove vanno cercate nel carisma fondazionale e nella profezia iniziale. Dobbiamo riconoscere personalmente e comunitariamente qual è la nostra mondanità.
Persino l’ascetica può essere mondana. E invece deve essere profetica. Quando sono entrato nel noviziato dei gesuiti, mi hanno dato il cilicio. Va bene anche il cilicio, ma attenzione: non deve aiutarmi a dimostrare quanto sono bravo e forte. La vera ascesi deve farmi più libero. Credo che il digiuno sia una cosa che conservi attualità: ma come faccio il digiuno? Semplicemente non mangiando? Santa Teresina aveva anche un altro modo: mai diceva cosa le piaceva. Non si lamentava e prendeva tutto quello che le davano. C’è un’ascesi quotidiana, piccola, che è una mortificazione costante. Mi viene in mente una frase di sant’Ignazio che aiuta a essere più liberi e felici. Lui diceva che per seguire il Signore aiuta la mortificazione in tutte le cose possibili. Se ti aiuta una cosa, falla, anche il cilicio! Ma solamente se ti aiuta a essere più libero, non se ti serve per mostrare a te stesso che sei forte.
Cosa comporta la vita comunitaria? Qual è il ruolo di un superiore per custodire questa profezia? Quale apporto possono dare i religiosi per contribuire al rinnovamento delle strutture e della mentalità della Chiesa?
La vita comunitaria? Alcuni santi l’hanno definita una continua penitenza. Ci sono comunità in cui la gente si spella e si spiuma! Se la misericordia non entra nella comunità, non va bene. Per i religiosi la capacità di perdono deve spesso iniziare nella comunità. E questo è profetico. Si comincia sempre con l’ascolto: che tutti si sentano ascoltati. Ci vuole ascolto e persuasione anche da parte del superiore. Se il superiore rimprovera continuamente, non aiuta a creare la profezia radicale della vita religiosa. Sono convinto che i religiosi siano in vantaggio nel dare un contributo al rinnovamento delle strutture e della mentalità della Chiesa.
Nei consigli presbiterali delle diocesi i religiosi aiutano nel cammino. E non devono avere paura di dire le cose. Nelle strutture della Chiesa entra il clima mondano e principesco, e i religiosi possono contribuire a distruggere questo clima nefasto. E non c’è bisogno di diventare cardinali per credersi prìncipi! Basta essere clericali. Questo è quanto di peggio ci sia nell’organizzazione della Chiesa. I religiosi possono contribuire con la testimonianza di una fratellanza più umile. I religiosi possono dare la testimonianza di un iceberg capovolto, dove la punta, cioè il vertice, il capo, è capovolta, sta in basso.
Santo Padre, noi abbiamo speranze che attraverso la sua guida si sviluppino migliori relazioni tra vita consacrata e Chiese particolari. Che cosa ci suggerisce per esprimere in pienezza i nostri carismi nelle Chiese particolari e per affrontare le difficoltà che a volte sorgono nei rapporti con i vescovi e il clero diocesano? Come vede la realizzazione del dialogo della vita religiosa con i vescovi e la collaborazione con la Chiesa locale?
Da tempo si chiede di rivedere i criteri circa i rapporti tra i vescovi e i religiosi stabiliti nel 1978 dalla Congregazione per i religiosi e dalla Congregazione per i vescovi nel documento Mutuae relationes. Già nel Sinodo del 1994 ne se era parlato. Quel documento risponde a un certo tempo e non è più così attuale. Il tempo è maturo per il cambiamento. È importante che i religiosi si sentano appieno dentro la Chiesa diocesana. Appieno. A volte ci sono tante incomprensioni che non aiutano all’unità, e allora bisogna dare un nome ai problemi. I religiosi devono essere nelle strutture di governo della Chiesa locale: consigli di amministrazione, consigli presbiterali… A Buenos Aires i religiosi eleggevano i loro rappresentanti nel consiglio presbiterale. Il lavoro va condiviso nelle strutture delle diocesi. I religiosi devono essere nelle strutture di governo della diocesi. Da isolati non ci si aiuta. In questo si deve crescere tanto. E così anche il vescovo è aiutato a non cadere nella tentazione di diventare un po’ principe…
Ma anche la spiritualità va diffusa e condivisa, e i religiosi sono portatori di forti correnti spirituali. In alcune diocesi i sacerdoti del clero diocesano si riuniscono in gruppi di spiritualità francescana, carmelitana… Ma che lo stile di vita possa essere condiviso: alcuni preti diocesani si chiedono perché non possano vivere insieme per non essere soli, perché non possano vivere una vita più comunitaria. Il desiderio viene, ad esempio, quando si ha la buona testimonianza di una parrocchia retta da una comunità di religiosi. Dunque, c’è un livello di collaborazione radicale, perché spirituale, di anima. E stare vicini spiritualmente in diocesi tra il clero e i religiosi aiuta a risolvere le possibili incomprensioni. Si possono studiare e ripensare tante cose. Tra queste anche la durata del servizio come parroco, che mi sembra breve e si cambiano i parroci troppo facilmente. Non nascondo che poi ci sono tanti altri problemi a un terzo livello, legato alla gestione economica. I problemi vengono quando si toccano le tasche! Penso alla questione dell’alienazione dei beni. Con i beni dobbiamo essere molto delicati. La povertà è midollare nella vita della Chiesa. Sia quando la si osserva, sia quando non la si osserva. Le conseguenze sono sempre forti.
Santo Padre, come la Chiesa anche la vita religiosa è impegnata ad affrontare le situazioni di abusi sessuali sui minori e di abusi finanziari con trasparenza e determinazione. Tutto ciò è una contro-testimonianza, suscita scandali e ha anche ripercussioni sulla proposta vocazionale e sull’aiuto dei benefattori. Quali misure ci suggerisce per prevenire tali scandali nelle nostre Congregazioni?
Forse non c’è il tempo per una risposta molto articolata e faccio affidamento alla vostra sapienza. Fatemi dire però che il Signore vuole tanto che i religiosi siano poveri. Quando non lo sono, il Signore manda un economo che porta l’Istituto in fallimento! A volte Congregazioni religiose sono accompagnate da un amministratore ritenuto «amico» e che poi le fa fallire. Comunque, criterio fondamentale per un economo è quello di non essere personalmente attaccato ai soldi. Una volta accadde che una suora economa svenne e una consorella disse a chi la soccorreva: «Passatele sotto il naso una banconota e certamente si riprenderà!». C’è da ridere, ma anche da riflettere. Importante poi verificare come le banche investono i soldi. Non deve mai accadere che ci siano investimenti in armi, ad esempio. Mai.
Circa gli abusi sessuali: pare che su 4 persone che abusano, 2 siano state abusate a loro volta. Si semina l’abuso nel futuro: è devastante. Se sono coinvolti preti o religiosi, è chiaro che è in azione la presenza del diavolo che rovina l’opera di Gesù tramite colui che doveva annunciare Gesù. Ma parliamoci chiaro: questa è una malattia. Se non siamo convinti che questa è una malattia, non si potrà risolvere bene il problema. Quindi, attenzione a ricevere in formazione candidati alla vita religiosa senza accertarsi bene della loro adeguata maturità affettiva. Per esempio: mai ricevere nella vita religiosa o in una diocesi candidati che sono stati respinti da un altro seminario o da un altro Istituto senza chiedere informazioni molto chiare e dettagliate sulle motivazioni dell’allontanamento.
Santo Padre, la vita religiosa non è in funzione di se stessa, ma della sua missione nel mondo. Lei ci ha invitato ad essere una Chiesa in uscita. Dal suo punto di osservazione, la vita religiosa nelle diverse parti del modo sta operando questa conversione?
La Chiesa è nata in uscita. Era chiusa nel Cenacolo e poi è uscita. E deve rimanere in uscita. Non deve tornare a chiudersi nel Cenacolo. Gesù ha voluto che fosse così. E «fuori» significa quelle che io chiamo periferie, esistenziali e sociali. I poveri esistenziali e i poveri sociali spingono la Chiesa fuori di sé. Pensiamo a una forma di povertà, quella legata al problema dei migranti e dei rifugiati: più importante degli accordi internazionali è la vita di quelle persone! E proprio nel servizio della carità è pure possibile trovare un ottimo terreno per il dialogo ecumenico: sono i poveri che uniscono i cristiani divisi! Queste sono tutte sfide aperte per i religiosi di una Chiesa in uscita. L’Evangelii gaudium vuole comunicare questa necessità: uscire. Vorrei che si tornasse a quella Esortazione apostolica con la riflessione e la preghiera. Essa è maturata alla luce dell’Evangelii nuntiandi e del lavoro fatto ad Aparecida, contiene un’ampia riflessione ecclesiale. E infine ricordiamolo sempre: la misericordia è Dio in uscita. E Dio è sempre misericordioso. Anche voi uscite!
Alle 13,00 circa l’incontro si è concluso con alcune parole di ringraziamento e un lungo applauso. Il Papa, già in piedi, prima di lasciare l’Aula, ha salutato tutti con queste parole: «Andate avanti con coraggio e senza paura di sbagliare! Quello che non sbaglia mai è quello che non fa nulla. Dobbiamo andare avanti! Sbaglieremo, a volte, sì, ma c’è sempre la misericordia di Dio dalla nostra parte!». Prima di uscire, Francesco ha voluto salutare ancora una volta tutti i presenti, uno ad uno.
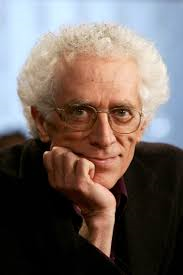
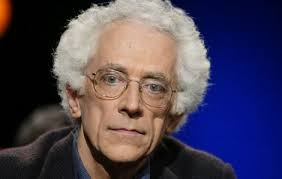









 Ma poco per volta il concetto si universalizza e diventa più ideale e più astratto. Intorno al I secolo filosofie e religioni assumono una concezione più universale dell’umano. Ne sentono il richiamo anche l’ebraismo e il cristianesimo. La religione stessa trova la sua più autentica espressione nella libertà e si svincola dall’idea di popolo trasformato (per catacresi) in «popolo di Dio». Gli scritti cristiani sottolineano la figura di Gesù come figura della libertà. Esempi di tale libertà sono gli episodi di superamento del legalismo e la norma come “nuova” legge. La legge lega, certo, ma siamo nello stesso tempo liberi. Il senso dell’identità è dato dall’agape, il legame reciproco, dove l’alterità diventa una nuova variabile prima sconosciuta. La nozione di agape viene a riempire e interpretare quella di legge, legandosi così intimamente alla nozione di libertà e di persona intimamente nuova. La libertà come problema appare nelle chiese paoline. Da un lato i Galati non comprendono la libertà, ne hanno quasi paura; dall’altro i Corinzi vi si immergono con impeto individuale soggettivo, senza accorgersi del suo nesso intersoggettivo (agape). Tale problematica ha trovato nell’idea moderna di “emancipazione” una applicazione a diversi contesti (il popolo, la donna, lo schiavo). La filosofia moderna coltiva il concetto radicale di libertà. L’essere umano è libero come tale. Non si può risalire a niente di più originario che la libertà (Kant). Ma l’idea di libertà così raffinata finisce nell’arbitrio o nell’egoismo. Peggio se equivale a «volontà di Dio». Va quindi ripensata e temperata. Fuori della solidarietà il diritto diventa astrazione, egoismo. Su tutto sovrasta ancora il fatto irrisolto dell’alterità. Forse solo oggi ci accorgiamo di quanto fosse forte in teoria e labile in pratica il rapporto tra diritto e solidarietà. Non c’è diritto personale che tenga alla lunga se non è compensato dal diritto altrui. Non c’è libertà nemmeno per me se il mio prossimo non è libero insieme con me. Libertà non prescinde da solidarietà: oggi più che mai appare necessario riflettere sul loro nesso. Ci sfuggono realtà che fino a ieri sembravano raggiunte, conquiste che sembravano stabili. Siamo giustamente preoccupati dalla difficoltà di poter mantenere per tutti i vantaggi del welfare e della scuola pubblica. Ma se questo discorso riguarda i popoli europei, ancor più riguarda il rapporto con i nostri simili di ogni provenienza e cultura. Coltivare e salvaguardare la propria identità è una cosa, isolarsi e credersi migliori è un’altra. L’idea che l’identità viva nel rapporto, nell’accoglienza, nella reciprocità non deve illanguidire sotto il peso dei problemi complessi che abbiamo. Dobbiamo farne invece una bandiera vivace anche oggi.
Ma poco per volta il concetto si universalizza e diventa più ideale e più astratto. Intorno al I secolo filosofie e religioni assumono una concezione più universale dell’umano. Ne sentono il richiamo anche l’ebraismo e il cristianesimo. La religione stessa trova la sua più autentica espressione nella libertà e si svincola dall’idea di popolo trasformato (per catacresi) in «popolo di Dio». Gli scritti cristiani sottolineano la figura di Gesù come figura della libertà. Esempi di tale libertà sono gli episodi di superamento del legalismo e la norma come “nuova” legge. La legge lega, certo, ma siamo nello stesso tempo liberi. Il senso dell’identità è dato dall’agape, il legame reciproco, dove l’alterità diventa una nuova variabile prima sconosciuta. La nozione di agape viene a riempire e interpretare quella di legge, legandosi così intimamente alla nozione di libertà e di persona intimamente nuova. La libertà come problema appare nelle chiese paoline. Da un lato i Galati non comprendono la libertà, ne hanno quasi paura; dall’altro i Corinzi vi si immergono con impeto individuale soggettivo, senza accorgersi del suo nesso intersoggettivo (agape). Tale problematica ha trovato nell’idea moderna di “emancipazione” una applicazione a diversi contesti (il popolo, la donna, lo schiavo). La filosofia moderna coltiva il concetto radicale di libertà. L’essere umano è libero come tale. Non si può risalire a niente di più originario che la libertà (Kant). Ma l’idea di libertà così raffinata finisce nell’arbitrio o nell’egoismo. Peggio se equivale a «volontà di Dio». Va quindi ripensata e temperata. Fuori della solidarietà il diritto diventa astrazione, egoismo. Su tutto sovrasta ancora il fatto irrisolto dell’alterità. Forse solo oggi ci accorgiamo di quanto fosse forte in teoria e labile in pratica il rapporto tra diritto e solidarietà. Non c’è diritto personale che tenga alla lunga se non è compensato dal diritto altrui. Non c’è libertà nemmeno per me se il mio prossimo non è libero insieme con me. Libertà non prescinde da solidarietà: oggi più che mai appare necessario riflettere sul loro nesso. Ci sfuggono realtà che fino a ieri sembravano raggiunte, conquiste che sembravano stabili. Siamo giustamente preoccupati dalla difficoltà di poter mantenere per tutti i vantaggi del welfare e della scuola pubblica. Ma se questo discorso riguarda i popoli europei, ancor più riguarda il rapporto con i nostri simili di ogni provenienza e cultura. Coltivare e salvaguardare la propria identità è una cosa, isolarsi e credersi migliori è un’altra. L’idea che l’identità viva nel rapporto, nell’accoglienza, nella reciprocità non deve illanguidire sotto il peso dei problemi complessi che abbiamo. Dobbiamo farne invece una bandiera vivace anche oggi.