il Dio di Gesù, un Dio totalmente nuovo
“Più scopriremo e capiremo la figura di Gesù, più scopriremo e capiremo la figura del Padre
Un Dio talmente nuovo, talmente sconvolgente, che farà sì che poi Gesù verrà assassinato in nome di questo Dio.”
Alberto Maggi
La frase che Giovanni scrive nel prologo al suo vangelo “Dio nessuno l’ha mai conosciuto, soltanto Gesù ne è stata la spiegazione” afferma che tutte le immagini di Dio che ci sono state presentate, sono tutte immagini parziali, immagini a volte false.
Tutto quello che c’è da vedere di Dio, si può vedere in Gesù. E ricordo la famosa domanda che Filippo ha fatto a Gesù: “Adesso mostraci il Padre e ci basta”. E Gesù gli dirà: “Filippo, chi vede me, vede il Padre”.
Che significa? Che non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù.
Più scopriremo e capiremo la figura di Gesù, più scopriremo e capiremo la figura del Padre. Un Dio talmente nuovo, talmente sconvolgente, che farà sì che poi Gesù verrà assassinato in nome di questo Dio. […]
L’uomo non è creato a immagine e somiglianza di Dio, ma la creazione è qualcosa di esterno da Dio : l’uomo è generato dal Padre come figlio. Ma questa figliolanza non può essere imposta, è una proposta. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. So che nella espressione popolare comunemente si dice che siamo tutti figli di Dio. Non è vero. Figli di Dio non lo si è per nascita, ma per una scelta.
E qual è questa scelta?
L’accoglienza nell’esistenza di Gesù, la sua figura e il suo messaggio. Questo è il progetto di Dio sull’umanità. […]
Le prime battute del vangelo di Giovanni si aprono con una immagine stupenda. Un Dio talmente innamorato dell’umanità, talmente entusiasta della creazione che dice: è troppo poco questa vita che hanno, io li voglio innalzare e dare loro la mia dignità divina.
Il progetto di Dio sull’umanità, la sua volontà – non esistono altre volontà – è che ogni uomo diventi suo figlio, attraverso la pratica di un amore simile al suo.
Questa è la volontà di Dio. Non il Dio – basta leggere certi salmi, il salmo 14 – che si affaccia dalle nuvole e guarda la terra disgustato: tutti sono traviati, tutti compiono il male. Ma un Dio che guarda l’umanità e dice: che meraviglia, guarda come sono belli, ma che peccato che abbiano questa vita che si conclude con la morte. Io li voglio innalzare e regalare a loro la mia stessa condizione divina, dare a loro la qualità di figli di Dio.
Questo è il progetto di Dio sull’ umanità. Un progetto pienamente positivo, un progetto nel quale si intravede tutto l’ottimismo di Dio sull’umanità. La volontà di Dio sull’umanità, che Gesù Cristo ci ha fatto conoscere, è che l’uomo è importante, tanto importane al punto che Dio lo vuole innalzare al suo livello e dargli la sua condizione divina.
Il progetto di Dio sull’umanità è che ogni uomo diventi Signore. Signore non significa avere dei sudditi a cui comandare. Signore significa non aver nessuno a cui obbedire. Il progetto di Dio sull’umanità è trasmetterci la sua stessa qualità divina in modo che come lui, noi non abbiamo nessuno a cui dover obbedire.
Il verbo obbedire, o il termine obbedienza, non ha diritto di cittadinanza nei Vangeli. E’ assente. C’è 5 volte il verbo obbedire, ma sempre riferito a elementi contrari all’uomo: il vento, il mare. Mai Gesù chiederà ai suoi discepoli di obbedirgli, mai Gesù chiederà ai discepoli di obbedire a Dio. Figuratevi se chiede ai discepoli di obbedire a qualcuno degli apostoli o dei discepoli.
L’obbedienza non fa parte del lessico evangelico, ma al posto dell’obbedienza Gesù inaugura la SOMIGLIANZA.
Noi non obbediamo né a Gesù Cristo, né a Dio, perché Gesù non ci chiede di obbedire né a lui, né al Padre, ma ci chiede insistentemente di assomigliargli. Nel Vangelo non troviamo mai l’invito di Gesù “obbedite al Padre”, ma abbiamo sempre quello di “siate come il Padre vostro”.
L’uomo realizza la sua condizione divina e quindi diventa Signore nella pratica di un amore simile al suo .
Il prologo del vangelo di Giovanni si conclude con questa espressione: “Dio nessuno l’ha mai visto, l’unico che ce l’ha fatto conoscere è Gesù”. Da questo momento tutta l’attenzione deve essere rivolta su Gesù.
Soltanto conoscendo Gesù si arriva a comprendere, a conoscere chi è Dio. Non bisogna partire da una immagine che abbiamo di Dio filosofica o religiosa e poi arrivare a Gesù. Ma eliminiamo ogni idea religiosa, filosofica di Dio, centriamoci su Gesù e tutto quello che crediamo di Dio e non corrisponde in Gesù, va eliminato.[…]
Gesù si presenta con l’attributo divino: “IO SONO… il cammino, la verità e la vita” (Gv 14,6).
1. Il primo di questi tre aspetti, il cammino, è un termine di movimento, dinamico, non un termine statico. Gesù non si presenta come una realtà statica, ferma, immobile, da adorare, ma come un cammino da percorrere in un crescendo di verità e di vita. Gesù dice: “Io sono il cammino”. Camminiamo con Lui, camminiamo sulle sue tracce.
2. Camminando con Gesù si conosce cos’è la verità. La verità , nel vangelo di Giovanni, è la verità su Dio e sull’uomo. Chi è Dio? E’ un Dio innamorato dell’uomo. Chi è l’uomo? E’ l’oggetto di questo amore di Dio che lo rende suo figlio per la vita.
3. Camminando in questa pienezza della verità si scopre anche la vita e si diventa figli di Dio.
E continua Gesù: “Se voi mi conosceste, conoscereste anche il Padre” (Gv 14,7).
Non c’è una conoscenza del Padre che precede la conoscenza di Gesù, ma la conoscenza di Gesù – l’unica conoscenza – permette la conoscenza del Padre.
Il dramma, almeno della mia esperienza, il dramma di noi cristiani è che non conosciamo Gesù. Il dramma di noi cristiani è che ci hanno imbottito di catechismi, con regole, obblighi, osservanze, ma non ci hanno fatto fare l’esperienza della persona di Gesù.[…]
Nei Vangeli abbiamo un dato sconvolgente, sconcertante. Più le persone sono immerse in un ambito religioso, più le persone vivono di devozioni, di pie pratiche, di atteggiamenti irreprensibili nei confronti della legge di Dio, e più hanno difficoltà a percepire Dio quando si manifesta nella loro esistenza. Più le persone sono lontane da Dio, sia dal punto di vista religioso e sia dal punto di vista morale, e più riescono per primi a percepire la presenza di Dio nella loro vita. Verrebbe quasi da dire: allontaniamoci dalla religione, perché, chi vive in un ambito religioso, è impossibilitato a fare l’esperienza di Dio. Qui c’è Filippo, un ebreo, un giudeo, un praticante che sta con Gesù, ma ancora non ha capito che in Gesù si manifesta il volto del Padre, perché il Dio della religione è un Dio imbalsamato, non un Dio vivo. E’ un Dio da venerare, ma non è un Dio con cui camminare.
Gesù dice: “Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai conosciuto?”. Ed ecco l’importante dichiarazione di Gesù: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,9). Non chi conosce il Padre, conosce me. Chi ha visto me – dice Gesù – ha visto il Padre.
Cosa significa?
Come già si è espresso nel prologo, Gesù è l’unica fonte per conoscere Dio. Il Padre è esattamente come Gesù: non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù.
Cosa significa questo? Se io dico: Gesù è come Dio, significa che in qualche maniera ho un’idea di Dio. No, non Gesù è come Dio. Noi Dio non lo conosciamo. Ma Dio è come Gesù. Tutto quello che noi vediamo in Gesù e nelle sue azioni e nel suo insegnamento, questo è Dio . […]
Gesù allora dice: “Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me, ma il Padre che dimora in me compie le sue opere” (Gv 14,10).
Ecco il criterio sul quale ci soffermeremo : LE OPERE .
Non importa se non credete alle parole, perché le parole possono ingannare, bisogna guardare le opere. L’unico criterio di verità che c’è nei vangeli per stabilire se Gesù viene veramente da Dio o no, e se noi siamo in sintonia con lui o no, non sono le parole, le attestazioni di ortodossia e di fedeltà, ma le opere. E tutte le opere compiute da Gesù sono opere che comunicano e trasmettono vita.
Gesù, è l’immagine di un Dio esclusivamente buono e ogni rapporto che ha con le persone, è esclusivamente quello della bontà.
Nota:
Il testo è tratto dalla conferenza di Alberto Maggi dal titolo “Il Dio Impotente” del 15/01/2003 .
Il testo completo può essere scaricato da : http://www.studibiblici.it/index.html
| Dio è come Gesù ! – p. Alberto Maggi OSM |








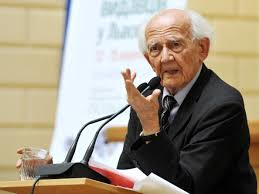
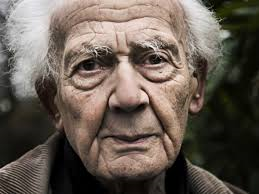


 LA “N” DEI CRISTIANI. Le parole della giornalista irachena forti hanno immediatamente colpito la collega Dima Sadeq (foto a destra), della rete libanese Lbci, la quale
LA “N” DEI CRISTIANI. Le parole della giornalista irachena forti hanno immediatamente colpito la collega Dima Sadeq (foto a destra), della rete libanese Lbci, la quale 
