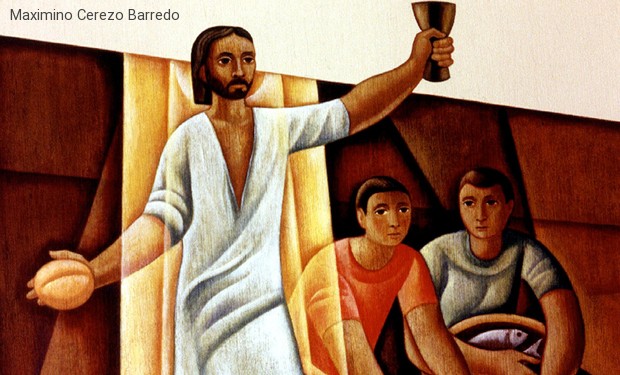sull’omofobia cosa sta cambiando nella chiesa?
Omofobia
cosa cambia nella Chiesa
tra resistenze ed “effetto Francesco”
intervista a Innocenzo Pontillo
a cura di Giampaolo Petrucci
in “Adista” – Notizie
un vescovo un giorno mi ha detto: «Ho sempre ricevuto e letto con attenzione le lettere dei gruppi di credenti omosessuali, ma non potevo fare nulla per loro. Solo oggi papa Francesco mi sta mettendo in condizione di poter rispondere concretamente a queste sollecitazioni»
Per il decimo anno consecutivo, dal Nord al Sud Italia, passando per Torino, Sanremo, Genova, Firenze, Cagliari, Roma, Siracusa e Palermo, e poi anche in Spagna, in luoghi chiave della cattolicità a Barcellona e Siviglia, le settimane a ridosso della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia istituita nel 2007 dall’Unione Europea per il 17 maggio – nello stesso giorno del 1991, l’Oms cancellava l’omosessualità dalla sua classificazione internazionale delle malattie mentali – sono state animate da una lunga serie di veglie di preghiera in ricordo delle vittime e dell’intolleranza omofobica, fiaccolate, serate musicali, culti domenicali, ecc. intorno al versetto del Vangelo di Giovanni: «Amatevi come io vi ho amato». Eventi promossi dagli storici gruppi di cristiani Lgbt italiani presso luoghi di culto delle Chiese cristiane valdesi o metodiste ma – questo il dato in crescita – anche presso parrocchie cattoliche. In alcuni casi, a farsi carico dell’organizzazione degli eventi sono stati proprio i parroci che accompagnano il percorso spirituale dei fedeli gay della propria parrocchia, ma anche commissioni e gruppi di quelle diocesi che negli ultimi anni hanno promosso una riflessione pastorale introno al rapporto tra fede e omosessualità. Le persone omosessuali e transessuali ancora vivono in condizioni di drammatica emarginazione e discriminazione nella società e nella comunità religiosa, si legge il 17 maggio sul portale del Progetto Gionata, che racconta quanto si muove a livello nazionale nel mondo lgbt credente. «Eppure in questi anni sono cambiate molte cose. Soprattutto è cambiato il modo in cui le Chiese affrontano e riflettono su questi argomenti: dieci anni fa, in occasione delle prime veglie, in Italia le chiese cattoliche si rifiutavano di ospitarle, mentre forti discussioni si accesendevano sull’opportunità di accoglierle anche in ambito evangelico. Le veglie allora erano tenute quasi in segreto, evitando di pubblicizzarle troppo. Parlare di certi argomenti era quasi un tabù nella società e sopratutto nelle nostre chiese. In questi ultimi anni invece sono tante le comunità cristiane che hanno deciso di organizzare questi momenti di preghiera e di riflessione insieme ai gruppi di cristiani Lgbt». A margine delle veglie 2016, abbiamo scambiato alcune parole con Innocenzo Pontillo, animatore storico del portale Progetto Gionata e coordinatore del gruppo Kairos di cristiani omosessuali di Firenze. Raccontaci il tuo 17 maggio. A Firenze, 10 anni fa, è nata la prima veglia per ricordare le vittime dell’omofobia in seguito al suicidio di un ragazzo vittima di bullismo omofobico. Quest’anno, proprio il 17 maggio, per la decima volta, il gruppo Kairos ha organizzato un momento di sensibilizzazione contro discriminazione e omotransfobia insieme ad altre realtà, tra cui Libera, Pax Cristi, Samaria, Progetto Gionata, Ives di Pistoia, la Parrocchia della Madonna della Tosse di Firenze, la Comunità di base delle Piagge, l’altracittà giornale della periferia, la Sezione di Firenze degli Scout laici della Cngei, Delegazione Finisterre, la Chiesa evangelica valdese e la Chiesa vetero cattolica di Firenze. Insieme abbiamo organizzato una fiaccolata, partita dalle periferie geografiche della città, ma anche da quelle simboliche delle nostre vite, e giunta nei luoghi simbolo del centro (piazza Duomo, Piazza S. Marco, Piazza Ognissanti, Piazza Strozzi). Con la luce della nostra testimonianza abbiamo voluto illuminare la notte della nostra città e ricordare che ognuno di noi può essere “luce nel mondo”. Le testimonianze che costituivano il cuore della fiaccolata lasciavano senza parole e in profondo silenzio il pubblico incontrato lungo il tragitto. Sul sito di Kairos, kairosfirenze.wordpress.com, si possono vedere foto della fiaccolata e della veglia. La Giornata contro la violenza omofobica sembra unire molte persone e comunità di diversa estrazione…

A Firenze, per esempio, la fiaccolata ha visto la partecipazione di laici cattolici ed evangelici, suore e religiosi, associazioni e anche parrocchie, e si è poi conclusa poi con una veglia nel tempio valdese. La veglia fiorentina è ospitata ogni anno, a rotazione, da una comunità cristiana diversa, ora cattolica, ora evangelica. Perché sempre più parrocchie accolgono le veglie? Cosa è cambiato con il pontificato di Francesco? C’è da dire che già dalla seconda edizione dell’iniziativa, molte comunità parrocchiali hanno ritenuto scandaloso che si negasse a dei credenti un luogo in cui pregare, solo perché omosessuali. Con l’arrivo del nuovo papa i vescovi si sono divisi in due: una maggioranza che ha rinunciato a sanzionare le parrocchie che ospitano le veglie; altri invece hanno voluto ribadire con forza la loro contrarietà, sopratutto nel Nordest. Le parole di ascolto e misericordia di papa Francesco non hanno convertito i cuori di alcuni vescovi, spesso condizionati da altre convenienze e logiche. Il caso di Genova è esemplare: lo scorso anno il card. Bagnasco, presidente dei vescovi italiani, ha vietato a una parrocchia della sua diocesi di accogliere una veglia, sollevando un grande movimento di protesta all’interno della Chiesa locale. Quest’anno, prudentemente, ha evitato ulteriori gesti eclatanti ed anzi ha inviato un suo delegato alla veglia genovese. Questo cambiamento di atteggiamento è dovuto anche alle reazioni di quel popolo di Dio cui papa Francesco ha dato nuova dignità, al cui sensus fidei il papa invita giustamente a guardare perché è lì che oggi spesso il Vangelo dà risposte vive e palpitanti. L’impressione, a volte, è che le veglie si fanno nelle parrocchie cattoliche perché lì c’è un prete “illuminato”, che opera senza un coordinamento, e spesso anzi in contrasto con le gerarchie locali e nazionali. Se non ci fosse l’iniziativa personale di alcuni parroci o suore si farebbe molta fatica a rintracciare il timido cambiamento in corso nella Chiesa italiana. Sono ancora pochi i vescovi che si stanno interrogando su questo tema, basti pensare alle difficoltà del Sinodo a discutere serenamente di accoglienza delle persone Lgbt. Comunque il Sinodo ha aiutato, se non a offrire soluzioni, almeno a mettere in luce il tema. E così, ora, alcuni vescovi stanno cominciando a incontrare i gruppi di credenti omosessuali e i loro genitori, per capire meglio le difficoltà che incontrano concretamente.

Monsignor Krysztof Charamsa, 43 anni, il teologo che ha fatto coming out, con il suo compagno Eduard alla fine della conferenza stampa in corso a Roma, 3 ottobre 2015. ANSA/ LUCIANO DEL CASTILLO
Uno di loro un giorno mi ha detto: «Ho sempre ricevuto e letto con attenzione le lettere dei gruppi di credenti omosessuali, ma non potevo fare nulla per loro. Solo oggi papa Francesco mi sta mettendo in condizione di poter rispondere concretamente a queste sollecitazioni». Insomma, il processo di dialogo con le gerarchie è ancora agli albori ed è tutto da inventare, percorrendo spesso strade inesplorate. Un passo avanti e due indietro? L’Amoris Laetitia non è stata accolta con grande entusiasmo dal mondo gay credente… È stato troppo grande lo scarto tra la discussione sul tema dell’accoglienza delle persone omosessuali, che pure c’è stata nel popolo di Dio, e le risposte impacciate del Sinodo. A dirla tutta al Sinodo è stata palpabile la difficoltà di molti vescovi di parlare di questo tema, argomento ancora tabù per molti di loro. Nell’Amoris Laetitia papa Francesco si è limitato a registrare le poche generiche parole scaturite dal Sinodo, lasciando però aperta la porta nella Chiesa alla ricerca e alla sperimentazione di nuove risposte. Cosa che sta creando anche situazioni contraddittorie: ad esempio, nella Diocesi di Torino è nato il progetto “Alla luce del sole” dell’equipe Fede&Omosessualità, sotto la supervisione dell’incaricato vescovile per l’accompagnamento delle persone omosessuali cristiane. L’équipe ha poi organizzato, presso una parrocchia torinese, la veglia del 7 maggio, che ha inaugurato il lungo cammino delle veglie che si concluderà il 31 maggio. Al tempo stesso però dentro alcune strutture diocesane torinesi c’è anche un gruppo di Courage, che propugna invece l’accoglienza delle persone omosessuali nella Chiesa solo se rinunciano alle relazioni affettive e vivano nel nascondimento di ciò che sono. L’enfasi di Francesco sulla prassi pastorale può essere interpretato come un escamotage per
aggirare la dottrina della Chiesa, senza modificarla, lasciando che il cambiamento si imponga di fatto a livello locale? Credo che questo sia l’invito di Papa Francesco: una sfida per la Chiesa locale che non sarà esente da passi falsi. Edith Warton diceva: «Ci sono due modi per diffondere la luce: essere la candela, o lo specchio che la riflette». Quindi se davvero Cristo è la nostra candela, è nostra responsabilità esserne lo specchio e permettere a questa luce di arrivare anche a chi si è sentito rifiutato, emarginato, “sbagliato”. Oggi la Chiesa locale si pone la domanda: come essere “specchio”, anche per le persone Lgbt? Come cattolici non abbiamo ancora una risposta, ma finalmente siamo di nuovo in cammino per cercarla. È forse giunto il tempo, per la Chiesa, di farsi compagna di viaggio di chi bussa alla sua porta?