il commento al vangelo della domenica
E NOI CHE COSA DOBBIAMO FARE?
commento al vangelo della terza domenica d’avvento (13 dicembre 2015) di p. Alberto Maggi
commento al vangelo della terza domenica d’avvento (13 dicembre 2015) di p. Alberto Maggi
a cura di Massimo Solani
in “l’Unità” del 10 dicembre 2015
«Il rischio è che queste morti vengano lasciate in secondo piano, dimenticate in un clima di guerra come quello che si è creato nel contesto dell’Unione Europea dopo i terribili attentati di Parigi. Come se questi morti non meritassero lo stesso trattamento e la medesima attenzione»
monsignor Gian Carlo Perego è direttore della Fondazione Migrantes e i suoi numeri sulla strage silenziosa nelle acque del Mediterraneo hanno per un giorno riacceso i riflettori sulle tragedie dell’immigrazione che l’Europa sembra aver dimenticato, travolta dall’esigenza di sicurezza e contrasto al terrorismo
Le cifre del 2015 ci dicono chiaramente che nel Mediterraneo è in corso un’ecatombe. E l’Europa cosa fa dopo tanto discutere?
«Il primo segnale negativo è stato l’abbandono delle missione Mare Nostrum e il passaggio a Triton che ha causato il doppio delle morti nel Mediterraneo. L’Europa non si è preoccupata di spendere 588 milioni di euro in una solo settimana per bombardare la Libia ma ha ritenuto eccessivo spendere appena un quinto di quella cifra per salvare invece delle vite in mare. Parimenti, adesso, non ci si pone il problema di spendere altri soldi per bombardare la Siria senza tuttavia preoccuparsi di investire soldi per mettere in atto sistemi realmente efficaci di soccorso in mare che permettano di evitare altre tragedie come quelle a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni. Purtroppo, ancora una volta prevale la logica di guerra sul diritto umanitario e la solidarietà internazionale. Il secondo segnale preoccupante, invece, è quello a cui assistiamo in queste settimane di lotta al terrore con la creazione di altri muri in Europa e altre divisioni. Sta tornando a prevalere il concetto per cui le frontiere non sono più luoghi di passaggio fra Stato e Stato, ma barriere fisiche viste come argine alle migrazioni e agli spostamenti di popoli in cerca di aiuto. Eppure sia Papa Francesco che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno più volte segnalato che occorre evitare questo rischio»
. Ma in questo clima non può essere un caso la crescita di formazioni politiche marcatamente xenofobe come il Front National di Marine Le Pen.
«La cultura del terrore e la paura crescono e si rafforzano nei momenti di grande incertezza e proprio in condizioni come quelle attuale generano quello che Piero Calamandrei definiva “il sonno della ragione”. In quasi tutta Europa stiamo assistendo al progressivo rafforzamento di formazioni politiche che teorizzano il rifiuto dell’altro e che minano il necessario percorso di dialogo, convivenza e inclusione sociale. Si tratta di un pericolo grave che va sconfitto attraverso l’educazione: bisogna tornare a far prevalere la ragionevolezza perché la paura e la diffidenza generano soltanto nuovi scontri e radicalizzano ulteriormente le tensioni. Il dialogo, dobbiamo ricordarlo, rappresenta l’unica strada per la convivenza pacifica in Europa. La tragedia dei Balcani a cui abbiamo assistito soltanto pochi anni fa deve essere un monito: non possiamo restare inermi di fronte al crescere di nuovi focolai di tensione e scontro in quei Paesi che, ad est, stanno costruendo la nuova Europa».
Dopo l’emergenza umanitaria dell’estate e il cordoglio unanime per i lutti come quello del piccolo Aylan, l’Europa è tornata a voltare la testa dall’altra parte? Cosa è rimasto di quella mobilitazione?
«L’Europa si è resa conto che la costruzione di questa realtà politica manca ancora di pezzi importanti che riguardano la solidarietà e la tutela del diritto d’asilo. Dopo aver firmato l’accordo di Dublino sul diritto d’asilo europeo ci siamo accorti che di fatto solo 5 paesi su 28 accoglievano e avevano un piano di accoglienza dei richiedenti asilo. Ci siamo accorti che non tutti concepiscono le frontiere come luoghi di passaggio delle persone ma come luoghi di chiusura totale. Questo mondo di richiedenti asilo e rifugiati ci ha ricordato che un diritto fondamentale espresso nella costituzione europea e nelle costituzioni di tutti i Paesi europei di fatto non è salvaguardato e ha messo in luce la latitanza di tutti gli Stati sul piano della cooperazione internazionale di aiuto dei paesi più poveri. Un’urgenza che già Paolo VI, negli anni 60, aveva affermato con la sua “Populorum progressio”. Questa consapevolezza chiede un nuovo cammino insieme nella solidarietà in un momento in cui la solidarietà non sembra essere affatto premiale sul piano politico. E prova ne sono i risultati delle ultime elezioni regionali in Francia».
di Enzo Bianchi
in “la Repubblica”
il gesto di apertura della porta chiusa è stato compiuto da papa Francesco innanzitutto in Africa, tra i poveri della terra, e ieri anche a Roma, nella basilica di San Pietro. In Vaticano, dove egli esercita il suo ministero di servo della comunione nella chiesa e tra le chiese e di annunciatore della buona notizia a tutta l’umanità. In un’epoca in cui si sono ricostruiti muri e si sono di nuovo innalzate barriere di filo spinato, in cui molti vorrebbero chiudere le frontiere, e alcuni le chiudono, infondendo nella gente ansia e paura, papa Francesco fa il gesto così semplice, quotidiano, umano di aprire una porta chiusa
Purtroppo temo che molti di quelli che passeranno per le porte sante aperte nelle chiese non arriveranno neppure a pensare che potrebbero aprire o tenere aperta la porta della propria casa: aperta per chi giunge inaspettato, straniero o povero, conosciuto o sconosciuto, aperta per un atto di fede-fiducia fatto nei confronti degli altri umani, tutti legati dalla fraternità, valore per il quale pochi oggi combattono, ma senza il quale anche la libertà e l’uguaglianza diventano fragili e non sono concretamente instaurabili. Papa Francesco ha compiuto lo stesso atto in un microcosmo come quello di Bangui, dove sono in atto violenza, intolleranza, scontro di religioni, e a Roma, dove per ora è lontana la violenza dello scontro culturale; potrebbe però essere più vicina di quanto pensiamo, e non perché i terroristi vengono da noi, ma perché alcune forze nostrane continuano ad alimentare diffidenza, odio, non accoglienza, atteggiamenti che possono solo trasformarsi in risentimento, humus su cui crescono risposte all’insegna della violenza. Aprire e tenere aperta una porta è invece una decisione umanizzante, un’azione antropologica che non dovrebbe essere così estranea a cristiani e a non cristiani. Ma per giungere a tale comportamento occorre con urgenza che la convinzione e la prassi di misericordia, compassione e perdono siano inoculate come diastasi nelle nostre società, dando vita a un’ospitalità culturale reciproca che ci permetta di far cadere pregiudizi e di conoscerci meglio. Nell’omelia di apertura del giubileo papa Francesco ha chiesto che questo sia «un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia». Sì, il primo passo è essere convinti della misericordia, così come la Scrittura ce la propone quale nome di Dio, e diventarne realizzatori nelle nostre società, a livello personale, ma anche comunitario, economico e politico. Per i credenti tutto nasce dall’immagine di Dio che hanno, perché questa plasma la loro fede e il comportamento. Secoli di storia cristiana testimoniano che la misericordia di Dio non è compresa, scandalizza i credenti stessi, sembra un eccesso che va temperato con le nozioni di verità e giustizia. Il papa lo sa bene e lo denuncia con forza: «Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto » — e solo i cristiani possono pronunciarlo — «che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza invece affermare prima che sono perdonati dalla sua misericordia… Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia», perché «la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio» (Giacomo 2,13). Poche parole, eppure parole di grande rottura con una certa vulgata cattolica, attestata soprattutto negli ultimi secoli, secondo la quale è doverosa l’intransigenza, è necessario l’esercizio del ministero di condanna: secoli in cui l’immagine prevalente di Dio era quella del Dio irato e giudice, del “Dio ti vede”, quale occhio in un triangolo ovunque presente, del Dio che castiga, che va placato con sofferenze e fatiche a lui offerte affinché arresti il braccio della sua giustizia divina. Papa Giovanni diede inizio a una nuova stagione della chiesa non innovando la dottrina, ma proclamando: «Oggi la sposa di Cristo, la chiesa, preferisce ricorrere alla medicina della misericordia piuttosto che brandire le armi della severità» (11 ottobre 1962, Allocuzione di apertura del concilio Vaticano II). E Papa Francesco manifesta l’urgenza della misericordia come la sua più intima convinzione: «Questo nostro tempo è proprio il tempo della misericordia. Di questo sono sicuro… Noi stiamo vivendo in tempo di misericordia » (6 marzo 2014, Discorso ai parroci di Roma).
Lo stesso Francesco ha esplicitato a più riprese che la misericordia, la compassione, la tenerezza e il perdono di Dio non sono da intendersi come un correttivo della giustizia divina, non sono in tensione con il suo giudizio, ma semplicemente sono la giustizia di Dio messa in atto verso l’essere umano. In Dio c’è un prevalere della misericordia sulla giustizia, se così possiamo dire. Addirittura, secondo il profeta Osea, la misericordia è la manifestazione della santità di Dio, il quale è Santo, cioè è differente, altro dall’uomo proprio nel giudicare e nel sentire la giustizia. Osea arriva a dire che nel cuore di Dio c’è una sorta di “rivolta” del sentimento di misericordia contro la volontà di giustizia: questo sentimento impedisce a Dio di castigare secondo l’alleanza, di andare in collera contro chi ha peccato (cf. Osea 11,8-9). Gesù sottolinea questo prevalere in Dio della misericordia sulla giustizia citando per ben due volte un’altra parola dello stesso profeta: “Andate a imparare che cosa vuol dire: voglio misericordia e non sacrifici (Osea 6,6)” (Matteo 9,13 e 12,7). Con i suoi incontri e con le sue parole, in particolare con le parabole, Gesù attesta che la giustizia di Dio è oltre la giustizia umana, trascende la giustizia della legge, perché non è “giustizia bendata” (Adriano Prosperi) ma vede, discerne, guarda in volto ogni umano; per questo non è retributiva, né punitiva, né meritocratica, secondo i concetti della “nostra” giustizia umana che proiettiamo in Dio. La giustizia di Dio proclamata nella Bibbia attesta che Dio non è indifferente al male compiuto dagli umani, perciò, anche quando va in collera, tale comportamento è l’altra faccia della compassione. Di fronte a questa verità molti cristiani continuano a chiedersi: «Ma allora che ne è della giustizia, della responsabilità umana?». Ha risposto bene il cardinale Pietro Parolin: «La misericordia esercitata non è buonismo, non è timidezza di fronte al male, ma è esercizio di responsabilità». Il segretario di Stato, con la sua profonda consonanza con papa Francesco, arriva a parlare di «misericordia necessaria, prima ancora dei trattati, per poter spianare i terreni di pace e le tante vie degli esodi forzati che stanno mutando il mondo», perché anche a livello economico, politico e giuridico la misericordia e il perdono devono trovare realizzazioni che aprano a una convivenza buona tra i popoli e le genti. È la stessa convinzione alla quale era giunto papa Giovanni Paolo II che, nel messaggio per giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2002, arrivò a chiedere che il perdono, negando la giustizia punitiva, trovasse realizzazione in «una politica del perdono espressa in atteggiamenti sociali e in istituti giuridici» e non fosse relegato nella coscienza del privato cittadino. Davvero, come recita il titolo di quel messaggio profetico, «non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono »: giustizia e perdono sono immanenti l’una all’altra. E all’Angelus di ieri papa Francesco con una delle sue frasi, aforismi che colpiscono, ha detto: «Non si può capire un cristiano che non sia misericordioso, come non si può capire Dio senza misericordia». Di fronte a questo cammino percorso dalla chiesa cattolica e all’insegnamento di papa Francesco non si possono più elevare accuse di spiritualismo o di evasione dalla storia. Questo è il cammino storico fatto dal Vaticano II a oggi. Con il concilio «si sono spalancate al mondo le porte chiuse… per un autentico incontro tra la chiesa e gli uomini del nostro tempo», ha detto papa Francesco. E ha anche chiesto che il giubileo in corso «non trascuri lo spirito emerso dal Vaticano II», lo spirito di una chiesa che si piega verso l’uomo sofferente, sull’esempio del samaritano il quale, secondo il vangelo, “ha fatto misericordia”. Questo è semplicissimo, è umanissimo. Priore della comunità monastica di Bose
«non smettiamo di giocare perché siamo vecchi; invecchiamo perché abbiamo smesso di giocare»
mi vado sempre più convincendo che il vero problema non è tanto quello del credere, quanto piuttosto: in quale Dio credere. Ci sono, in circolazione, troppe immagini contraffatte, deformi, quasi caricaturali, di Dio. Domina incontrastata, sopratutto, l’immagine del Dio giudice severo, giustiziere, inesorabile, che incombe sull’uomo. Ad ogni immagine falsificata di Dio corrisponde una religiosità non autentica, adulterata e quindi pericolosa. Ed ecco, allora una pratica religiosa volontaristica, all’insegna dello sforzo, con la preoccupazione ossessiva di guadagnarsi dei meriti. Ecco una concezione della fede in chiave legalista, colpevolizzante, a causa della quale prevale la paura di non essere a posto, di non aver sistemato tutti i conti. Ecco un culto formale, senza spontaneità né vita. Ecco certe esistenze cristiane perennemente tormentate, problematiche, contorte, complicate fino all’assurdo. Ecco un rapporto con Dio visto esclusivamente in chiave di doveri, prescrizioni, divieti, dove tutto è ridotto a colpa, rimorsi, timori, angoscia, senza l’abbandono dell’intimità, della poesia, della musica, della contemplazione, della mistica, del gioco.
Sì, proprio del gioco. (…) Occorre avere l’onestà di ammettere che troppi cristiani esibiscono la loro fede come qualcosa di vecchio, stantìo, tetro, rancido, rigido. Manca, appunto, il senso del gioco. Secondo quanto afferma un proverbio inglese: «non smettiamo di giocare perché siamo vecchi; invecchiamo perché abbiamo smesso di giocare». E la cosa incide negativamente anche su un certo stile religioso. Urge, dunque, guardando a ciò che è accaduto a Cana, ritrovare il vero volto di Dio. Vorrei esprimere tutto ciò sotto forma di colloquio diretto col Signore. Più o meno così. Tu sei un Dio senza fischietto Signore, Tu non hai mai usato il fischietto con me. E – ho motivo di ritenere – con nessuno. Quando ero bambino, chiunque passasse sotto la finestra di casa suonando il violino o la tromba, il flauto o il piffero, la chitarra o la zampogna, l’organino o semplicemente l’armonica a bocca, o uno zufolo rudimentale, mi buttava in strada. Chiunque suonasse uno strumento qualsiasi – corno violoncello piatti – mi poteva portare dove voleva. Tu sapevi questa mia debolezza e tutte le volte – quante sono state! – che volevi sloggiarmi, hai pizzicato una corda, premuto un tasto, soffiato una nota, accennato un arpeggio, liberato nell’aria un motivetto… Se penso alla mia chiamata al sacerdozio, non posso dire di aver sentito una voce. Credo di aver avvertito un suono, forse qualche accordo d’organo, come quelli che tira fuori il mio amico Piero, o la mia “sirocchia” clarissa suor Raffaella… E io ti ho seguito, sia pure arrancando (chissà perché le tue strade non sono mai in discesa…). Ma non hai fatto ricorso al fischietto, neppure le volte che mi presentavi la croce – e non sono state poche -, nemmeno quando pretendevi ti tenessi dietro lungo la via dolorosa – ed è capitato spesso -. Comunque, se avessi adottato il fischietto, non sarei venuto perché non ti avrei riconosciuto. Ho incocciato, invece, parecchi tuoi rappresentanti che si sono intestarditi a farmi rigar dritto a colpi di fischietto. Il prete all’oratorio, dopo aver fischiato i falli nella partita di pallone, usava lo stesso fischietto per mandarci in chiesa (nella tua e nostra casa!), a Messa (alla tua festa!), o a confessarci (all’abbraccio del tuo perdono!), o al catechismo (ad ascoltare notizie sul tuo conto!).
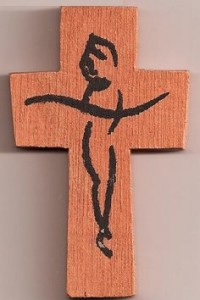 Troppi, lungo la mia strada, mi hanno parlato di Te e delle tue esigenze modulando – si fa per dire – il messaggio a colpi di fischietto. Colpi secchi rabbiosi cattivi. E io avvertivo e avverto ancor oggi, che in quel fischietto sibila un fiato che viene da un fegato guasto, risultato inequivocabile di una cattiva digestione della tua Parola, un’aria gelida, non riscaldata dal cuore, non rigenerata dalla misericordia, non percorsa dalla tua tenerezza. E provo una ripugnanza istintiva a imboccare quella strada irta di divieti e imposizioni, dove la tirannia del codice ha soppiantato il gusto dell’esplorazione e il fascino dell’avventura. Tu sei un Dio che mi fa cantare. Io vorrei danzare, correre per i sentieri, ruzzolare nei prati, scavalcare le siepi, scorticarmi i piedi suoi sassi, appostarmi su un roccione per contemplare il paesaggio, arrampicarmi su un albero come Zaccheo, mettermi ad urlare al tuo passaggio come il cieco Bartimeo… E loro, invece, si accaniscono a mettermi in riga, impormi il silenzio, e farmi procedere a passo di militare, cadenzato, con la divisa inappuntabile, disciplinatamente, come a una parata ( o a un funerale?). Io vorrei cantare a squarciagola. E loro mi ammoniscono che non sta bene. Mi costringono a gargarizzare formule che sanno di cenere. Io vorrei lodarti, inventando parole nuove, fresche, da innamorato. E loro mi cacciano nella strozza pagine ingiallite di vecchi libri carichi di polvere. Perfino quando parlano d’amore, invece di imbastire un canto delicato, si preoccupano prima di tutto ossessivamente di scandirne le “regole” a colpi di fischietto che sembrano altrettanti segnali di allarme (…) sirene spiegate contro la vita e la spontaneità (…). Tu sei il Signore del canto e della danza e lor non si rendono conto che soltanto cantando e danzando lungo la tua difficile strada è possibile staccarsi dalle calcagna il demonio. Tu hai fatto del Venerdì Santo una festa. E loro riescono a trasformare tutte le feste in un cupo Venerdì Santo, senza nemmeno un pallido presagio di Risurrezione. Tu sei un Dio che mi fa danzare Signore, fa’ che i tuoi rappresentanti, quando parlano di Te, non mortifichino la musica e la poesia, non abbiano paura della bellezza, non dimentichino la cetra. E fa’ che sul loro spartito non ci siano le aride norme di un codice, ma il canto gioioso del tuo Vangelo, molto più esigente e impegnativo. Signore, che nessuno mi faccia sentire in colpa se ho voglia di fischiettare, perché Tu mi metti in bocca il sapore della libertà e mi nascondi nel cuore il segreto della follia, e mi fai camminare su per un sentiero aspro verso l’appuntamento segreto del tuo amore. Signore, forse dico un’enormità: ma la tromba del giudizio universale mi fa meno paura del fischietto del tutore dell’ordine (che non è mai l’ordine sognato dalla fantasia del tuo amore…). Signore, mi raccomando, non cessare di pizzicare almeno una corda su una chitarra qualsiasi, di dare un colpo di manovella a un organetto sgangherato, di soffiare una nota in una tromba sfiatata, di picchiare un colpo su un tamburo ammaccato – conosco quel richiamo! – e io, anche se carico di artriti e reumatismi e acciacchi vari, mi precipiterò ancora in strada, come un bambino. E mi lascerò portare ovunque Tu vorrai. All’inferno, no. All’inferno proprio non voglio andarci. … Perché ho troppa paura del fischietto. Tu sei un Dio che mi tiri in faccia una canzone Molti amano raffigurarti con il grosso libro della legge in mano. Altri hanno l’impressione che Tu gli sventoli sempre sotto il naso le pagine di un regolamento. Io preferisco riferirmi allo stupendo canto della vigna (Is 5,1-7), lamento struggente per una vendemmia sfortunata, che diventa simbolo trasparente di un amore tradito. Se non sto troppo a distanza, mi accorgo che quel poema risuona ancor oggi alle mie orecchie, non semplicemente come qualcosa di patetico; so che mi viene gettato in faccia, quale preciso e documentato capo d’imputazione per le mie innumerevoli inadempienze. Sì. tu continui a rinfacciarmi, ossia a scaraventarmi in faccia, una canzone d’amore. Signore, non stancarti di attendere, non smettere di replicare quella canzone. Sarà il tuo canto appassionato, più che le minacce, a farmi prendere coscienza delle mie mancate risposte e a far maturare dentro di me una voglia di fiori e poi, chissà, perfino i frutti. Guai se venisse a cessare quel canto d’amore… Sei riuscita a farlo uscire allo scoperto Maria, permettimi questo sfogo. Non riesco proprio a capacitarmi come mai i teologi, pur abituati ad argomentare su una virgola, non abbiano sfruttato l’episodio di Cana per proporci l’immagine autentica di un Dio della festa, amante della vita e della gioia di vivere.(…) Io ho il sospetto che quando hai fatto notare a Gesù che su quella tavola stava esaurendosi il vino, tu non fossi soltanto preoccupata per quella gente. Pensavi anche a noi. Il tuo intento segreto era quello di far uscire allo scoperto tuo Figlio. E, attraverso di Lui, far emergere il volto nuovo di Dio, che liquidasse definitivamente le vecchie estinte immagini terrificanti di un Dio minaccioso, despota inesorabile, gendarme dell’universo, inquisitore implacabile, che gli uomini si erano fabbricati. Maria, aiutaci tu a “rinnovare” il volto di Dio, cominciando col togliere tutte le incrostazioni abusive che ci abbiamo appiccicato sopra. L’immagine cui leghiamo la nostra fede e la nostra pietà si è coperta della patina grigia dell’abitudine, che ha tolto splendore, bellezza, fascino a quel volto. La distrazione, la sbadataggine, le ipocrisie, l’hanno reso scolorito, privo di espressività. Rinnoviamo il mobilio di casa, la cucina, le stoviglie, le varie suppellettili, gli arredamenti dell’ufficio. E non ci preoccupiamo di quell’immagine sbiadita, polverosa, sempre la stessa, priva di vita, appiattita, spenta, insulsa o addirittura ripugnante. (…) Maria aiutaci a scoprire il volto intriso di luce del Dio che ci guarda con simpatia e benevolenza., ci è favorevole, ci manifesta protezione, ci invita al gioco. Maria, facci scoprire che Dio sta “voltato” dalla nostra parte. Non è minaccioso ma ci comunica pace, serenità, tranquillità. Non ci incute terrore, ma al contrario ci vuole liberi dalla paura. Maria, Dio ha giocato con te quando ti ha scelta, oscura ragazza di un oscuro villaggio mai nominato prima nelle Scritture, proponendoti un’avventura inimmaginabile. E tu hai avuto, a tua volta, la fortuna di giocare con Lui, anche se pochi ne parlano. Sì, perché non posso impedirmi di pensare che tu Gli abbi a insegnato anche a giocare, e abbia giocato più volte con Lui. (…) Vedi, Maria. Le nostre vite assomigliano a quelle giare di pietra che stagliavano nella sala delle nozze a Cana. Pesanti – e tanto più pesanti quanto più vuote -, rigide, immobili, impassibili, inappuntabili, come sull’attenti… Tu fai intervenire tuo Figlio. Ed ecco che comincia il gioco, e le anfore non stanno più al loro posto, si muovono, mettono tutto e tutti in movimento, riservano sorprese incredibili: sono state riempite d’acqua e regalano il vino. Non è un gioco di magia. E’ il gioco della vita nuova del cristiano, vigilato non da un arbitro munito di fischietto, col regolamento in mano, ma da un Volto sorridente…
Troppi, lungo la mia strada, mi hanno parlato di Te e delle tue esigenze modulando – si fa per dire – il messaggio a colpi di fischietto. Colpi secchi rabbiosi cattivi. E io avvertivo e avverto ancor oggi, che in quel fischietto sibila un fiato che viene da un fegato guasto, risultato inequivocabile di una cattiva digestione della tua Parola, un’aria gelida, non riscaldata dal cuore, non rigenerata dalla misericordia, non percorsa dalla tua tenerezza. E provo una ripugnanza istintiva a imboccare quella strada irta di divieti e imposizioni, dove la tirannia del codice ha soppiantato il gusto dell’esplorazione e il fascino dell’avventura. Tu sei un Dio che mi fa cantare. Io vorrei danzare, correre per i sentieri, ruzzolare nei prati, scavalcare le siepi, scorticarmi i piedi suoi sassi, appostarmi su un roccione per contemplare il paesaggio, arrampicarmi su un albero come Zaccheo, mettermi ad urlare al tuo passaggio come il cieco Bartimeo… E loro, invece, si accaniscono a mettermi in riga, impormi il silenzio, e farmi procedere a passo di militare, cadenzato, con la divisa inappuntabile, disciplinatamente, come a una parata ( o a un funerale?). Io vorrei cantare a squarciagola. E loro mi ammoniscono che non sta bene. Mi costringono a gargarizzare formule che sanno di cenere. Io vorrei lodarti, inventando parole nuove, fresche, da innamorato. E loro mi cacciano nella strozza pagine ingiallite di vecchi libri carichi di polvere. Perfino quando parlano d’amore, invece di imbastire un canto delicato, si preoccupano prima di tutto ossessivamente di scandirne le “regole” a colpi di fischietto che sembrano altrettanti segnali di allarme (…) sirene spiegate contro la vita e la spontaneità (…). Tu sei il Signore del canto e della danza e lor non si rendono conto che soltanto cantando e danzando lungo la tua difficile strada è possibile staccarsi dalle calcagna il demonio. Tu hai fatto del Venerdì Santo una festa. E loro riescono a trasformare tutte le feste in un cupo Venerdì Santo, senza nemmeno un pallido presagio di Risurrezione. Tu sei un Dio che mi fa danzare Signore, fa’ che i tuoi rappresentanti, quando parlano di Te, non mortifichino la musica e la poesia, non abbiano paura della bellezza, non dimentichino la cetra. E fa’ che sul loro spartito non ci siano le aride norme di un codice, ma il canto gioioso del tuo Vangelo, molto più esigente e impegnativo. Signore, che nessuno mi faccia sentire in colpa se ho voglia di fischiettare, perché Tu mi metti in bocca il sapore della libertà e mi nascondi nel cuore il segreto della follia, e mi fai camminare su per un sentiero aspro verso l’appuntamento segreto del tuo amore. Signore, forse dico un’enormità: ma la tromba del giudizio universale mi fa meno paura del fischietto del tutore dell’ordine (che non è mai l’ordine sognato dalla fantasia del tuo amore…). Signore, mi raccomando, non cessare di pizzicare almeno una corda su una chitarra qualsiasi, di dare un colpo di manovella a un organetto sgangherato, di soffiare una nota in una tromba sfiatata, di picchiare un colpo su un tamburo ammaccato – conosco quel richiamo! – e io, anche se carico di artriti e reumatismi e acciacchi vari, mi precipiterò ancora in strada, come un bambino. E mi lascerò portare ovunque Tu vorrai. All’inferno, no. All’inferno proprio non voglio andarci. … Perché ho troppa paura del fischietto. Tu sei un Dio che mi tiri in faccia una canzone Molti amano raffigurarti con il grosso libro della legge in mano. Altri hanno l’impressione che Tu gli sventoli sempre sotto il naso le pagine di un regolamento. Io preferisco riferirmi allo stupendo canto della vigna (Is 5,1-7), lamento struggente per una vendemmia sfortunata, che diventa simbolo trasparente di un amore tradito. Se non sto troppo a distanza, mi accorgo che quel poema risuona ancor oggi alle mie orecchie, non semplicemente come qualcosa di patetico; so che mi viene gettato in faccia, quale preciso e documentato capo d’imputazione per le mie innumerevoli inadempienze. Sì. tu continui a rinfacciarmi, ossia a scaraventarmi in faccia, una canzone d’amore. Signore, non stancarti di attendere, non smettere di replicare quella canzone. Sarà il tuo canto appassionato, più che le minacce, a farmi prendere coscienza delle mie mancate risposte e a far maturare dentro di me una voglia di fiori e poi, chissà, perfino i frutti. Guai se venisse a cessare quel canto d’amore… Sei riuscita a farlo uscire allo scoperto Maria, permettimi questo sfogo. Non riesco proprio a capacitarmi come mai i teologi, pur abituati ad argomentare su una virgola, non abbiano sfruttato l’episodio di Cana per proporci l’immagine autentica di un Dio della festa, amante della vita e della gioia di vivere.(…) Io ho il sospetto che quando hai fatto notare a Gesù che su quella tavola stava esaurendosi il vino, tu non fossi soltanto preoccupata per quella gente. Pensavi anche a noi. Il tuo intento segreto era quello di far uscire allo scoperto tuo Figlio. E, attraverso di Lui, far emergere il volto nuovo di Dio, che liquidasse definitivamente le vecchie estinte immagini terrificanti di un Dio minaccioso, despota inesorabile, gendarme dell’universo, inquisitore implacabile, che gli uomini si erano fabbricati. Maria, aiutaci tu a “rinnovare” il volto di Dio, cominciando col togliere tutte le incrostazioni abusive che ci abbiamo appiccicato sopra. L’immagine cui leghiamo la nostra fede e la nostra pietà si è coperta della patina grigia dell’abitudine, che ha tolto splendore, bellezza, fascino a quel volto. La distrazione, la sbadataggine, le ipocrisie, l’hanno reso scolorito, privo di espressività. Rinnoviamo il mobilio di casa, la cucina, le stoviglie, le varie suppellettili, gli arredamenti dell’ufficio. E non ci preoccupiamo di quell’immagine sbiadita, polverosa, sempre la stessa, priva di vita, appiattita, spenta, insulsa o addirittura ripugnante. (…) Maria aiutaci a scoprire il volto intriso di luce del Dio che ci guarda con simpatia e benevolenza., ci è favorevole, ci manifesta protezione, ci invita al gioco. Maria, facci scoprire che Dio sta “voltato” dalla nostra parte. Non è minaccioso ma ci comunica pace, serenità, tranquillità. Non ci incute terrore, ma al contrario ci vuole liberi dalla paura. Maria, Dio ha giocato con te quando ti ha scelta, oscura ragazza di un oscuro villaggio mai nominato prima nelle Scritture, proponendoti un’avventura inimmaginabile. E tu hai avuto, a tua volta, la fortuna di giocare con Lui, anche se pochi ne parlano. Sì, perché non posso impedirmi di pensare che tu Gli abbi a insegnato anche a giocare, e abbia giocato più volte con Lui. (…) Vedi, Maria. Le nostre vite assomigliano a quelle giare di pietra che stagliavano nella sala delle nozze a Cana. Pesanti – e tanto più pesanti quanto più vuote -, rigide, immobili, impassibili, inappuntabili, come sull’attenti… Tu fai intervenire tuo Figlio. Ed ecco che comincia il gioco, e le anfore non stanno più al loro posto, si muovono, mettono tutto e tutti in movimento, riservano sorprese incredibili: sono state riempite d’acqua e regalano il vino. Non è un gioco di magia. E’ il gioco della vita nuova del cristiano, vigilato non da un arbitro munito di fischietto, col regolamento in mano, ma da un Volto sorridente…
don Alessandro Pronzato
ennesima tragedia nel Mar Egeo, davanti alle coste della Turchia: un barcone carico di migranti è affondato stamani vicino all’isola greca di Farmakonissi provocando la morte di almeno 11 persone, tra cui 5 bambini. I dispersi sono 13. A bordo dell’imbarcazione, ha detto la Guardia Costiera, c’erano circa 50 persone, 26 sono state salvate.
l’ennesima tragedia all’indomani del naufragio costato la vita a 6 bimbi, tra cui un neonato, morti intorno alle 2.30 dell’8 dicembre. Erano a bordo di un gommone di profughi afghani al largo di Cesme, nella provincia di Smirne, sulla costa egea della Turchia. La Guardia costiera di Ankara ha salvato altre 8 persone
«Continua una strage silenziosa nel Mediterraneo, con i morti che sono più che raddoppiati nel 2015 rispetto al 2014: da 1600 a oltre 3200. Continuano le morti di bambini, dimenticate: oltre 700 dall’inizio dell’anno», denuncia oggi il Direttore Generale della Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego. «L’Europa che trova sempre risorse per bombardare, non trova risorse per salvare vittime innocenti. L’operazione europea Triton non ha saputo rafforzare il salvataggio in mare delle vite umane rispetto all’operazione italiana Mare Nostrum – continua Mons. Perego -: una vergogna che pesa sulla coscienza europea. L’Europa sembra ora – a fronte della minaccia terroristica – giustificare i muri e la chiusura delle frontiere, oltre che il disimpegno nel creare canali umanitari che avrebbero potuto oltre che salvare vite umane, combattere il traffico degli esseri umani, una delle risorse del terrorismo».
«L’accoglienza ai nostri porti, anziché in centri di accoglienza aperti sembra affidarsi ancora una volta a centri chiusi, gli ‘hotspots’, come dimostra il Centro di accoglienza di Lampedusa: più di 20.000 persone arrivate al porto e trasferite nel Centro, chiuso ad ogni ingresso e uscite. La paura insieme alla convenienza sembra far ritornare indietro di anni il cammino di protezione internazionale costruito in Europa». Continua invece l’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale che, dopo l’appello di Papa Francesco del 6 settembre scorso, è cresciuta nelle strutture ecclesiali, nelle parrocchie e nelle famiglie, conclude il direttore della Migrantes realizzando «un’accoglienza diffusa, costruita insieme, senza conflittualità. Un’accoglienza intelligente che aiuta anche a conoscere volti e storie di sofferenza e a costruire, in questo tempo di Avvento, percorsi e progetti di cooperazione internazionale. Ancora una volta la Chiesa costruisce un gesto concreto, che supera pregiudizi e contrapposizioni ideologiche, che accompagna le persone, nella prospettiva di una ‘cultura dell’incontrò che sola rigenera le nostre città».
Istituzioni Ue e Stati «devono correggere le lacune nel funzionamento degli hotspot, incluso stabilire le necessarie capacità ricettive per raggiungere gli obiettivi, e concordare rapidamente un preciso calendario affinché anche altri hotspot diventino operativi»: così la bozza di conclusioni del vertice Ue del 17 e 18 dicembre. «Nonostante il duro lavoro degli ultimi mesi il livello di attuazione di alcune decisioni» per affrontare la crisi migratoria «è insufficiente». «Schengen è sotto seria pressione», si legge. Istituzioni Ue e Stati «devono assicurare le registrazioni» dei migranti ed «adottare misure per scoraggiare il rifiuto» di quelli che non vogliono farsi identificare e sottoporre alla raccolta delle impronte, si legge ancora nella bozza.
da ‘il Messaggero’
non campi di concentramento, ma un generico confino. Al resto, pensavano le pietre polverose delle campagne sarde, la miseria dei paesi: i più ricchi sull’asino, gli altri a piedi. La Sardegna è stata anche terra di deportazione tra il 1938 e il 1940, una manciata d’anni anni alla fine del Fascismo, in cui l’Isola è diventata la meta – obbligata – dei rom dell’Istria. Il vero inizio di una politica di repressione tutta italiana, rimasta per decenni una pagina fumosa, tutta da studiare. Le storie di Rosa Raidich, dei suoi figli tra cui Graziella (Lalla) nata a Perdasdefogu rientrano nel Porrajmos: termine romanesh che significa “divoramento”, di fatto: sterminio.
leggi anche: IL MUSEO VIRTUALE. La memoria del Porrajmos in rete: i documenti, le voci e le ricostruzioni
I rom sinti erano infatti considerati “spie” da Mussolini, al pari degli ebrei: e quindi da isolare e neutralizzare, successivamente anche in veri lager nel Sud Italia (Molise e Abbruzzo) e in Emilia Romagna. Fino alla deportazione negli ultimi anni del regime in Germania e Polonia con l’uccisione di migliaia di uomini, donne, bambini: la stima è di 500mila.
Il lavoro di studio e ricerca di documenti e testimonianze è stato portato avanti dal Centro studi zingari di Roma e da vari giornalisti e storici, tra cui Mirella Karpati. Una rete in parte ricostruita di storie, racconti e vite di passaggio. Dopo il 1945 delle ottanta persone confinate in Sardegna non c’è più traccia: sono tutte tornate nel continente, a caccia dei loro parenti che spesso non troveranno. Anche se è probabile che – in parte – alcuni siano rimasti. Ne è convinto Luca Bravi, dell’Università di Chieti, uno dei ricercatori che si è occupato dei rom in Sardegna. Autore, insieme a Matteo Bassoli, del “Porrajamos in Italia. La persecuzione di rom e sinti durante il fascismo”. Se ne è parlato in uno dei tanti appuntamenti della tre giornate del convegno organizzato dalla Caritas a Cagliari dal titolo “Da Zingaro a cittadino”.
L’ordine al confino, scritto, è stato dato nel 1941: una circolare arrivata dal ministro degli Interni, firmata dal capo della polizia Arturo Bocchini. Si ordinava: «gli zingari di nazionalità italiana certa aut presunta ancora in circolazione vengano rastrellati nel più breve tempo possibile et concentrati sotto rigorosa vigilanza in località meglio adatte a ciascuna provincia». Prima ancora c’era stato un rigido e dettagliato censimento. Poi, l’ordine delle partenze: fino a Civitavecchia, poi la nave. Ottanta persone sparpagliate in paesi minuscoli: nel Nuorese e nel Sassarese. A Lula, Perdasdefogu passaggi certi che si ritrovati anche nei documenti dell’Archivio di Nuoro e di Pasino, in provincia di Pola. Ma i movimenti verso l’Isola erano iniziati già prima, nel 1938: un’altra donna, Angela Levacovich: nessun reato a suo carico, solo l’essere rom. E così è arriva a Lula, poi spostata a Perdas. I cognomi sono soprattutto slavi: Levacovich, Poropat, Raidich, Stepich, Carri. Ma secondo gli studiosi non erano gli unici presenti in Istria in quegli anni. Le altre famiglie in quanto “zingari autoctoni nazionali” non subirono il confino, almeno fino al 1940, quando la persecuzione arrivò anche per i rom italiani.
Sulla nave per la Sardegna salirono anche molti bambini: anche se a conti fatti il viaggio per il confino sarebbe stato più costoso rispetto all’affidamento all’Opera maternità e infanzia. All’arrivo lo smistamento a chilometri e chilometri di distanza: una o massimo due famiglie per paese, in alcuni casi anche donne sole. Una a Urzulei, una a Bortigali e così via: Ovodda, Talana, Loceri, Nurri, Posada, Padria, Martis, Chiaromonti e Illorai.
Della loro vita di tutti i giorni poche tracce scritte, nei racconti di chi riesce a tornare in Istria soprattutto la fame nera, gli stenti vissuti nella miseria sarda. Condizioni condivise e familiari con gli abitanti: “C’era una fame terribile – racconta Rosa Raidich – Un giorno, non so come, una gallina si è infilata nel campo. Mi sono gettata sopra come una volpe, l’ho ammazzata e mangiata dalla fame che avevo. Mi hanno picchiata e mi sono presa sei mesi di galera per furto”.
Partono tutti di nuovo verso il continente solo dopo il 1945, quando la guerra è di fatto finita e si smantellano pure i lager tedeschi. “Non esistono più testimoni diretti del confino, ma è di fatto un racconto corale e vivo nella tradizione orale delle famiglie rom”, spiega il ricercatore Bravi. I documenti scritti portano anche a una bimba rom, nata proprio a Perdasdefogu: Graziella detta Lalla, figlia di Rosa Raidich. Ed è un’eccezione quasi nazionale, perché di fatto venivano evitate le registrazioni. È la stessa Rosa Raidich a darne testimonianza: “Mia figlia Lalla è nata in Sardegna a Perdasdefogu il 7 gennaio 1943, eravamo lì in un campo di concentramento”. Nessun lager è stato, poi, accertato. Anche se non si esclude – spiega Bravi: “che esistessero zone recintate”, o aree in cui i confinati rom non potessero attraversare sempre “per motivi di sicurezza”.
Eppure Lalla di Perdas ebbe anche una madrina per il battesimo, come racconta Giacomo Mameli, in un articolo sui rom di Foghesu. Tra la miseria di quegli anni e qualche pezzo di pane diviso le donne spiccavano rispetto ai paesani: sapevano anche leggere e scrivere. Come dimostrano i documenti e le stesse lettere inviate dalla Raidich alle autorità: scrittura sghimbescia ma ferma soprattutto nelle intenzioni. Negli anni di confino scrive per reclamare l’indennizzo previsto per gli internati dal regime: “Ma che – spiega Bravi – lo Stato non corrispondeva praticamente a nessuno”. E ancora, ormai dopo molti anni dal ritorno nella penisola chiede i documenti di quella figlia nata a Perdas. E di cui, a dispetto di tutti, è rimasto segno nelle carte, del Comune e pure della parrocchia.
Monia Melis
“nel 2015 raddoppiati i migranti morti: 700 sono bambini”
monsignor Gian Carlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes, ha esposto un quadro drammatico: “L’Europa che trova sempre risorse per bombardare, non trova risorse per salvare vittime innocenti
di Davide Falcioni
parla di “strage silenziosa” monsignor Gian Carlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes, nell’esporre i numeri delle tragedie dell’immigrazione, che da mesi ormai si verificano con cadenza quotidiana a largo del Mar Mediterraneo, spesso nel silenzio più totale, nell’indifferenza quando non nell’odio. I morti del 2015 sono più che raddoppiati rispetto al 2014, passando da 1.600 a 3.200 e dimostrando che la commozione all’indomani della strage di Lampedusa non ha sortito, purtroppo, azioni positive. Impressionante il dato riguardante i bambini: in 700 hanno perso la vita in mare dall’inizio dell’anno.
Il direttore della Fondazione Migrantes attacca il Vecchio Continente: “L’Europa che trova sempre risorse per bombardare, non trova risorse per salvare vittime innocenti. L’operazione Triton non ha saputo rafforzare il salvataggio in mare delle vite umane rispetto all’operazione italiana Mare Nostrum: una vergogna che pesa sulla coscienza europea. L’Europa sembra ora – a fronte della minaccia terroristica – giustificare i muri e la chiusura delle frontiere, oltre che il disimpegno nel creare canali umanitari che avrebbero potuto oltre che salvare vite umane, combattere il traffico degli esseri umani, una delle risorse del terrorismo”.
La situazione, insomma, sembra peggiorare di giorno in giorno, con il dramma che i naufragi sembrano essere anche spariti dalle prime pagine dei giornali, relegati tra le notizie “varie ed eventuali”. Ciò, inevitabilmente, non ha contribuito a al miglioramento delle condizioni di accoglienza che, insiste Pelago, “sembra affidarsi ancora una volta a centri chiusi, gli ‘hotspots’, come dimostra il Centro di accoglienza di Lampedusa: più di 20mila persone arrivate al porto e trasferite nel Centro, chiuso ad ogni ingresso e uscite. La paura insieme alla convenienza sembra far ritornare indietro di anni il cammino di protezione internazionale costruito in Europa”.
Ai numeri forniti dalla Fondazione Migrantes si aggiungono quelli dell’Unicef: secondo il “Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia” da gennaio 2015 876mila persone hanno raggiunto le coste europee, con una percentuale di donne e bambini in continua ascesa da qualche mese a questa parte: se a giugno rappresentavano il 27% degli arrivi a novembre la quota è salita al 52%: un profugo su due ormai è un minore o una donna. Ne consegue che anche il numero di vittime sale: solo a ottobre 90 bimbi sono deceduti nel Mare Egeo, il 20% dei quali aveva meno di 2 anni. Una situazione drammatica che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane e mesi, con l’arrivo dell’inverno. Marie-Pierre Poirier, Coordinatore speciale UNICEF per la crisi dei Rifugiati e dei Migranti in Europa, ha dichiarato: “Finora l’inverno in Europa è stato relativamente mite, ma ora la stagione sta cambiando. La nostra più grande preoccupazione è che il clima invernale e le imprevedibili restrizioni alle frontiere lascino migliaia di bambini in un limbo, esposti al rischio di naufragi e di gravi malattie respiratorie. Purtroppo c’è carenza di abiti pesanti, sciarpe e calzini da bambino. I bambini migranti e rifugiati hanno sperimentato guerra, privazioni e disagi di ogni genere. Ora hanno bisogno di stabilità, protezione e assistenza”. Per questo, nel tentativo di fronteggiare l’emergenza, l’Unicef ha predisposto nei luoghi di sbarco punti di assistenza specializzati, incapaci però per il momento di fronteggiare le richieste di tutti: occorrerebbero 14 milioni di dollari per garantire continuità alle attività di assistenza ai bambini migranti e rifugiati, ma al momento la comunità internazionale ne ha sborsati solo 3. Parliamo di numeri insignificanti rispetto ai bilanci degli stati.
Milite sposa Gemma Capra nel 1984 facendo da padre ai figli del commissario ucciso. È stato l’inventore della bandiera Arcobaleno, divenuto simbolo del movimento pacifista.

mettere sotto accusa i due cronisti Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi contraddice la volontà di trasparenza sempre sbandierata da papa Francesco
Ma al tempo stesso, nel corso di questa trasferta, ha ricordato al mondo le ragioni dell’amore e fascino che fin dal giorno della sua elezione ha suscitato in laici e fedeli. Ossia ha scandito, davanti a telecamere e giornalisti, parole forti a favore delle madri delle bidonville, quelle che «lottano eroicamente per proteggere figli e figlie dai pericoli nel contesto di indifferenza e ostilità». Si è anche soffermato, con paterna cura, sull’identità dell’uomo e del senso della sua esistenza, suggellato dal «sacro diritto alla terra, alla casa e al lavoro». Fino a toccare, in questo flusso di empatia trans-nazionale e trans-confessionale, il tema cardine tra le mura vaticane: cioè la necessità di arginare i «casi di corruzione», che penetrano nelle segrete stanze come «lo zucchero» che «è dolce, ci piace, è facile».
Impossibile dissentire da questa interpretazione delle distrazioni molto umane e curiali. Ma anche impossibile sfuggire al confronto, in queste settimane, con la grammatica giudiziaria del processo, dove il rinascimento post moderno della comunicazione voluto da Francesco, e del consenso cercato dal Santo Padre nella società civile, sbatte contro l’estromissione di taccuini e telecamere dall’aula di giustizia. Il più infernale dei cortocircuiti, dal momento in cui alla sbarra – oltre a monsignor Lucio Vallejo Balda, Nicola Maio e Francesca Chaouqui – siedono due esponenti della stampa libera come Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi; e la situazione diventa ancora più contorta, sotto il profilo della linearità tra parole e fatti, dato che l’accusa in campo (la diffusione di notizie e documenti riservati) esiste sì Oltretevere con l’articolo fresco d’inchiostro 116 bis, ma non nel codice penale italiano. Il che avrebbe dovuto suggerire alla Santa Sede, nel dialogo emotivo tra differenti Stati e coscienze, la costruzione di una liturgia giudiziaria che sposasse i diktat vaticani – comunque leciti in quel perimetro – a una costante documentazione mediatica dei passaggi processuali.
L’esatto opposto, nei fatti, di quello che è già diventato il caso VatiLeaks 2. Cioè una drastica conferma di come l’azione contro Fittipaldi e Nuzzi, in particolare, odori di censura e paura (di spalancare tutte le altre porte, oltre a quella Santa).
Niente a che vedere con la postura che papa Francesco ha assunto in pubblico verso i più tormentati snodi sociali (basti ricordare il suo rivoluzionario «Chi sono io, per giudicare?» in tema di omosessualità) e niente di compatibile con il dicembre 2014, quando rivolto alla Curia romana nominò una dopo l’altra le malattie da sanare con urgenza: partendo da quella della «rivalità e vanagloria» per arrivare a quella «del profitto mondano».
Qual è la Chiesa, è a questo punto lecito chiedere, che il Santo Padre lotta per affermare? È quella scandita da esternazioni costanti sui grandi mali dell’uomo e del mondo contemporaneo (tra i quali appunto il «profitto mondano» al centro dei libri-inchiesta di Fittipaldi e Nuzzi) ma pronta subito a rinculare quando la disinvoltura etica e morale si sposta dalla teoria alla pratica (dentro le mura del Vaticano, s’intende, e tra le persone di fiducia del papa), oppure il sommo pastore e la sua nuova chiesa vogliono davvero cancellare anni e anzi secoli di opacità e collusioni con figure e pensieri impuri? Non sposta affatto l’approccio, l’esternazione di Francesco sul volo di ritorno dall’Africa riguardo alla «libertà di difesa» che spetta agli imputati di VatiLeaks 2. Lo stop medievale alla stampa e al suo lavoro di testimonianza al processo, non soltanto fa temere per la prima opzione, ma spinge pure a invocare da parte del Santo Padre – con tutto il rispetto possibile – il suo impegno sulla strada che più fa proseliti: quella della coerenza. Ideale, tra parentesi, per evitare il valzer dei veleni figlio dei regimi censori.
di Raniero La Valle
il papa va a Bangui ad aprire l’anno santo della misericordia e siccome le grandi idee hanno bisogno di simboli concreti il papa, per significare l’ingresso in questo anno di misericordia, aprirà una porta. Ma per lo stupore di tutte le generazioni che si sono succedute dal giubileo di Bonifacio VIII ad oggi, la porta che aprirà non sarà la porta “santa” della basilica di san Pietro, ma la porta della cattedrale di Bangui, il posto, ai nostri appannati occhi occidentali, più povero, più derelitto e più pericoloso della terra.
ma si tratta non solo di cominciare un anno di misericordia. Che ce ne facciamo di un anno solo in cui ritorni la pietà? Quello che il papa vuol fare, da quando ha messo piede sulla soglia di Pietro, è di aprire un’età della misericordia, cioè di prendere atto che un’epoca è finita e un’altra deve cominciare
Perché, come accadde dopo l’altra guerra mondiale e la Shoà, e Hiroshima e Nagasaki, abbiamo toccato con mano che senza misericordia il mondo non può continuare, anzi, come ha detto in termini laici papa Francesco all’assemblea generale dell’ONU, è compromesso “il diritto all’esistenza della stessa natura umana”. Il diritto!
Di fronte alla gravità di questo compito, si vede tutta la futilità di quelli che dicono che, per via del terrorismo, il papa dovrebbe rinunziare ad andare in Africa (“dove sono i leoni” come dicevano senza curarsi di riconoscere alcun altra identità le antiche carte geografiche europee) e addirittura dovrebbe revocare l’indizione del giubileo, per non dare altri grattacapi al povero Alfano.
Ma il papa, che ha come compito peculiare del suo ministero evangelico di “aprire la vista ai ciechi”, ci ha spiegato che il vero mostro che ci sfida, che è “maledetto”, non è il terrorismo, ma è la guerra. Il terrorismo è il figlio della guerra e non se ne può venire a capo finché la guerra non sia soppressa. La guerra si fa con le bombe, il terrorismo con le cinture esplosive. Non c’è più proporzione, c’è una totale asimmetria, le portaerei e i droni non possono farci niente. Possiamo nei bla bla televisivi o governativi fare affidamento sull’”intelligence”, ma si è già visto che è una bella illusione.
Questo vuol dire che per battere il terrorismo occorre di nuovo ripudiare quella guerra di cui, dal primo conflitto del Golfo in poi, l’Occidente si è riappropriato mettendola al servizio della sua idea del mercato globale, e che da allora ha provocato tormenti senza fine, ha distrutto popoli e ordinamenti, suscitato torture e vendette, inventato fondamentalismi e trasformato atei e non credenti in terroristi di Dio.
E che cosa è rimasto di tutte queste guerre?, ha chiesto il papa nella sua omelia del 19 novembre, la prima dopo le stragi di Parigi. Sono rimaste “rovine, migliaia di bambini senza educazione, tanti morti innocenti: tanti! E tanti soldi nelle tasche dei trafficanti di armi”; ed è rimasto che perfino le luci, le feste, gli alberi luminosi, anche i presepi del Natale che ci apprestiamo a celebrare, sarà “tutto truccato”.
E’ rimasto il grande movente della guerra e l’inesauribile riserva del terrorismo: il commercio delle armi, sia per incrementare le ricchezze private che per migliorare un po’ i bilanci pubblici. “Facciamo armi, così l’economia si bilancia un po’ – ha ironizzato papa Francesco – e andiamo avanti con il nostro interesse”.
Rendiamo le armi beni illegittimi se non per le legittime esigenze di difesa di Stati sovrani, disarmiamo il dominio, l’oppressione, l’ingiustizia, l’ineguaglianza, la discriminazione e finiranno non solo le guerre ma finirà anche il mondo di guerra “questo mondo che non è un operatore di pace”, e così anche il terrorismo si inaridirà e diverrà sempre più residuale.
E se decideremo di smetterla con i bombardamenti e la guerra, potremo promuovere una vera operazione di polizia internazionale, non solo autorizzata, ma eseguita dall’ONU, e non sotto un comando nazionale, per ristabilire il diritto nelle terre devastate dall’ISIS e dunque ripristinare l’integrità territoriale dell’Iraq e della Siria, lasciando ai siriani di decidere cosa fare con Assad. Il papa aveva detto, già dopo Charlie Hebdo, tornando dalla Corea del Sud, che “l’aggressore ingiusto ha il diritto di essere fermato, perché non faccia del male”. Non è solo nostro dovere è suo diritto; e anche i giovani estremisti che vengono reclutati per andare in Siria a indottrinarsi e poi tornare in Europa a suicidarsi hanno il diritto di essere salvati da noi e di non avere alcuna Siria in cui andare a buttare la vita. Questo è ciò che richiede il diritto internazionale se finalmente si darà attuazione al capitolo VII della Carta dell’ONU, ed è la cosa più “nonviolenta” che si può fare per neutralizzare e battere l’ISIS.
Raniero La Valle