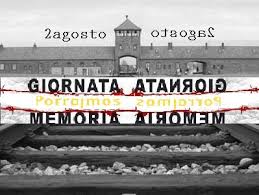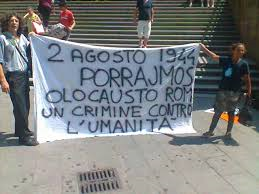“Fratelli e sorelle carissimi, già da qualche anno al territorio delle nostre due diocesi, come del resto a tutto il nostro Paese, è chiesto di offrire accoglienza ad un certo numero di “migranti forzati”, tra i quali vi sono richiedenti asilo, rifugiati e migranti economici. Ad oggi, in provincia di Treviso, sono presenti circa 900 migranti, arrivati sia nel 2014 che nel 2015: in media 10 persone per comune, uno ogni mille abitanti. Recentemente l’arrivo di migranti ha dato luogo a qualche episodio di particolare tensione sociale, anche a causa di scelte improvvide per la loro sistemazione”.
Comincia così una lettera dei Vescovi di Treviso e di Vittorio Veneto, monsignor Gianfranco Agostino Gardin e monsignor Corrado Pizziolo, “ai cristiani e agli uomini e donne di buona volontà delle loro diocesi” pubblicata nei due settimanali diocesani in uscita. I due Vescovi sulla “Vita del popolo” e su “L’Azione” spiegano di aver voluto attendere “che si attenuasse un certo clima surriscaldato” dopo i recenti episodi, desiderando “offrire ai cristiani, e a quanti credono nel valore della solidarietà, alcune considerazioni pacate e, soprattutto, ispirate a ciò che orienta la vita dei credenti”.
Dopo aver ricordato che il fenomeno migratorio ha radici complesse e domanda soluzioni impegnative, i Pastori rilevano come a livello nazionale ed europeo la gestione dei flussi appaia non sufficientemente pensata e organizzata. Nel territorio, però, “a livello di responsabili regionali e comunali si mescolano, alla oggettiva difficoltà di far fronte a richieste improvvisate di accoglienza, alcune componenti ideologiche; queste sembrano impedire di cogliere la dimensione drammatica di tante situazioni umane”.
“Come Chiesa noi vogliamo essere attenti osservatori della realtà, non condizionati da letture preconcette e frettolose di quanto sta avvenendo; e vogliamo cogliere soprattutto il “costo umano”, per chi arriva e per chi accoglie, di questi eventi. Desideriamo – spiegano i Vescovi -, nei limiti delle nostre possibilità, aiutare a dare risposte che partano dalla considerazione della dignità e della situazione drammatica di tante persone. Vorremmo che preclusioni di principio, atteggiamenti di parte dettati dall’appartenenza politica, come pure l’accento posto solo sul “disturbo” che queste persone ci arrecano, non ci togliessero la libertà interiore di pensare e agire secondo alcuni criteri irrinunciabili per i cristiani”.
A partire dal rispetto per la realtà, che significa anzitutto “riconoscere che queste persone fuggono dalle loro terre a causa di situazioni drammatiche e invivibili, spesso ben più insostenibili di quelle che hanno spinto nel passato tanti nostri conterranei ad emigrare in altri Paesi”.
“Che cosa viene chiesto a noi cristiani? La nostra terra, che si connota nell’opinione comune come regione dal cattolicesimo ben radicato, viene dipinta in questi giorni come terra di inospitalità, di durezza, di egoismo. Vorremmo proprio che non fosse così. Una certa integrazione con molti immigrati fa ormai parte della nostra storia recente” scrivono i Vescovi, ringraziando di cuore chi si prodiga con generosità e dedizione verso questi fratelli disperati.
“Come comunità cristiane non dobbiamo rinunciare a fare la nostra parte – sottolineano Gardin e Pizziolo -, per quello che possiamo, senza rifugiarci dietro la vastità del fenomeno e la sua infelice gestione “a livello alto”. Abbiamo cercato strutture, mezzi, persone; invitiamo al dialogo, alla ricerca comune di soluzioni, alla solidarietà. Del resto ci sentiamo interpellati da domande non eludibili. Sono le domande che risuonano nella Bibbia: «Dov’è Abele, tuo fratello?» (Genesi 4,9); «chi è mio prossimo?» (Luca 10,29); «A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere?» (Lett. di Giacomo 2,14)”.
“Sentiamo emergere più che mai l’interrogativo su che cosa significa, in queste precise circostanze, essere cristiani. Lo siamo davvero? Lo siamo oggi di fronte a questi “scarti” dell’umanità? Lo siamo nella maniera che ci è richiesta dal Vangelo o secondo un cristianesimo accomodante che ci siamo rimodellati sulle nostre ideologie o sulle nostre chiusure? Forse questo è il momento di verificare se abbiamo “il coraggio del Vangelo”, se l’essere discepoli di Gesù è un’esperienza che solo ci sfiora o che realmente ci penetra” spiegano i Vescovi, che si dicono “sconcertati di fronte alla deformazione di un cristianesimo professato a gran voce, e magari “difeso” con decisione nelle sue tradizioni e nei suoi simboli, ma svuotato dell’attenzione ai poveri, agli ultimi: dunque svuotato del Vangelo, dunque svuotato di Cristo. I poveri, ci ripete papa Francesco, sono «la carne sofferente di Cristo»”.
“Non vogliamo credere che l’accoglienza e l’integrazione, per quanto impegnative, siano del tutto impossibili – scrivono ancora i due Pastori -. Esse chiedono però il coinvolgimento di tutti: istituzioni, amministrazioni locali, privato sociale, associazioni, e certamente anche le comunità cristiane. Vorremmo che si potessero perseguire scelte che nascano, nello stesso tempo, dall’intelligenza e dal cuore; vorremmo che si mettesse in atto una progettualità che preveda una accoglienza diffusa nel territorio. Del resto le nostre diocesi, attraverso la Caritas ed in collaborazione con altre realtà del privato sociale, stanno sperimentando questo modello, il quale sta offrendo buoni risultati e mostra una sua efficacia. E se proprio ci ritroviamo a constatare la precarietà delle nostre risposte a questa drammatica emergenza, non rifugiamoci nell’indifferenza, non rispondiamo come Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Genesi 4,9). Almeno lasciamo spazio alla tristezza per non riuscire a fare quanto vorremmo, almeno solidarizziamo con l’amarezza di chi sperimenta il rifiuto di essere accolto, almeno piangiamo. Nell’omelia della Messa di Lampedusa, papa Francesco ha chiesto cinque volte: «Chi di noi ha pianto»?”.
E concludono: “Il Signore ci renda “credenti credibili”, uomini e donne di solidarietà di pace, costruttori di un’umanità nuova”.
IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA