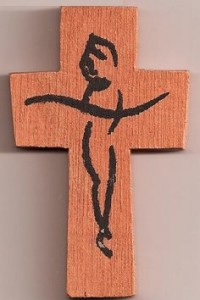Raniero La Valle e la chiesa italiana odierna
papa Francesco rappresenta una radicale e feconda novità anche per la chiesa italiana che il papa vorrebbe meno burocratica, meno separata dalla vita del mondo soprattutto nei suoi pastori, più capace di condivisione e misericordia verso i più marginali … ma non sembra a R. La Valle che essa si muova convintamente in tal senso, tranne delle poche e apprezzabili eccezioni
quella che segue è un’analisi realisticamente triste della realtà ecclesiale italiana rappresentata dai suoi vescovi che sembrano sottovalutare molto l’invito papale a diffondere capillarmente il ‘questionario’ per il sinodo straordinario sulla famiglia e a trasformarlo in un’opportunità di grande dialogo e partecipazione del popolo di Dio:
SE LA CHIESA RISPONDE
Era stato mons. Lorenzo Baldisseri, di fresco nominato segretario del Sinodo dei vescovi, a rompere gli indugi e gli autismi curiali e a direurbi et orbi che tutti potevano liberamente mandare testi di riflessioni e suggerimenti al Sinodo straordinario sulla famiglia, anche senza passare attraverso il canale canonico dei vescovi. Ora quel monsignore è stato fatto cardinale, segno che non ha preso una cantonata, che il papa è d’accordo con lui e che a dare la parola alla Chiesa non si è redarguiti ma si è promossi.
Del resto c’è una coerenza: che senso avrebbe l’insistenza di papa Francesco sulle periferie, se il rapporto della Chiesa con le periferie fosse un rapporto discendente, paternalistico, di una Chiesa che scende dalle pedane e dai pulpiti per andare a ispezionare le periferie, e non invece un rapporto per cui la Chiesa riconosce tutta se stessa come periferia, e ascolta, e perciò dà la parola, alle periferie?
Il riconoscimento delle Comunità di base
Negli stessi giorni in cui le periferie erano chiamate a dire la loro sulla pastorale (ma anche sulla teologia) delle famiglie, il papa mandava un messaggio alle Comunità di base del Brasile riunite per il loro XIII incontro interecclesiale nello Stato del Cearà, richiamando la legittimazione data a tali Comunità dall’assemblea episcopale di Aparecida e riproponendo loro il dovere della evangelizzazione; e siccome questo è il “dovere di tutta la Chiesa e di tutto il popolo di Dio”, per il papa ciò equivaleva a dire che le Comunità di base, a differenza di ciò che si è ritenuto altrove, sono parte integrante e legittima della Chiesa.
Dunque questa è una Chiesa in movimento, cui la riforma in corso del papato sta dando nuova vita; farà pure degli errori, ma questo è il prezzo di ogni riforma, tanto che il papa ha detto ai giovani in Brasile di fare confusione, chiasso, “casino”, e nella “Evangelii Gaudium” ha scritto di preferire “una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per le chiusure e le comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”.
Così incoraggiate, molte Comunità di base, associazioni ecclesiale, scuole di ricerca, aggregazioni spontanee hanno preso carta e penna e hanno scritto a Roma per rispondere a tutte o ad alcune delle 38 domande di cui consisteva il questionario messo in rete dalla segreteria del Sinodo. Molte risposte sono state severe, perché hanno criticato le domande stesse, che spesso della domanda avevano solo la veste retorica, ed in realtà erano tradizionalissimi enunciati sul matrimonio e la famiglia. Altre risposte sono state costruttive; ma in ogni caso della natura e della quantità dei documenti venuti direttamente dalla base si potrà sapere solo in seguito, quando qualcuno ne farà la ricognizione.
Molto cammino ancora da fare
Quello che invece si può rilevare fin da ora è che la Chiesa italiana, nelle sue strutture diocesane, ha accusato una difficoltà nel dare riscontro all’iniziativa del Sinodo. Non sembra che essa si sia messa in movimento, che abbia sollecitato interventi, veicolato proposte, si sia fatta eco di sofferenze e preghiere dei fedeli; si sconta ora il fatto che da cinquant’anni ormai, uscita in stato confusionale dal Concilio, la Chiesa italiana abbia imposto il silenzio ai fedeli e si sia fatta silenzio essa stessa, fino ai livelli di vertice della conferenza episcopale, priva com’è stata di ogni altra parola che non fosse quella del suo presidente.
Così la Chiesa italiana è giunta a questo appuntamento in stato di torpore, non si è fatta scuotere dalla novità di un organismo sinodale che prima di impartire direttive e insegnamenti chiedeva informazioni, pareri e proposte; essa non sembra essere uscita, almeno questa volta, dalle “abitudini – come dice il papa – in cui ci sentiamo tranquilli”.
Ma è solo la Chiesa italiana? Vedremo. Quello che intanto già si può dire è che la difficoltà a rispondere alla sollecitazione romana di una consultazione estesa a tutto il popolo di Dio, rivela un problema che non è solo di qualche comparto ecclesiale, ma è di tutta la Chiesa. Essa non è pronta a questo passo. Non è pronta a pensarsi veramente come popolo di Dio, né del resto le era necessario finché il Concilio, che ne aveva posto le premesse teologiche, era rimasto inattuato nelle sue conseguenze istituzionali e pastorali. Di fatto era rimasta vigente nella Chiesa romana la teologia del laicato, inteso come un esercito di riserva della gerarchia, anche se ormai in disarmo e pressoché inutilizzabile, come avevano dimostrato i velleitari tentativi politici alla “Todi 1” e “Todi 2”; era rimasta l’idea che l’unico vero apostolato fosse quello dei vescovi, a cui laici selezionati erano cooptati a collaborare; era rimasta l’idea dei “duo genera christianorum”, giustapposti così che il ministero dei fedeli e quello dei chierici “differiscano essenzialmente e non solo di grado”; era rimasta l’idea che l’unica successione dall’evento fondatore della Chiesa fosse la successione apostolica e non anche la successione nella fede dell’universalità dei discepoli e del mondo più prossimo a Gesù; né erano state tratte tutte le conseguenze dall’aver identificato la Chiesa con la nuova figura o immagine di “popolo di Dio”, che è una figura antropologica ulteriore e dirompente rispetto alla figura biblica di popolo di Dio riservata al popolo d’Israele. E la prima conseguenza di questo mutamento di paradigma rispetto alle immagini bibliche più tradizionali come quelle di gregge, di ovile, di tempio, di edificio di Dio, è quella per cui essere un popolo significa avere la parola, e godere dei diritti innati – ossia di origine divina – alla libertà e all’eguaglianza nel pluralismo di una comunità universale.
Che significa essere “popolo di Dio”
Non può essere infatti senza conseguenze che, nell’intento di rappresentare la fede e la Chiesa nel linguaggio e nelle forme del pensiero moderno “nel modo che la nostra età esige”, secondo quello che era il compito del Concilio, esso abbia privilegiato l’immagine del popolo di Dio rispetto a quella, finora dominante, del gregge. E’ chiaro che nel linguaggio dell’allegoria, che è uno dei sensi dell’interpretazione delle Scritture, le caratteristiche a cui allude l’immagine del popolo sono ben diverse da quelle cui allude l’immagine del gregge (che ha fiuto, ma non ha la parola, non ha l’autodeterminazione, non ha la libertà). Ed è molto interessante che nella Costituzione dogmatica del Concilio, il passaggio dall’idea del gregge all’idea del popolo è collegata al passaggio da una certa struttura di Chiesa, fondata sull’autorità di un solo capo, a un’altra struttura di Chiesa fondata sull’autorità del collegio apostolico (s’intende, con il suo capo); dice infatti la Lumen Gentium, al n. 22: “Questo collegio (degli apostoli), in quanto composto da molti, esprime la varietà e l’universalità del popolo di Dio; in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l’unità del gregge di Cristo”; dunque la diversità e universalità nel popolo e nella Chiesa sono legate alla sinodalità e collegialità, l’unità e uniformità del gregge sono legate al ruolo preminente di Pietro: e le due cose devono stare insieme.
Sta qui allora il valore dell’operazione avviata con il questionario diffuso per il Sinodo. La Chiesa collegiale, col suo capo, domanda, il popolo, nella sua varietà e universalità, risponde. E non è affatto detto che allargandosi l’interlocuzione non ci siano da aspettarsi delle sorprese. Ci sono delle risposte che hanno cambiato il mondo. A cominciare dalle risposte che si trovano nei vangeli. E’ quando Gesù chiede: “chi dice la gente che io sia?” che viene la professione di fede di Pietro: “Tu sei il Cristo”. E’ quando Gesù chiede ai discepoli di Emmaus che cosa era successo a Gerusalemme, che viene svelato il senso delle Scritture che avevano parlato del messia. È quando Gesù chiede a Marta se crede nella resurrezione, che Marta risponde: “Si, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. È quando Gesù chiede a Tommaso di mettere la mano nelle sue piaghe, che Tommaso risponde: “Mio Signore e mio Dio”; è quando i farisei chiedono al cieco nato di proclamare che Gesù era un peccatore, perché guariva di sabato, che il cieco risponde con una delle più belle professioni di fede che ci sono nei vangeli: “se sia un peccatore non lo so, quello che so è che prima non ci vedevo ed ora ci vedo”. Ed è quando la donna torna in città per raccontare l’incontro con Gesù al pozzo di Giacobbe, che i samaritani andati a loro volta da lui le rispondono: “non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”.
Dunque c’è un ministero della risposta, del rispondere, nella Chiesa, che non è dei letterati, dei sapienti, dei chierici, dei consacrati, ma è dei discepoli, dei semplici testimoni, della gente comune. Nei vangeli, prima che nella predicazione degli apostoli, lo svelamento di Gesù come Signore, come Messia, come figlio di Dio, sta nelle risposte dei discepoli, delle donne, dei mendicanti, degli stranieri.
Ma questo ministero della risposta non si può esercitare se non c’è chi interroghi. Se nessuno chiede niente, non c’è nessuno che risponda. E la Chiesa allora resta muta, è la Chiesa del silenzio.
Per molto tempo nella Chiesa, e per lo meno fino al Concilio, ai discepoli, ai fedeli, nessuno ha chiesto niente; è stata chiesta obbedienza, è stato chiesto di ascoltare, è stato chiesto di partecipare ai sacramenti, alle novene, ai catechismi e di dare l’8 per mille. Ma nessuno finora aveva chiesto che cosa pensano di Dio, del Cristo, dell’uomo, della Chiesa, dell’amore, del matrimonio, nessuno aveva chiesto come pensassero di poter rispondere oggi della speranza che è in loro.
Perciò è una così grande novità che ora queste domande siano state poste. E se la Chiesa non è ancora pronta, l’importante è cominciare; l’importante è far crescere questo ministero del chiedere e del rispondere, perché maturi un nuovo modo di essere Chiesa, e anche un nuovo modo di essere mondo, perché finché si domanda e si risponde c’è dialogo, c’è comunicazione, c’è insegnamento e c’è apprendimento, ci può essere comunione, non c’è il fragore della guerra e il silenzio dei cimiteri.
Raniero La Valle